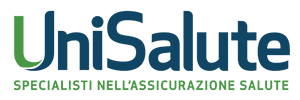Cia Basilicata: incontro a Venosa con i produttori del Vulture
L’agricoltura in generale, partendo dalle eccellenze agricole e agroalimentari del Vulture come la viticoltura, l’olivicoltura, la cerealicoltura, le produzioni orticole degli areali irrigui, deve confermare ed elevare gli standard sul versante della sicurezza alimentare del Made in Italy e, contestualmente, contribuire alla tutela e alla preservazione dell’ambiente e del “capitale natura”, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici che sono la vera nuova frontiera dei prossimi anni.
Questa la conclusione dell’incontro di Cia Basilicata a Venosa, che si inserisce in un più ampio e vasto programma di contatti e di informazione sul territorio lucano per discutere delle prospettive del settore nell’ambito della programmazione comunitaria 2023-2027 e degli impatti nei singoli comparti, in modo che gli agricoltori siano pronti a utilizzare la transizione come momento preparatorio e di strutturazione del sistema aziendale e produttivo.
All’incontro hanno partecipato i responsabili della sede zonale Minutiello e Santoliquido, il presidente Cia Potenza Giambattista Lorusso, il responsabile settore vitivinicolo Cia Antonio Amato, il vicepresidente della Cantina di Venosa Pio Domenico Briscese, il direttore del CAA Cia nazionale Domenico Mastrogiovanni, oltre a una qualificata delegazione di viticoltori dell’areale dell’Aglianico del Vulture. La chiusura dei lavori è stata affidata al coordinatore di Cia Potenza e Matera Donato Distefano.
Il convegno è stato l’occasione per fare il punto sul comparto della vitivinicoltura, sempre più rilevante nell’economia agricola nazionale e internazionale. La Basilicata vanta una superficie viticola censita di poco sopra i 5.000 ettari, conseguenza dell’inversione di tendenza che si registra negli ultimi anni che ha fatto registrare una crescita delle superfici di quasi il 15% dal 2015 e circa 1.700 ettari ristrutturati dal 2000 a oggi. Le aziende con superfici viticole sono poco più di 7.000, i cui ricavi medi per ettari vanno dai 3000 euro per uva comune ai 7.000 euro per le uve a denominazione; di queste solo il 27% è associato o aggregato in forma cooperativistica.
Al centro dell’iniziativa Cia, in previsione della programmazione Pac 2023-27, dell’impiego delle relative risorse pari a 1,1 miliardi di euro annui per i 4 anni e la redazione del piano strategico nazionale per l’agricoltura, c’è l’impegno a:
- sostenere il reddito dei viticoltori. Su questo punto si pensa alla stabilizzazione dei redditi anche per il tramite di forme assicurative che intervengono sia per eventi eccezionali che per crisi di mercato;
- migliorare orientamento al mercato sostenendo l’internazionalizzazione e favorendo la commercializzazione di vini di altissima qualità dal target alto;
- migliorare gli agricoltori nella catena del valore favorendo aggregazione e conferimenti a cantine con contrattualizzazione preventiva;
- favorire produzioni sani, sicuri nutrienti e sostenibili sostenendo verso i consumatori che trattasi di un alimento che ha positive ricadute sul versante salutistico e nutrizionale;
- tutelare la funzione plurima della viticoltura che è produzione di qualità, ma anche biodiversità, ambiente paesaggio agrario oltre che maestria cultura e tradizione.
A questi temi si sono aggiunti quelli attuali e impattanti relativi all’OCM vino, alla fase 2023/27, in particolare ristrutturazioni e riconversioni dei vigneti; riconferma e degli investimenti promozionali sui mercati esteri e Paesi terzi; vendemmia verde; distillazione sottoprodotti.
Nelle conclusioni, il coordinatore di Cia lucana Distefano ha fatto il punto dell’azione messa in campo. “Stiamo procedendo per singolo comparto -ha detto- a valutare portata, impatti e proporre modelli organizzativi al passo con le indicazioni e prescrizioni europee e abbiamo organizzato, nel rispetto delle norme Covid, un fitto programma di divulgazione e confronto, proprio come quella di Venosa, con particolare attenzione anche ai bandi della Regione di prossima emanazione”. Distefano ha richiamato l’urgenza di aprire subito un tavolo permanente di confronto con il Dipartimento su quanto previsto dall’applicazione della futura Pac per pervenire a una posizione utile anche in sede Mipaaf per la definizione del Piano strategico Nazionale per l’agricoltura, che dovrà essere chiuso entro la fine di quest’anno.
“Si tratta -ha sottolineato- di aprire un primo confronto a partire dalle posizioni da assumere verso il Mipaaf sulle misure che riguardano il primo pilastro e gli aiuti diretti, in particolare sulla cosiddetta condizionalità rafforzata che passa dall’applicazione di pratiche agronomiche chiamate eco-schemi e che rappresentano il 25% degli aiuti diretti, che comprendono tematiche quali la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità, la riduzione dei pesticidi e la conservazione delle risorse idriche. Tutto questo rientra organicamente nella proposta e nel progetto di Cia ‘Il Paese che Vogliamo’, con il quale intendiamo fare delle aree rurali e degli areali agrari, dei sistemi produttivi locali organizzati e sostenibili. Obiettivo -ha concluso Distefano- è quello di sfruttare le misure Ue per concretizzare le tre macro transizioni ambientale, digitale e energetica, applicata ai contesti territoriali e all’agricoltura, vogliamo concretizzare tramite le nostre aziende l’economia verde e circolare, inglobare connessioni e innovazioni tecnologiche, facendone anche sostenibilità sociale e coesione territoriale, areali produttivi al cui interno l’agricoltura e lo sviluppo agro-ambientale sia fattore di impresa e di coesione locale, favorendo aggregazione e filiere non solo economiche ma anche territoriali con il protagonismo di tutti gli attori locali che vivono e operano in tali contesti”.