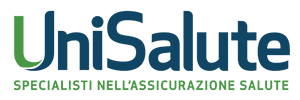18 Novembre 2003
Tutela delle produzioni: interventi compensativi e assicurazioni agevolate
Archivio
Condividi
Pubblichiamo la relazione che Paolo Surace, responsabile dell'Osservatorio economico, ha tenuto al convegno nazionale della Cia svoltosi il 7 novembre scorso a Castellaneta (in provincia di Taranto) sul tema "Tutela delle produzioni: interventi compensativi e assicurazioni agevolate". Nella sua relazione, Surace ha affondato il tema "Nuovi strumenti assicurativi".
Perché è necessario innovare l'offerta assicurativa
Abbiamo un sistema assicurativo in agricoltura ormai inadeguato: limitato nella copertura dei rischi e dei settori, praticamente assente nel settore degli allevamenti.
Le assicurazioni agevolate hanno interessato, in Italia, meno dell'8% della produzione agricola.
Siamo tutti d'accordo su questo giudizio. Onore al merito, ma è necessario innovare. I motivi sono noti.
le avversità atmosferiche costituiscono una costante nell'attività agricola. Nel corso del 2003 sono stati emanati 77 provvedimenti di dichiarazione di eventi calamitosi che hanno colpito 80 province. Di questi, nove hanno interessato le province pugliesi;
l'impresa agricola diviene sempre più complessa. Penso alla legge di orientamento ed alla nuova definizione di impresa: dall'attività di produzione, a quella di trasformazione e vendita dei prodotti, all'agriturismo, alla fornitura di servizi. L'esposizione al rischio si estende, e non si riferisce più solo agli eventi naturali.
l'agricoltore è chiamato a nuove responsabilità verso i consumatori. Mi riferisco alle norme dell'Unione europea che hanno esteso agli agricoltori la responsabilità civile per danni alimentari e le implicazioni dell'impiego di varietà vegetali contenenti ogm (le raccomandazioni della Commissione sulla coesistenza fanno esplicito riferimento alle responsabilità ed alla copertura assicurativa).
La riforma della PAC sposta gli interventi dal sostegno dei prezzi agli aiuti al reddito. L'intervento è stato una vera e propria assicurazione sui prezzi. Oggi gli agricoltori sono molto più esposti alle variazioni dei prezzi ed agli andamenti di mercato. Le oscillazioni, anche vistose, dei prezzi dei prodotti agricoli non sono un'anomalia italiana. La variabilità dei prezzi dei cereali è raddoppiata, in Italia, nel corso degli anni '90 (dopo la riforma), superando quella registrata negli USA.
Un sistema assicurativo che non si rinnova diventa progressivamente più costoso e meno efficiente. Il costo delle polizze, in Italia, si è attestato lo scorso anno mediamente sull'8,1% del valore assicurato (in aumento) con vistose differenze tra i prodotti.
Eppure, se guardiamo agli altri paesi, vediamo un sistema in continua e rapido cambiamento.
Anzi, credo si possa parlare di una vera evoluzione dei sistemi assicurativi che tendono, sempre più, negli altri paesi, a adattarsi alle necessità delle imprese agricole. Se in Spagna, Canada, USA il sistema assicurativo in agricoltura sta entrando nell'età moderna, da noi, senza offesa, siamo in pieno medio evo.
Il quadro degli strumenti assicurativi
Vediamo rapidamente questa evoluzione: dove siamo e dove, invece, a mio avviso, si collocano gli interessi delle nostre imprese.
alla base: le polizze "mono prodotto" ed a "rischio singolo". E' il sistema diffuso in Italia: classico, la polizza grandine. I limiti sono ampliamente noti. Si assicurano solo gli agricoltori delle zone dove sono maggiori i rischi. Questo è un comportamento tradizionale, che però provoca: un innalzamento dei premi assicurativi; la concentrazione del rischio; la tendenza a "scaricare" sull'intero sistema i maggiori costi - rischi delle compagnie. Il caso del tabacco che, nel 2002, per ogni 100 euro di premi pagati ne ha incassati 128, mentre l'uva da tavola ne ha incassati la metà (circa 62).Il difetto maggiore è che non sono presi in considerazione gli effetti congiunti di più eventi: eccessiva piovosità nel periodo delle semine, caldo eccessivo durante la maturazione; piogge persistenti durante la raccolta ecc (è ciò che avvenne nel 2002, soprattutto).
questo difetto è corretto dalle "polizze multirischio" che, appunto, coprono l'effetto congiunto di diversi eventi climatici che hanno diverse probabilità di verificarsi nel corso dell'anno. È il sistema più diffuso in Spagna. Il vantaggio è: maggiore copertura, più vasta platea di assicurati, minori costi. Il limite: una procedura di accertamento ancora complessa. Ogni evento prevede una comunicazione dell'assicurato ed una verifica del danno. Questa complessità (450.000 dichiarazioni di sinistro, 1,7 per ogni polizza) non ha, tuttavia, impedito, in Spagna, una rapidità degli indennizzi (mediamente entro 60 giorni). Il sistema assicurativo spagnolo è considerato, in Europa, uno dei più avanzati. Esso è proposto spesso come modello. Le novità introdotte dal 1980 hanno portato ad una copertura assicurativa del 30% per le produzioni vegetali e del 10% per quelle zootecniche.
Il salto di qualità si ha con l'introduzione delle "polizze multirischio sulle rese". E' una notevole innovazione, dal punto di vista dell'agricoltore, perché parte dall'obiettivo del sistema assicurativo: salvaguardare il reddito.
Da questa premessa, lo schema di funzionamento delle polizze sulle rese può essere esemplificato:
- il reddito lordo (senza considerare i costi di produzione) è dato dalla resa e dal prezzo;
- ogni fenomeno climatico che riduce le rese è un danno per l'agricoltore. Non importa quale avversità atmosferica si sia verificata; importa che si sia avuta una riduzione delle rese, e quindi del reddito;
- di fatto, l'agricoltore si assicura contro un'eccessiva variabilità delle rese. In questo modo, a parità di prezzo di mercato, si ha il massimo livello di garanzia del reddito.
Le polizze sulle rese costituiscono il più diffuso ed efficace strumento assicurativo negli USA e si stanno diffondendo rapidamente in Spagna.
La resa di riferimento presa in considerazione può essere di area o della singola azienda, ma questa diversità, per il mio ragionamento, interessa meno.
Il meccanismo è abbastanza semplice.
Ho una piantagione di mais con una resa media (calcolata su un certo numero di anni) di 10 t/ha. L'agricoltore si può assicurare sul 50, o il 75 o l'85% della resa (secondo le probabilità di rischio). Ovviamente cambia il costo dell'assicurazione ed il contributo pubblico.
L'agricoltore, per esempio, si assicura sul 75%, cioè su una resa di 7,5 t/ha. A causa della cattiva stagione, la resa effettiva è inferiore (per esempio 6 t/ha). L'assicurazione paga un indennizzo pari alla differenza di resa moltiplicato un prezzo di riferimento indicato nella polizza.
Il vantaggio di questo sistema è la semplificazione delle procedure. La valutazione del danno non avviene quando si verifica l'evento climatico, ma alla raccolta. Non vi sono complicate istruttorie; l'agricoltore dichiara la minore resa e la quantifica direttamente. Le erogazioni sono praticamente "automatiche". È la stessa compagnia che procede, a campione, a rigorosi controlli. Soprattutto verifica che la mancata resa non sia per negligenza dell'agricoltore.
Lo svantaggio: è facilmente applicabile per le grandi colture (cereali, semi oleosi ecc.) e su aree omogenee. Esse, inoltre, prendono in considerazione le singole produzioni. Tutto il contrario della nostra agricoltura, dei nostri ordinamenti colturali e del nostro paesaggio agrario. Una delle difficoltà incontrate in questa fase di sperimentazione è proprio la delimitazione delle aree omogenee.
L'assicurazione sulle rese basa la sua forza sulla disponibilità di attendibili banche dati, cioè sulle serie storiche che consentono di calcolare il costo delle polizze
Lo sviluppo delle assicurazioni zootecniche in Spagna, per esempio, è stato favorito sia dal contributo statale, sempre superiore al 40% del costo della polizza, sia, soprattutto, dall'introduzione dell'anagrafe per l'identificazione degli animali.
Il problema è la serie storica delle rese ad ettaro articolate per territorio (aree omogenee). Credo che i piani di regionalizzazione previsti dalla PAC del 1992 non siano sufficientemente attendibili.
Alla fine del 2000. l'Ismea lanciò un progetto di sperimentazione che non mi pare abbia avuto esecuzione.
Per molte nostre produzioni (in particolare gli ortofrutticoli) il valore del prodotto deriva anche dalla qualità, che spesso è caratteristica peculiare delle singole aziende.
Per queste coltivazioni si stanno sperimentando le assicurazione sul reddito. In questo, le agricolture del Canada e degli USA sono all'avanguardia.
Le assicurazioni sul reddito sono state introdotte negli USA dal 1996 ed hanno avuto un notevole successo. Esse interessano il 60% della produzione assicurata di mais e frumento. In seguito sono state estese alle produzioni ortofrutticole. Per fare un esempio, in California, nel 2002, hanno beneficiato di questa copertura assicurativa, il 62% delle superfici coltivate a mele, l'85% a fichi e uva da tavola.
Le assicurazioni sul reddito coprono il risultato complessivo dell'attività produttiva agricola: esse tengono conto della variabilità dei costi e dei ricavi, quindi anche della componente qualità.
I vantaggi sono: la semplicità della procedura, la grande adattabilità alle diverse agricolture.
L'indennizzo copre, integralmente o parzialmente, la differenza tra il reddito effettivo e quello assicurato. Il reddito effettivo è attestato dallo stesso agricoltore tramite i documenti fiscali.
Qui sta lo svantaggio: in assenza di un sistema fiscale trasparente ed affidabile, l'efficacia del sistema è molto scarsa.
Alcune indicazioni: le polizze multirischio e sulle rese
È certamente difficile trovare soluzioni. Non siamo solo di fronte ad obiettive difficoltà. C'è, secondo me, una diffusa resistenza a sperimentare e diffondere soluzioni nuove.
Le compagnie assicurative. Nel 2002 hanno incassato premi per quasi 250 milioni di euro, con un rapporto tra indennizzi e premi del 75%, in linea con gli altri paesi. Nelle regioni del mezzogiorno il rapporto è più basso, a dimostrazione che gli agricoltori assicurati del sud o sono più fortunati (cosa di cui dubito) oppure contribuiscono con le loro polizze a pagare gli indennizzi delle regioni del centro - nord, ed a mantenere il sistema in equilibrio finanziario. E' un settore di attività abbastanza marginale per le compagnie, ma consolidato.
Gli agricoltori. Gli aiuti disaccoppiati, slegati dagli andamenti produttivi e dai prezzi, rappresentano una porzione garantita del reddito aziendale. In taluni casi (penso al grano tenero, ma non solo) coprono quasi interamente i costi di produzione. Di fatto, sono essi stessi un'assicurazione base sul reddito. Possiamo dire che l'aiuto disaccoppiato rappresenta, per le aziende meno orientate al mercato, un'efficace alternativa a qualsiasi tipo di assicurazione privata, seppur sostenuta dal contributo pubblico.
Aggiungo che nel nostro paese il sistema assicurativo in agricoltura è relativamente recente: più antico e consolidato è in paesi come la Spagna e gli Stati Uniti (inizio degli anni '30) o la Francia (inizio secolo) dove, non a caso, si hanno le esperienze più avanzate.
Inoltre, per molti anni in Italia è stato decisamente privilegiato l'intervento di risarcimento dei danni piuttosto che il contributo sulle assicurazioni. Nei dieci anni dal 1988 al 1997, il contributo sulle assicurazioni ha assorbito, in Italia, il 30% della spesa complessiva dello Stato per il fondo di solidarietà; in Spagna la percentuale è stata l'80%; negli USA il 50%.
E' necessario un incentivo forte. Che non è solo la copertura del premio assicurativo, anche se questo è un aspetto non secondario. Nell'Unione europea il contributo pubblico può raggiungere al massimo l'80% del premio (il 50% nel settore zootecnico). In Spagna il contributo pubblico si è attestato, mediamente sul 53% del costo della polizza. Negli USA il contributo pubblico è, mediamente, pari al 75% del premio. Ma l'assicurazione base sulle rese (la copertura è limitata al 50% della resa storica) è completamente a carico dello Stato. L'agricoltore paga, se vuole, una copertura aggiuntiva.
Come recuperare il tempo ma, soprattutto, come costruire una strategia europea.
Vi sono alcuni segnali di una maggiore attenzione al problema.
Nell'Unione europea:
La costituzione di un fondo di solidarietà che interviene, accanto agli Stati, in occasione di grandi catastrofi;
le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Spagna e Grecia con il richiamo alla "necessità di gettare le basi per una strategia comune di gestione del rischio in agricoltura all'interno della PAC". Questo impegno è stato inserito tra le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio agricolo;
in occasione del varo della riforma della PAC (compromesso di Lussemburgo) la Commissione si è impegnata a presentare alcune proposte entro la fine del 2004. L'obiettivo è far partire il sistema europeo di gestione dei rischi in agricoltura dal 2007.
A livello nazionale, ricordo, in particolare, oltre la proposta di riforma della legge 185:
- la previsione delle assicurazioni multirischio;
- l'istituzione della banca dati presso l'Ismea;
- la disciplina dei fondi di mutualità e solidarietà;
- la costituzione presso l'Ismea del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli con riferimento alle polizze multirischio e sulle rese;
- il gruppo di esperti insediato presso l'Ismea per lo studio di forme innovative di assicurazioni in agricoltura.
E' un insieme di strumenti e di norme "propedeutiche" al lancio di una nuova e più moderna offerta assicurativa.
Si tratta, ora, di imprimere una decisa accelerazione al processo avviato. Recuperare i ritardi
La novità è la proposta di inserire il sistema di protezione dai rischi nel quadro della PAC. In altre parole: rafforzare l'intreccio tra intervento pubblico e privato nel sistema assicurativo in agricoltura; finalizzare meglio gli aiuti della PAC.
È un'idea che, secondo me, dovrebbe essere sostenuta con convinzione. Oggi se ne parla ancora poco. Eppure dovrebbe divenire un tema costante nella discussione sulla riforma proprio perché i tempi si intrecciano: nel periodo 2005-2007 andrà a pieno regime la riforma, si discuterà la riforma dei fondi strutturali, nascerà, secondo gli impegni assunti, il sistema europeo di gestione dei rischi.
Alcune ipotesi di lavoro: gli strumenti assicurativi e la PAC
Quali, a mio avviso, i capisaldi:
destinare al finanziamento del sistema una parte delle risorse della PAC;
trasformare una quota degli aiuti al reddito in un contributo sui costi delle polizze;
estendere il contributo a tutti i settori, anche quelli non inclusi nella riforma (per esempio alcuni allevamenti e gli ortofrutticoli).
Non sarebbe una novità in assoluto: il memorandum della Presidenza greca cita alcuni precedenti, le organizzazioni di produttori nei settori del tabacco e dell'ortofrutta.
Perché, secondo me, è un'idea condivisibile:
il contributo sul costo delle polizze assicurative premia gli agricoltori orientati al mercato ed è compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale per il commercio. Sarebbe un modo per risolvere i molti dubbi che ha sollevato la riforma della PAC con il meccanismo degli aiuti disaccoppiati.
Il legame tra aiuti PAC e assicurazioni allargherebbe la platea dei produttori assicurati, con positivi effetti sui costi delle polizze e sull'efficacia del sistema.
Quindi, i punti sui quali si dovrebbe lavorare:
accelerare e favorire l'offerta di polizze multirischio (o combinate, secondo la definizione della Spagna). La banca dati Ismea ed il fondo di riassicurazione contribuiscono a quest'innovazione;
avviare, per taluni prodotti di eccellenza, la sperimentazione di assicurazioni sulle rese. C'è una sorta di timor panico ad affrontare questo tema. Negli USA ed in Spagna queste polizze sono state introdotte dopo un periodo di sperimentazione. Perché non fare tesoro di quelle esperienze?
sperimentare la costituzione di fondi mutualistici di garanzia. Essi, com'è noto, possono essere istituiti dai consorzi di difesa, dalle organizzazioni di produttori o dalle cooperative. Il gruppo di esperti presso l'Ismea sta approfondendo questo tema. Io credo che i fondi mutualistici debbano essere considerati una particolare forma di assicurazione, non necessariamente alternativa a quella tradizionale. Il vantaggio dei fondi è un maggiore controllo sociale. Il fatto che i partecipanti siano tutti membri di una comunità (la cooperativa, per esempio) limita il rischio di comportamenti opportunistici. Lo svantaggio è, tuttavia, la disponibilità di capitali iniziali e, soprattutto, la concentrazione del rischio. In caso di evento, tutti, o quasi tutti i soci subiscono il danno.
In sostanza dobbiamo essere protagonisti nel definire gli orientamenti dell'Unione europea sul tema delle assicurazioni in agricoltura; ma anche attori di un nuovo modello di assicurazioni che ci permetta di giungere preparati ed attrezzati agli appuntamenti comunitari.
Pubblichiamo la relazione che Paolo Surace, responsabile dell'Osservatorio economico, ha tenuto al convegno nazionale della Cia svoltosi il 7 novembre scorso a Castellaneta (in provincia di Taranto) sul tema "Tutela delle produzioni: interventi compensativi e assicurazioni agevolate". Nella sua relazione, Surace ha affondato il tema "Nuovi strumenti assicurativi".
Perché è necessario innovare l'offerta assicurativa
Abbiamo un sistema assicurativo in agricoltura ormai inadeguato: limitato nella copertura dei rischi e dei settori, praticamente assente nel settore degli allevamenti.
Le assicurazioni agevolate hanno interessato, in Italia, meno dell'8% della produzione agricola.
Siamo tutti d'accordo su questo giudizio. Onore al merito, ma è necessario innovare. I motivi sono noti.
le avversità atmosferiche costituiscono una costante nell'attività agricola. Nel corso del 2003 sono stati emanati 77 provvedimenti di dichiarazione di eventi calamitosi che hanno colpito 80 province. Di questi, nove hanno interessato le province pugliesi;
l'impresa agricola diviene sempre più complessa. Penso alla legge di orientamento ed alla nuova definizione di impresa: dall'attività di produzione, a quella di trasformazione e vendita dei prodotti, all'agriturismo, alla fornitura di servizi. L'esposizione al rischio si estende, e non si riferisce più solo agli eventi naturali.
l'agricoltore è chiamato a nuove responsabilità verso i consumatori. Mi riferisco alle norme dell'Unione europea che hanno esteso agli agricoltori la responsabilità civile per danni alimentari e le implicazioni dell'impiego di varietà vegetali contenenti ogm (le raccomandazioni della Commissione sulla coesistenza fanno esplicito riferimento alle responsabilità ed alla copertura assicurativa).
La riforma della PAC sposta gli interventi dal sostegno dei prezzi agli aiuti al reddito. L'intervento è stato una vera e propria assicurazione sui prezzi. Oggi gli agricoltori sono molto più esposti alle variazioni dei prezzi ed agli andamenti di mercato. Le oscillazioni, anche vistose, dei prezzi dei prodotti agricoli non sono un'anomalia italiana. La variabilità dei prezzi dei cereali è raddoppiata, in Italia, nel corso degli anni '90 (dopo la riforma), superando quella registrata negli USA.
Un sistema assicurativo che non si rinnova diventa progressivamente più costoso e meno efficiente. Il costo delle polizze, in Italia, si è attestato lo scorso anno mediamente sull'8,1% del valore assicurato (in aumento) con vistose differenze tra i prodotti.
Eppure, se guardiamo agli altri paesi, vediamo un sistema in continua e rapido cambiamento.
Anzi, credo si possa parlare di una vera evoluzione dei sistemi assicurativi che tendono, sempre più, negli altri paesi, a adattarsi alle necessità delle imprese agricole. Se in Spagna, Canada, USA il sistema assicurativo in agricoltura sta entrando nell'età moderna, da noi, senza offesa, siamo in pieno medio evo.
Il quadro degli strumenti assicurativi
Vediamo rapidamente questa evoluzione: dove siamo e dove, invece, a mio avviso, si collocano gli interessi delle nostre imprese.
alla base: le polizze "mono prodotto" ed a "rischio singolo". E' il sistema diffuso in Italia: classico, la polizza grandine. I limiti sono ampliamente noti. Si assicurano solo gli agricoltori delle zone dove sono maggiori i rischi. Questo è un comportamento tradizionale, che però provoca: un innalzamento dei premi assicurativi; la concentrazione del rischio; la tendenza a "scaricare" sull'intero sistema i maggiori costi - rischi delle compagnie. Il caso del tabacco che, nel 2002, per ogni 100 euro di premi pagati ne ha incassati 128, mentre l'uva da tavola ne ha incassati la metà (circa 62).Il difetto maggiore è che non sono presi in considerazione gli effetti congiunti di più eventi: eccessiva piovosità nel periodo delle semine, caldo eccessivo durante la maturazione; piogge persistenti durante la raccolta ecc (è ciò che avvenne nel 2002, soprattutto).
questo difetto è corretto dalle "polizze multirischio" che, appunto, coprono l'effetto congiunto di diversi eventi climatici che hanno diverse probabilità di verificarsi nel corso dell'anno. È il sistema più diffuso in Spagna. Il vantaggio è: maggiore copertura, più vasta platea di assicurati, minori costi. Il limite: una procedura di accertamento ancora complessa. Ogni evento prevede una comunicazione dell'assicurato ed una verifica del danno. Questa complessità (450.000 dichiarazioni di sinistro, 1,7 per ogni polizza) non ha, tuttavia, impedito, in Spagna, una rapidità degli indennizzi (mediamente entro 60 giorni). Il sistema assicurativo spagnolo è considerato, in Europa, uno dei più avanzati. Esso è proposto spesso come modello. Le novità introdotte dal 1980 hanno portato ad una copertura assicurativa del 30% per le produzioni vegetali e del 10% per quelle zootecniche.
Il salto di qualità si ha con l'introduzione delle "polizze multirischio sulle rese". E' una notevole innovazione, dal punto di vista dell'agricoltore, perché parte dall'obiettivo del sistema assicurativo: salvaguardare il reddito.
Da questa premessa, lo schema di funzionamento delle polizze sulle rese può essere esemplificato:
- il reddito lordo (senza considerare i costi di produzione) è dato dalla resa e dal prezzo;
- ogni fenomeno climatico che riduce le rese è un danno per l'agricoltore. Non importa quale avversità atmosferica si sia verificata; importa che si sia avuta una riduzione delle rese, e quindi del reddito;
- di fatto, l'agricoltore si assicura contro un'eccessiva variabilità delle rese. In questo modo, a parità di prezzo di mercato, si ha il massimo livello di garanzia del reddito.
Le polizze sulle rese costituiscono il più diffuso ed efficace strumento assicurativo negli USA e si stanno diffondendo rapidamente in Spagna.
La resa di riferimento presa in considerazione può essere di area o della singola azienda, ma questa diversità, per il mio ragionamento, interessa meno.
Il meccanismo è abbastanza semplice.
Ho una piantagione di mais con una resa media (calcolata su un certo numero di anni) di 10 t/ha. L'agricoltore si può assicurare sul 50, o il 75 o l'85% della resa (secondo le probabilità di rischio). Ovviamente cambia il costo dell'assicurazione ed il contributo pubblico.
L'agricoltore, per esempio, si assicura sul 75%, cioè su una resa di 7,5 t/ha. A causa della cattiva stagione, la resa effettiva è inferiore (per esempio 6 t/ha). L'assicurazione paga un indennizzo pari alla differenza di resa moltiplicato un prezzo di riferimento indicato nella polizza.
Il vantaggio di questo sistema è la semplificazione delle procedure. La valutazione del danno non avviene quando si verifica l'evento climatico, ma alla raccolta. Non vi sono complicate istruttorie; l'agricoltore dichiara la minore resa e la quantifica direttamente. Le erogazioni sono praticamente "automatiche". È la stessa compagnia che procede, a campione, a rigorosi controlli. Soprattutto verifica che la mancata resa non sia per negligenza dell'agricoltore.
Lo svantaggio: è facilmente applicabile per le grandi colture (cereali, semi oleosi ecc.) e su aree omogenee. Esse, inoltre, prendono in considerazione le singole produzioni. Tutto il contrario della nostra agricoltura, dei nostri ordinamenti colturali e del nostro paesaggio agrario. Una delle difficoltà incontrate in questa fase di sperimentazione è proprio la delimitazione delle aree omogenee.
L'assicurazione sulle rese basa la sua forza sulla disponibilità di attendibili banche dati, cioè sulle serie storiche che consentono di calcolare il costo delle polizze
Lo sviluppo delle assicurazioni zootecniche in Spagna, per esempio, è stato favorito sia dal contributo statale, sempre superiore al 40% del costo della polizza, sia, soprattutto, dall'introduzione dell'anagrafe per l'identificazione degli animali.
Il problema è la serie storica delle rese ad ettaro articolate per territorio (aree omogenee). Credo che i piani di regionalizzazione previsti dalla PAC del 1992 non siano sufficientemente attendibili.
Alla fine del 2000. l'Ismea lanciò un progetto di sperimentazione che non mi pare abbia avuto esecuzione.
Per molte nostre produzioni (in particolare gli ortofrutticoli) il valore del prodotto deriva anche dalla qualità, che spesso è caratteristica peculiare delle singole aziende.
Per queste coltivazioni si stanno sperimentando le assicurazione sul reddito. In questo, le agricolture del Canada e degli USA sono all'avanguardia.
Le assicurazioni sul reddito sono state introdotte negli USA dal 1996 ed hanno avuto un notevole successo. Esse interessano il 60% della produzione assicurata di mais e frumento. In seguito sono state estese alle produzioni ortofrutticole. Per fare un esempio, in California, nel 2002, hanno beneficiato di questa copertura assicurativa, il 62% delle superfici coltivate a mele, l'85% a fichi e uva da tavola.
Le assicurazioni sul reddito coprono il risultato complessivo dell'attività produttiva agricola: esse tengono conto della variabilità dei costi e dei ricavi, quindi anche della componente qualità.
I vantaggi sono: la semplicità della procedura, la grande adattabilità alle diverse agricolture.
L'indennizzo copre, integralmente o parzialmente, la differenza tra il reddito effettivo e quello assicurato. Il reddito effettivo è attestato dallo stesso agricoltore tramite i documenti fiscali.
Qui sta lo svantaggio: in assenza di un sistema fiscale trasparente ed affidabile, l'efficacia del sistema è molto scarsa.
Alcune indicazioni: le polizze multirischio e sulle rese
È certamente difficile trovare soluzioni. Non siamo solo di fronte ad obiettive difficoltà. C'è, secondo me, una diffusa resistenza a sperimentare e diffondere soluzioni nuove.
Le compagnie assicurative. Nel 2002 hanno incassato premi per quasi 250 milioni di euro, con un rapporto tra indennizzi e premi del 75%, in linea con gli altri paesi. Nelle regioni del mezzogiorno il rapporto è più basso, a dimostrazione che gli agricoltori assicurati del sud o sono più fortunati (cosa di cui dubito) oppure contribuiscono con le loro polizze a pagare gli indennizzi delle regioni del centro - nord, ed a mantenere il sistema in equilibrio finanziario. E' un settore di attività abbastanza marginale per le compagnie, ma consolidato.
Gli agricoltori. Gli aiuti disaccoppiati, slegati dagli andamenti produttivi e dai prezzi, rappresentano una porzione garantita del reddito aziendale. In taluni casi (penso al grano tenero, ma non solo) coprono quasi interamente i costi di produzione. Di fatto, sono essi stessi un'assicurazione base sul reddito. Possiamo dire che l'aiuto disaccoppiato rappresenta, per le aziende meno orientate al mercato, un'efficace alternativa a qualsiasi tipo di assicurazione privata, seppur sostenuta dal contributo pubblico.
Aggiungo che nel nostro paese il sistema assicurativo in agricoltura è relativamente recente: più antico e consolidato è in paesi come la Spagna e gli Stati Uniti (inizio degli anni '30) o la Francia (inizio secolo) dove, non a caso, si hanno le esperienze più avanzate.
Inoltre, per molti anni in Italia è stato decisamente privilegiato l'intervento di risarcimento dei danni piuttosto che il contributo sulle assicurazioni. Nei dieci anni dal 1988 al 1997, il contributo sulle assicurazioni ha assorbito, in Italia, il 30% della spesa complessiva dello Stato per il fondo di solidarietà; in Spagna la percentuale è stata l'80%; negli USA il 50%.
E' necessario un incentivo forte. Che non è solo la copertura del premio assicurativo, anche se questo è un aspetto non secondario. Nell'Unione europea il contributo pubblico può raggiungere al massimo l'80% del premio (il 50% nel settore zootecnico). In Spagna il contributo pubblico si è attestato, mediamente sul 53% del costo della polizza. Negli USA il contributo pubblico è, mediamente, pari al 75% del premio. Ma l'assicurazione base sulle rese (la copertura è limitata al 50% della resa storica) è completamente a carico dello Stato. L'agricoltore paga, se vuole, una copertura aggiuntiva.
Come recuperare il tempo ma, soprattutto, come costruire una strategia europea.
Vi sono alcuni segnali di una maggiore attenzione al problema.
Nell'Unione europea:
La costituzione di un fondo di solidarietà che interviene, accanto agli Stati, in occasione di grandi catastrofi;
le conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Spagna e Grecia con il richiamo alla "necessità di gettare le basi per una strategia comune di gestione del rischio in agricoltura all'interno della PAC". Questo impegno è stato inserito tra le priorità del semestre italiano di Presidenza del Consiglio agricolo;
in occasione del varo della riforma della PAC (compromesso di Lussemburgo) la Commissione si è impegnata a presentare alcune proposte entro la fine del 2004. L'obiettivo è far partire il sistema europeo di gestione dei rischi in agricoltura dal 2007.
A livello nazionale, ricordo, in particolare, oltre la proposta di riforma della legge 185:
- la previsione delle assicurazioni multirischio;
- l'istituzione della banca dati presso l'Ismea;
- la disciplina dei fondi di mutualità e solidarietà;
- la costituzione presso l'Ismea del fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli con riferimento alle polizze multirischio e sulle rese;
- il gruppo di esperti insediato presso l'Ismea per lo studio di forme innovative di assicurazioni in agricoltura.
E' un insieme di strumenti e di norme "propedeutiche" al lancio di una nuova e più moderna offerta assicurativa.
Si tratta, ora, di imprimere una decisa accelerazione al processo avviato. Recuperare i ritardi
La novità è la proposta di inserire il sistema di protezione dai rischi nel quadro della PAC. In altre parole: rafforzare l'intreccio tra intervento pubblico e privato nel sistema assicurativo in agricoltura; finalizzare meglio gli aiuti della PAC.
È un'idea che, secondo me, dovrebbe essere sostenuta con convinzione. Oggi se ne parla ancora poco. Eppure dovrebbe divenire un tema costante nella discussione sulla riforma proprio perché i tempi si intrecciano: nel periodo 2005-2007 andrà a pieno regime la riforma, si discuterà la riforma dei fondi strutturali, nascerà, secondo gli impegni assunti, il sistema europeo di gestione dei rischi.
Alcune ipotesi di lavoro: gli strumenti assicurativi e la PAC
Quali, a mio avviso, i capisaldi:
destinare al finanziamento del sistema una parte delle risorse della PAC;
trasformare una quota degli aiuti al reddito in un contributo sui costi delle polizze;
estendere il contributo a tutti i settori, anche quelli non inclusi nella riforma (per esempio alcuni allevamenti e gli ortofrutticoli).
Non sarebbe una novità in assoluto: il memorandum della Presidenza greca cita alcuni precedenti, le organizzazioni di produttori nei settori del tabacco e dell'ortofrutta.
Perché, secondo me, è un'idea condivisibile:
il contributo sul costo delle polizze assicurative premia gli agricoltori orientati al mercato ed è compatibile con le regole dell'Organizzazione mondiale per il commercio. Sarebbe un modo per risolvere i molti dubbi che ha sollevato la riforma della PAC con il meccanismo degli aiuti disaccoppiati.
Il legame tra aiuti PAC e assicurazioni allargherebbe la platea dei produttori assicurati, con positivi effetti sui costi delle polizze e sull'efficacia del sistema.
Quindi, i punti sui quali si dovrebbe lavorare:
accelerare e favorire l'offerta di polizze multirischio (o combinate, secondo la definizione della Spagna). La banca dati Ismea ed il fondo di riassicurazione contribuiscono a quest'innovazione;
avviare, per taluni prodotti di eccellenza, la sperimentazione di assicurazioni sulle rese. C'è una sorta di timor panico ad affrontare questo tema. Negli USA ed in Spagna queste polizze sono state introdotte dopo un periodo di sperimentazione. Perché non fare tesoro di quelle esperienze?
sperimentare la costituzione di fondi mutualistici di garanzia. Essi, com'è noto, possono essere istituiti dai consorzi di difesa, dalle organizzazioni di produttori o dalle cooperative. Il gruppo di esperti presso l'Ismea sta approfondendo questo tema. Io credo che i fondi mutualistici debbano essere considerati una particolare forma di assicurazione, non necessariamente alternativa a quella tradizionale. Il vantaggio dei fondi è un maggiore controllo sociale. Il fatto che i partecipanti siano tutti membri di una comunità (la cooperativa, per esempio) limita il rischio di comportamenti opportunistici. Lo svantaggio è, tuttavia, la disponibilità di capitali iniziali e, soprattutto, la concentrazione del rischio. In caso di evento, tutti, o quasi tutti i soci subiscono il danno.
In sostanza dobbiamo essere protagonisti nel definire gli orientamenti dell'Unione europea sul tema delle assicurazioni in agricoltura; ma anche attori di un nuovo modello di assicurazioni che ci permetta di giungere preparati ed attrezzati agli appuntamenti comunitari.