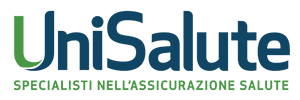17 Febbraio 2005
Tema: competitività da costi (regole). Il sistema fiscale, del welfare, pensionistico.
Archivio
Condividi
Area del sociale e dell'inclusione
Area dell'impresa e dell'innovazione
SCHEDA
Tema: Competitività da costi (regole).
Il sistema fiscale, del welfare, pensionistico.
Roma 17 Febbraio 2005
"La semplificazione amministrativa"
La situazione attuale
Le procedure amministrative della politica agraria e di molte politiche connesse in Italia nascono dalla gestione dei miglioramenti fondiari ed agrari nei cosiddetti "piani verdi", alla fine degli anni cinquanta. Queste procedure sono caratterizzate da tre aspetti: individualità della domanda (ogni pratica è un caso a parte), base dichiarativa con allegata documentazione probante dei requisiti aggettivi richiesti, istruttoria amministrativa strettamente connessa al controllo.
Questa tipologia di gestione, nata in ambito ministeriale, ma successivamente ereditata dalle Regioni, presenta diversî limiti di fondo: lentezza dei provvedimenti autorizzativi e delle erogazioni, forti oneri burocratici a carico degli utenti, scarsa efficacia dei controlli ed alta possibilità di manifestazione di fatti corruttivi e collusivi, anche per la difficoltà di distinguere gli errori amministrativi dai veri e propri tentativi di truffa.
La situazione si è aggravata con il tempo per il forte aumento delle procedure amministrative nella politica agraria (sviluppo della Pac, politiche regionali, iniziative territoriali, eccetera) e in molte politiche connesse influenti sulla gestione dell'impresa: sicurezza, ambiente, lavoro, fiscalità.
Vari tentativi di semplificazione sono stati sostanzialmente disattesi o hanno avuto effetti molto limitati: autocertificazione (logiche di sportello unico, decentramento amministrativo), anche per le difficoltà di rinnovamento e per fenomeni di inerzia organizzativa della pubblica amministrazione. Esperienze positive, invece, si sono realizzate negli ultimi dieci anni, con l'implementazione di logiche di sussidiarietà e con il rafforzamento del ruolo delle Regioni unito ad un miglioramento qualitativo (anche se diffuso a "macchie di leopardo) della pubblica amministrazione.
Le esigenze delle impresa
La semplificazione delle procedure amministrative non rappresenta soltanto una necessità per ridurre i costi di gestione ed i tempi nei processi di creazione, ristrutturazione e sviluppo delle imprese, ma un fattore di sviluppo favorendo relazioni efficaci e sinergiche tra impresa ed amministrazione pubblica, orientata al riposizionamento strategico dell'agricoltura italiana, sia sul piano locale, che nazionale ed europeo.
Portare a sistema le esperienze di sussidiarietà insieme all'implementazione ulteriore di nuove tecnologie dell'itiformazione e della comunicazione possono garantire una sostanziale semplificazione amministrativa.
La proposte della Cia
Più che cercare di semplificare le attuali procedure in essere occorre sviluppare una nuova filosofa gestionale, valorizzando, peraltro, diverse esperienze positive attivate a livello centrale e in alcune regioni.
I punti di forza di questa nuova filosofia gestionale sono:
- passaggio sistematico dalla logica della domanda (o della pratica) a quella del flusso informativo relazionale tra utente ed amministrazione;
- sviluppo di un sistema federalistico non frammentato, ma coordinato, anche con supporti centralizzati in grado di favorire economie di scala;
- valorizzazione del principio della sussidiarietà orizzontale, il ruolo dei CAA e la logica del "fascicolo aziendale" come base informativa, documentata, certificata ed autoalimentata, a supporto di tutte le relazioni procedurali con le diverse amministrazioni e con varie altre istituzioni;
- creazione di un sistema informativo in rete, federalistico, non fondato sul principio di un soggetto gestore (che ha in passato alimentato contrasti e conflittualità e di fatto bloccato ogni iniziativa), ma su quello della rete cooperativa, in cui ogni soggetto gestore, certifica e mette a disposizione di tutti le proprie basi di dati; (in questo ambito è fondamentale valorizzare e relazionare le banche dati regionali, quelle relative al sistema AGEA e quelle relative al sistema camerale come il REA);
- sviluppo della telematica e diffusione della firma digitale (anche iniziando la sperimentazione di terminali aziendali);
- valorizzazione del principio della terzietà dei controlli su tutti i segmenti e gli attori del sistema, razionalizzando, qualificando e relazionando i diversi soggetti (organi amministrativi, strutture di polizia e soggetti terzi) oggi operanti a vario titolo;
- valorizzazione del controllo da parte organismi di certificazione accreditati, in anodo complementare con l'azione di vigilanza pubblica (in questo ambito è fondamentale portare a termine la riforma del sistema di accreditamento, con una maggiore presenza del pubblico e delle rappresentanze del mondo produttivo e sociale).
"Il sistema fiscale"
Analisi
Uno stato democratico non può fare a meno di un ordinamento tributario serio e strutturato, quale garanzia di libertà personale ed economica; la fiscalità dunque non rappresenta solo una questione tecnica, ma anche morale e politica.
In forza di questi principi le scelte legate al prelievo fiscale devono necessariamente mantenere una stretta connessione con la spesa pubblica; solo in questo modo è possibile valutarne l'incidenza, l'efficacia e l'equità. Non necessariamente la riduzione del prelievo fiscale porta e risultati attesi, mentre può giustificarsi un suo incremento con vantaggio di tutti se l'impiego del provento è per fini produttivi e se l'imposta viene sottratta, ad un impiego individuale meno utile per la collettività.
Occorre dunque considerare il fisco come strumento di politica economica teso a contribuire allo sviluppo ed alla crescita della ricchezza del Paese; dobbiamo perciò uscire da questo stereotipo sbagliato per cui il sistema tributario è chiamato ad assolvere una funzione di mero reperimento delle risorse.
In questo senso serro uri sistema tributario non vessatorio, improntato su principi di giustizia, di solidarietà e equità, in un contesto di regole definite, comprensibili, attuate; occorre che l'imposta sia sopportabile e non opprimente, in modo da incentivare lo sviluppo e la crescita così da incoraggiate la produzione del reddito.
E' dunque essenziale un corretto e costante rapporto di collaborazione tra Amministrazione pubblica e contribuente, inserito in un contesto in cui la persuasione politica e morale, espressa in atti e fatti, produce la consapevolezza che difendendo il modo razionale ed uguale nell'applicazione dei tributi si difende l'essenza stessa dello Stato.
La stesso richiamo alla capacità contributiva fatto proprio dalla Carta Costituzionale non va visto in modo asettico, come base immutabile, bensì quale risultato di un giudizio che avviluppa una valutazione politica, sociale e sugli elementi oggettivi che qualificano la posizione del singolo contribuente.
Analisi e proposte
Il rapporto fra fisco ed agricoltura non si sottrae al rispetto ed all'affermazione di questi principi fondanti; di equità, capacità contributiva, sostenibilità e progressività.
L'agricoltura continua a rappresentare un settore economico fondamentale per il Paese e come tale va valorizzato e messo nelle condizioni di poter competere efficacemente di fronte ad una concorrenza. che in molti casi disattende o, peggio ancora, opera in completa essenza di regole; va peraltro rimarcato come l'agricoltura assolva anche ad un ruolo sociale rappresentato dalla sua funzione a tutela e salvaguardia del territorio nell'interesse della. collettività che in tale contesto opera e risiede.
Con la legge di Orientamento del 2001 e successive disposizioni queste prerogative sono state rese palesi e codificate primariamente da un punto di vista civilistico, successivamente nell'ambito della disciplina tributarla; il riconoscimento di una fiscalità propria appannaggio di attività sussidiarie legate all'agricoltura essenziale risponde a ragioni di armonizzazione e di attenzione al ruolo ed alla funzione del settore primario nella duplice veste di entità economica e come tale attenta a considerare la fiscalità corno fattore di competizione, e di espressione sociale in cui le esternalità positive ad essa legate meritano un adeguato riconoscimento anche in termini tributari, in particolare nel caso l'imprenditore agricolo si sostituisca all'ente pubblico territoriale nella tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale.
L'interesse manifestato dalla legge di Orientamento bis a favore di una maggiore presenza delle forme societarie in agricoltura risponde all'esigenza di accreditare a livello internazionale imprese agricole adeguatamente strutturare e patrimonializzate e con idonee risorse finanziarie; resta, da valutare e monitorate la fase attuativi per comprendere appieno gli effetti di questa scelta, considerando che (agricoltura italiana è rappresentata da un sistema di imprese diffuse, perciò radicate sul territorio, di piccole e medie dimensioni, a prevalente conduzione familiare, multifunzionali e pluriattive. Intanto occorre apportare sostanziali modifiche alla norma vigente in modo da dipanare qualche elemento di criticità che diversamente potrebbe create i presupposti a che una norma prevista a favore del settore agricolo si tramuti in opportunità più che altro speculativa per soggetti operanti in altri contesti economici.
L'affermazione anche recente del sistema catastale quale forma privilegiata di prelievo erariale verso il settore agricolo, non lascia dubbi su quella che anche per il futuro dovrà rappresentare la modalità preponderante per le imprese agricole di partecipazione alla spesa pubblica.
Nei fatti questa metodologia appare sempre meno ancorata al settore primario e sempre più esplosa anche verso altre categorie di contribuenti; parlare oggi di "catastalizzazione" del reddito o dei ricavi corrisponde ad una dato di fatto, visto che anche per le imprese commerciali e per i professionisti, seppur in termini più evoluti e dinamici, le modalità di accertamento, e dunque di definizione di una sorta di reddito convenzionale, basate sull'applicazione degli studi di settore e dei parametri rispondono ad una logica simile a quella che ha ispirato la definizione e determinazione del reddito agricolo, quale reddito medio ordinario.
Indubbiamente occorre definire modalità diverse nell'utilizzo del sistema catastale, trattandosi di uno strumento eccessivamente statico e per questo talvolta dannoso per le sperequazioni che potrebbe provocare nei confronti degli agricoltori; esso necessità di essere impiegato in modo dinamico cosicché riesca a recuperare il dato reale legato all'effettiva utilizzazione del terreno in ragione della sua concreta destinazione.
Si tratta comunque di un sistema che risponde a prerogative essenziali per l'impresa, quali quelle legate alla semplificazione del processo, alle certezza e determinabilità puntuale del prelievo ed alla sua sopportabilità.
Il riferimento ai soli imprenditori individuali ed alle società semplici quali destinatari del regime catastale, trova la sua ragion d'essere nelle caratteristiche e nelle peculiarità dei soggetti stessi, con le parti escluse che per tipologia e prerogative troverebbero non giustificata una metodologia di determinazione della propria capacità contributiva diversa da quella attuale; non da meno per i pruni andrebbe prevista una flessibilità del sistema catastale in rapporto alla diversa redditività dell'impresa stessa.
Ancora nei confronti delle imprese individuali e delle società semplici, pur limitandone (applicazione a quelle realtà con volume di affari superiore ad rara determinato limite, serve prevedere la possibilità di opzione per la determinazione del reddito nei modi normali in modo da consentire ad un numero nutrito di imprese agricole di beneficiare di possibili e probabili vantaggi legati ad una minore redditività rispetto a quella definita convenzionalmente oppure a specifiche agevolazioni.
La sopportabilità della pressione fiscale risente oggi della diversificata allocazione delle fonti di prelievo; al tradizionale prelievo erariale oramai si e stabilmente affiancato e in talune situazioni sovrapposto quello locale.
L'introduzione prima dell'Imposta comunale sugli immobili, poi dell'imposta regionale sulle attività produttive, per poi proseguire con le varie addizionali comunali e regionali, con la Tarsu, con altre imposte, tasse, tariffe ed altro, di fatto ha spostato molto il baricentro della fiscalità, prima assolutamente statocentrica, oggi più marcatamente localcentrica. La stessa Finanziaria per il 2005 né rappresenta la prova più tangibile.
In tal senso si avvertono una serie di rischi; il primo dei quali e riferito alla eccessiva burocratizzazione nei rapporti e degli adempimenti, a cui si aggiunge il timore pus un inasprimento del prelievo fiscale, in particolare in quelle realtà territoriali maggiormente penalizzate da una ridotta retrocessione delle risorse da parte dello Stato.
Appare fondato pensare ad un allargamento della forbice fra le diverse realtà del nostro territorio, dove il divario rischia di accentuarsi in modo proporzionato rispetto alle risorse che le entità territoriale sono in grado di recuperare attraverso la fiscalità locale; in tal senso occorre dunque che venga salvaguardo il principio di solidarietà su cui il nostro Stato di diritto fino ad ora ha fondato il suo tratto distintivo.
Va evitata qualsiasi scelta o decisione che contrasti con questo principio, diversamente avremo soprattutto le realtà a forte vocazione rurale, con una densità demografica ridotta e con una capacità contributiva mediamente inferiore alle altre categorie a pagarne le conseguenze maggiori; minori entrate per le Amministrazioni locali significa infatti minore possibilità di erogare prestazioni sociali a favore essenzialmente di categorie meno abbienti.
Non va inoltre trascurato un altro elemento di criticità in questo caso di natura economici una contribuzione diffusa e significativa consente di adottare misure tese a ridurre il prelievo fiscale, cosa che viceversa non è possibile in caso di prelievo ridotto, con la conseguenza che taluni produttori di ricchezza (imprese, professionisti, lavoratori dipendenti) potrebbero essere indotti a delocalizzare la propria produzione ed attività a favore di quelle realtà "più ospitali", cosa che non è consentita, nella quasi totalità dei casi, all'agricoltore,
E dunque fattore di competitività è la fiscalità nel suo complesso, abbandonando quindi lo stereotipa riferito alla sola fiscalità erariale; ci si attende che complessivamente essa sia equa, determinata, sostenibile, certa.
La certezza del diritto differita al sistema tributario, e perciò quale sistema delle regole, rappresenta uno degli anelli deboli al cospetto dell'impresa; questa per essere competitiva ha bisogno di programmare investimenti, azioni, iniziative, processi. Una situazione aleatoria come quella che vede coinvolte determinate imposte e la loro applicazione, indubbiamente non giova al sistema delle imprese agricole.
Il riferimento è alla disciplina IVA con la necessità di superare la stagione delle proroghe e ripristinare in modo strutturale il regime speciale a favore della generalità delle imprese agricole, in armonia peraltro con altri Paesi dell'Unione Europea deve sono previsti analoghi regimi contabili, ed all'Imposta regionale sulle attività produttive per cui si chiede di accelerare il processo di graduale soppressione evitando comunque che questo generi ripercussioni negative verso comparti essenziali del nostro Stato sociale, ed in ogni caso va definitivamente superata la norma transitoria e prevista a regime l'aliquota dell'1,9% che rappresenta l'espressione puntuale dell'invarianza di gettito per il settore agricolo rispetto a quanto versato precedentemente all'entrata in vigore dell'IRAP.
La dinamica del mercato premia la creatività., la ricerca, caparbietà, l'entusiasmo, la capacità imprenditoriale, l'elevato grado di managerialità, tutte qualità che per lo più risiedono in imprenditori giovani.
Alcune statistiche ci indicano che a fronte di oltre 960 mila imprese agricole iscritte al Registro delle imprese, neanche la metà sono soggette alla tenuta della contabilità IVA, mentre oltre il 70% ha un volume di affari non superiore a 50 mila curo, e non meno del 70% degli imprenditori ha un'età non inferiore ai 50 anni, con i giovani con meno di 40 anni che si attestano al di sotto del 15%.
Urgono dunque misure tese ad incentivate ed accelerare il ricambio generazionale, per evitare che l'agricoltura resti al traino di altri settori economici ed emarginata di fronte ad una prospettiva di grandi cambiamenti e di significative opportunità.
" Il sistema del welfare e pensionistico"
L'analisi delle politiche sociali, intese quali interventi di protezione sociale volti a rimediare a condizioni di bisogno degli individui, passa oggi necessariamente attraverso lo studio dei fenomeni che stanno trasformando il modello tradizionale di Welfare. I tre fenomeni, tra loro fortemente connessi, sono sostanzialmente quello della globalizzazione, quello della spinta ad accentuare le condizioni di autonomia degli enti territoriali all'interno degli ordinamenti statali (agisca essa in senso federalista o regionalista) ed, infine, quello dell'integrazione europea.
Negli ultimi anni, lo Stato sociale, così come delineato dalla Costituzione italiana del 1948, ha subito dei profondi mutamenti anche a livello normativo. Il grande disegno previsto dall'Assemblea costituente prevede che sia "compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art.3 Cost., comma secondo).
Tale previsione è stata sensibilmente condizionata dalla recente riforma del titolo V della Costituzione, apportata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Le novità introdotte con questa incisiva innovazione della Carta Costituzionale, infatti, hanno disegnato un modello nuovo di azione dello Stato sociale, il quale, pur allontanandosi dal modello originario, sembra chiaramente intenzionato a seguirne gli alti scopi, pur con mezzi profondamente diversi.
L'articolo appena menzionato, infatti, deve oggi essere letto in combinato disposto con altre norme della Costituzione. In primo luogo, con l'art. 114, in base al quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". E' chiaro, quindi, che il compito di rimuovere tali ostacoli spetti ad un soggetto, quale è la Repubblica, che non è riconducibile solo allo Stato, ma anche agli altri enti territoriali, cioè ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni. Tali enti territoriali autonomi, quindi, sono chiamati a concorrere alla costruzione del welfare state con la stessa rilevanza giuridica e dignità politica riconosciuta allo Stato.
D'altra parte, ciascun ente, a sua volta, è chiamato ad avvalersi dell'azione dei privati. Come recita l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, infatti, " Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Dunque, a ciascuno dei soggetti che compongono la Repubblica spetta l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali che si frappongono alla libertà ed eguaglianza dei consociati e, nel farlo sono chiamati ad avvalersi del principio di sussidiarietà orizzontale.
Il quadro normativo costituzionale, inoltre, si compone delle disposizioni riguardanti i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali". Nella graduazione progressiva dell'incidenza dell'intervento sociale, infatti, il legislatore costituzionale nel 2001 ha effettuato una ripartizione tra lo Stato e le singole Regioni. Come recita l'art. 117 della Costituzione (comma secondo, lettera p), spetta allo Stato la determinazione di tali livelli essenziali, mentre spetterebbe alle singole Regioni decidere di fornire (o non fornire) e come farlo tutte quelle prestazioni che concernono livelli superiori a quelli essenziali, fino, in teoria, a coprire i livelli massimi delle prestazioni.
Quello che si ricava dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali inerenti lo Stato sociale, dunque, è che oggi il "welfare state" è un sistema complesso ed articolato nel quale sono chiamati a svolgere un ruolo significativo, sia le autorità pubbliche, centrali e locali, sia i privati.
Tale complessità si traduce anche in una occasione di differenziazione delle prestazioni dello stato sociale in riferimento alle diverse aree del paese sulle quali è chiamato ad operare. Una volta stabilite (e tutelate) le prestazioni concernenti i livelli essenziali, infatti, in ciascuna zona l'intervento degli altri enti potrebbe articolarsi nel senso delle specifiche richieste che da quel territorio emergono. Qui, dunque, si apre un grande spazio che è compito del welfare locale riempire.
D'altra parte, la stesse legge n. 328 del 2000 aveva disegnato uno scenario convergente con quanto appena descritto. Come si legge all'art. 1 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce, le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia".
Proprio nella legge adottata nel 2000 è forte e caratterizzante sia l'idea di un sistema sociale costruito con il contributo di diversi attori (pubblici, privati e del "terzo settore"), sia l'attenzione al coinvolgimento degli enti territoriali diversi dallo Stato, quali le Regioni, le Province ed i Comuni con il metodo della programmazione, che pone in stretto contatto risorse ed interventi. Spetta alle Regioni, nell'ambito del piano triennale nazionale, l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, coadiuvata dai Comuni e Province che a tali attività concorrono la stessa Legge del 2000 si preoccupò di definire il contenuto dei livelli essenziali (art.22), aprendo la strada all'approccio sistemico ora previsto in Costituzione.
Venendo nello specifico al settore della previdenza sociale, anche in riferimento ad esso la Costituzione prevede compiti diversi per lo Stato e per le Regioni. Come si legge sempre all'art. 117 della nostra Carta fondamentale, infatti, la materia " previdenza sociale" figura tra le materie sottoposte alla competenza esclusiva della legge statale, senza che vi possa essere margine di intervento per le Regioni. In realtà esse recuperano un ruolo in questo settore, poiché al comma successivo dello stesso articolo si legge che la materia " previdenza complementare ed integrativa" rientra tra quelle sottoposte alla potestà concorrente tra lo Stato e le Regioni. Nelle materie concorrenti, come è noto, spetta alla legge dello Stato porre i principi, mentre le norme di dettaglio sono riservate alle Regioni.
Il sistema previdenziale italiano non brilla certo per equilibrio ed equità fra le varie gestioni e fra i lavoratori assicurati. Il caso agricoltura è originato proprio dal problema dell'equità, delle contribuzioni prima e delle prestazioni pensionistiche poi. In tal senso, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo nulla ha innovato. Una riforma dovrebbe rappresentare l'occasione per recuperare parte delle disuguaglianze e delle discriminazioni,ma sulla previdenza fino ad oggi ciò non è accaduto. Osservando l'andamento della discussione e del confronto, ci accorgiamo subito che anche in questa occasione non sarà così, anzi rischiamo seriamente che sul secondo pilastro, la tanto invocata previdenza complementare, si trasferiscano le pecche della previdenza obbligatoria. La gestione dei lavoratori agricoli autonomi all'interno dell'Inps è caratterizzata da sempre da un deficit di bilancio, pur essendo le pensioni dei coltivatori diretti le più basse in assoluto. Tali pensioni fino al 1990 sono risultate sempre inferiori al trattamento minimo e successivamente superiori al minimo solo per pochi. Si potrebbe facilmente pensare ad una gestione scellerata, ma non è assolutamente così. Il settore paga a caro prezzo la riduzione continua degli addetti e le scelte politiche nazionali dirette ad una imponente industrializzazione. La conseguenza è che il rapporto si è fortemente sbilanciato e che i titolari di prestazioni superano per numero i lavoratori iscritti alla gestione (rapporto di 3 a 1). Non solo, ad appesantire ulteriormente la situazione concorrono due problemi specifici:
1) Allargamento della platea a figure miste (soprattutto al sud), un problema per il quale chiediamo da sempre una soluzione restando inascoltati;
2) La rigidità del sistema di contribuzione, che non consente a chi può di pagare di più, per avere domani una pensione più dignitosa;
In agricoltura risultano attive circa 1.200.000 partita IVA, di cui, 1.000.000 riguardano aziende iscritte anche al registro imprese della Camera di Commercio. Le posizioni previdenziali aperte presso l'INPS però sono solo 600.000, in virtù di un obbligo che vige solo per coloro che svolgono l'attività in maniera prevalente e continuativa.
Solo allargando la platea possiamo pensare a realizzare maggiori entrate ed il tal sensosono individuabilisei aspetti da prendere in considerazione per realizzare l'obiettivo posto in discussione.
1) conduzione di aziende agricole in maniera non prevalente;
2) collaborazione alla conduzione da parte di familiari occasionali;
3) attività svolta dalle cosiddette figure miste;
4) conduzione da parte di società;
5) famiglie di fatto;
6) contoterzismo agricolo.
Intervenire sulla previdenza agricolatenendo conto dei sei punti di cui sopra, determinerebbe un sostanziale ampliamento della platea, interessando soggetti che effettivamente operano nel settore. Si realizzerebbe inoltre un importante passo avanti, in direzione dell'equità, delle pari opportunità e della dignità della categoria. Riteniamo importante che, anche soggetti che guardano all'agricoltura in maniera non esclusiva, contribuiscano alla crescita della gestione. Per costoro, pur avendo diritto alla pensione in altra gestione , l'iscrizione rappresenterebbe comunque una integrazione della misura della stessa e quindi un beneficio tangibile.
Risolvere il problema delle figure miste significherebbe oltre ad ampliare la platea degli iscritti, alleggerire la gestione dei lavoratori agricoli dipendenti, ottenendo anche una forte diminuzione del ricorso alle indennità di disoccupazione. Occorre però il coraggio di una scelta forte, che consenta la regolarizzazione in prospettiva futura, chiudendo gli occhi sul passato. Infatti, fino a che sui potenziali soggetti regolarizzabili, penderà la spada di damocle dei possibili recuperi retroattivi, con la conseguente perdita del diritto a prestazioni di disoccupazione già percepite e notifica di indebiti per il loro recupero, tali soggetti non emergeranno mai. Più complesso ancora il discorso sulla rigidità del sistema.
Dopo oltre 30 anni di gestione a contribuzione fissa uguale per tutti e prestazioni altrettanto fisse, uguali e mai superiori al minimo neanche con 35 anni di anzianità, con la legge 233/90 si sono fatti alcuni passi in avanti, senza tuttavia risolvere il problema.
L'introduzione delle fasce contributive, delle retribuzioni convenzionali e del calcolo di pensione in pro-rata, hanno apportato benefici sulle pensioni di anzianità. I benefici però si sono ben presto rivelati notevolmente inferiori agli aumenti contributivi, eppure la gestione per i motivi che prima citavo continua a restare deficitaria in maniera sostanziale. Oggi non possiamo negare che una parte delle pensioni agricole superano il trattamento minimo, né che la presenza di contributi agricoli autonomi nella carriera lavorativa grazie al meccanismo del pro-rata per i singoli periodi lavorativi, non penalizza più il calcolo della pensione.
Tuttavia siamo ancora lontani da un ragionamento equo. Ancora oggi un coltivatore diretto collocato in prima fascia (sono la maggioranza degli iscritti), che possa vantare 40 anni di anzianità contributiva, non supera l'importo del trattamento minimo, pur essendo i suoi versamenti dal 90 ad oggi aumentati del 200% ovvero triplicati.
Coloro che invece fin dal 1990 si collocavano nelle fasce superiori, beneficiando del miglioramento di fascia per tutta la carriera lavorativa, con 35 anni di contributi, ricevono una pensione superiore al trattamento minimo. Per ottenere però un beneficio consistente occorre essere collocati in quarta fascia , con una aumento dei contributi versati che arriva al 500%. Come si vede non c'è confronto fra gli aumenti contributivi e quelli pensionistici.
Peraltro il riconoscimento dei benefici di fascia anche sui periodi precedenti al 90 ha creato una assurda discriminazione: periodi nei quali tutti avevano pagato gli stessi contributi hanno assunto un valore diverso. Coincidendo la riforma con i 35 anni dall'istituzione della gestione, ad alcuni è bastato pagare per un solo anno con il nuovo sistema per avere una pensione migliore rispetto a quella di molti altri colleghi e ciò, - consentitemi il termine - è anomalo e curioso.
Il problema principale comunque resta la rigidità del sistema. Le quattro fasce sono ancorate ad un unico parametro: il reddito agrario. La redditività di un'azienda moderna invece non è più legata a tale reddito, bensì agli investimenti effettuati e alla capacità imprenditoriale del titolare dell'azienda, pertanto a parità di reddito agrario, il reddito effettivo può cambiare radicalmente e con esso ovviamente cambia la capacità di contribuzione. Ci troviamo così di fronte a due casistiche opposte:
1) L'azienda è collocata in una fascia contributiva che l'agricoltore non può sostenere;
2) L'agricoltore ha un reddito che gli consentirebbe una contribuzione maggiore e di conseguenza una pensione maggiore, ma il sistema glielo impedisce, salvo per alcuni più giovani che possono almeno optare per la fascia superiore a quella cui è inquadrata l'azienda;
Queste considerazioni, inducono a sostenere che occorrono nuove modifiche in grado di dare respiro al sistema, renderlo sostenibile per chi ha redditi bassi e aumentare le entrate aumentando la contribuzione di chi ha redditi più alti. Le fasce possono essere mantenute, magari riducendole per eliminazione di quelle a maggiore contribuzione, in modo da mantenere ai livelli più bassi la contribuzione minima che tutti gli iscritti devono versare. Vanno però individuati ed affiancati alle fasce altri criteri per il versamento di contributi percentuali, come già accade per artigiani e commercianti. Il parametro di riferimento potrebbe essere il reddito netto ai fini Irap, ovviamente quando questo supera le soglie di retribuzione convenzionale coperte dalla contribuzione minima della fascia di appartenenza. Parallelamente occorre riconoscere non a parole ma nei fatti l'anomalia di una gestione sovraccarica di problemi del passato. Problemi come prima dicevo, derivati dalle scelte politiche del nostro paese e dal conseguente esodo dalle campagne di soggetti che successivamente pensionandosi sono stati posti a carico della gestione. Gli oneri provenienti dal passato devono essere separati dalla gestione corrente e posti a carico del bilancio dello stato, consentendo così un riequilibrio fra iscritti attivi e pensionati, rispondente alla reale situazione dell'agricoltura italiana.
Non ci convince l'idea di una previdenza complementare basata sul trasferimento obbligatorio del TFR, se prima non si definiscono bene i parametri di compensazione per le imprese e di rendimento per i lavoratori. IL trasferimento ai fondi pensione del TFR non convince nessuno: non convince le imprese che si vedono sottrarre nell'immediato risorse economiche; non convince i lavoratori che vedono trasformarsi una risorsa certa incassata interamente al momento del pensionamento, in una risorsa dal rendimento incerto e per di più incassata in forma dilazionata; non convince il mondo del lavoro autonomo che non ha il TFR su cui discutere. Il mondo del lavoro autonomo attende quindi di sapere come la previdenza complementare si cala al suo interno. Per i lavoratori autonomi una cosa è certa: per finanziare la previdenza complementare devono reperire risorse proprie, rinunciare nell'immediato ad ulteriore liquidità oppure restarne fuori. Per questo la vera leva per il decollo dei fondi pensione sta nella defiscalizzazione e nella garanzia di stabilità. Se gli incentivi fiscali sono appetibili e purtroppo oggi non lo sono, i fondi possono attrarre risorse, altrimenti se ne continuerà a discutere ed i lavoratori continueranno a snobbarli. Quanto alle garanzie di stabilità, oggi non ve ne sono, tutto è affidato al mercato privato che si è dimostrato volatile e incerto. Il governo se vuole veramente far decollare la previdenza complementare e noi siamo convinti che debba essere così deve accettare un confronto serio e aperto.
Occorrono garanzie sul recupero del capitale investito e rendimenti minimi prefissati. Non si tratta di questioni impossibili, bensì di meccanismi che altre forme di investimento privato già offrono. Complessivamente quindi le modificazioni del sistema previdenziale ed il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo per il mondo agricolo ha complicato una situazione già abbastanza critica. L'abbassamento del tasso di sostituzione in un settore dalla pensioni già poco consistenti e soprattutto il superamento dell'integrazione al trattamento minimo, che fino ad oggi ha garantito comunque una prestazione certa destabilizzano la gestione creando forti preoccupazioni. Se a ciò aggiungiamo l'impossibilità di inserirsi in sistema di previdenza complementare dai costi troppo alti per il settore, si giunge ad una unica conclusione: per evitare nel futuro la comparsa di un vero e proprio problema sociale degli ex agricoltori, oggi occorre fare di più.
In questo quadro occorre prima ancora di entrare nel merito della riforma dello Stato sociale definire un primo punto della discussione.
Sedi e soggetti della concertazione.
Questo punto è di forma (se vogliamo, possiamo anche dire che è un profilo procedurale) ma, allo stesso tempo è un profilo sostanziale.
Non possiamo permetterci il lusso di lasciare che il dibattito sulla riforma delle politiche sociali sia svolto negli stessi modi e con gli stessi soggetti di venti, trenta o addirittura quaranta anni fa. Con ciò si fa riferimento sia alle sedi dove si svolge il metodo della concertazione, sia ai soggetti che siedono alle prime fila di quei tavoli.
Ciclicamente, infatti, i sindacati ed il Governo nazionale si incontrano nelle stanze del potere centrale e si confrontano. La parte dei leoni, come sappiamo, è giocata, all'interno della rappresentanza sociale, dai sindacati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Queste procedure e questi metodi della concertazione devono essere radicalmente aggiornati perché è mutato in maniera evidente il contesto sociale per il quale, in quelle riunioni, si cercano nuove politiche.
Iniziando dal primo dei due aspetti, occorre dunque superare l'idea, generalmente accettata da quasi tutte le forze politiche, che la sede della concertazione sia esclusivamente quella del Governo centrale. Tuttavia, come è noto, non è così semplice, anzi le politiche sociali oggi sono investite da fenomeni di complessità come la legge n. 328 del 2000 ha ben colto.
Questa necessaria riforma organizzativa, d'altro canto, non è solo richiesta dalla strutturazione multilivello delle politiche sociali e dall'affermazione delle logiche federaliste, ma è anche l'unico vero strumento con il quale si possa subito dare una risposta alla crisi della rappresentanza che investe il Paese.
La classe dirigente dei sindacati e delle organizzazioni professionali, in questo modo, sarebbe il vero canale di semplificazione e rappresentanza degli interessi del territorio, di ciascuna realtà, delle sue peculiarità e delle sue esigenze sociali. Le esigenze del territorio e la logica della partecipazione alle scelte sociali ne beneficerebbe, le scelte sociali stesse accrescerebbero le loro capacità risolutive.
Per quanto riguarda, poi, i soggetti della trattativa tra le rappresentanze degli interessi e gli organi di governo, occorre togliere l'egemonia della discussione sul Welfare ai sindacati dei lavoratori dipendenti; sia chiaro, non si propone di estromettere soggetti importanti del panorama sindacale del Paese, tantomeno, di allontanare dai tavoli della concertazione gli interessi rappresentati da quegli stessi soggetti.
Quello che occorre fare è recuperare una dimensione di "complessità degli interessi", senza che nessuno possa monopolizzarli, né, tantomeno ridurre tale complessità.
Come sottolinea in un bel libro, recentemente tradotto in Italia, il filosofo francese André Gorz, le trasformazioni delle economie occidentali stanno riducendo sensibilmente il ruolo del lavoro salariato, mentre sempre di più ciascuno di noi è "imprenditore di se stesso" all'interno di un'economia della conoscenza.
Il concetto di lavoratore salariato si è trasformato, poiché sempre di più ciascuno sente su di se il peso della sua forza lavorativa. Bisogna, quindi, far emergere nella discussione sulle politiche sociali anche il disegno di stato sociale quale richiesto dai lavoratori autonomi.
Non dimentichiamoci, poi, che alcuni degli interessi che sono recentemente sorti nella realtà sociale hanno difficoltà ad essere rappresentati. Chi rappresenta le future generazioni che non avranno né domani una pensione dal sistema pubblico, né tantomeno hanno oggi le borse di studio e gli incentivi alla formazione?
Formazione ed accrescimento del capitale umano
La formazione, appunto: è questo il vero, forte e determinante perno del sistema sociale del prossimo millennio. Il cittadino (per essere un lavoratore protetto) deve essere messo nella condizione di accedere alle forme del sapere culturale e professione, deve poter contare sulla disponibilità di tempo per formarsi e rimanere formato durante gli anni. Ecco perché occorre, in primo luogo, liberare risorse per le politiche sociali della formazione giovanile e d'ingresso al mercato del lavoro.
Ma non basta, non è così semplice. Se il cittadino deve essere messo nelle condizioni di crescere e competere, allo stesso tempo deve potersi muovere con sicurezza, perché è sicuro che se cade sotto di lui c'è una rete che lo protegge: una rete di politiche sociali che è "normalmente" sotto di lui.
Un Welfare a rete per tutti che combatte l'eredità dello svantaggio
Questa logica trasforma il concetto stesso di stato sociale. Il nuovo Welfare, infatti, deve essere allo stesso tempo sociale e liberale. Sociale, nella misura in cui include un numero maggiore di soggetti tra i destinatari delle proprie politiche; esso si configura come un welfare della normalità, cioè un sistema sociale che si rivolge a tutti, senza essere proiettato su di una categoria specifica (di lavoratori, di età, di sesso). Esso deve permettere a ciascuno di formarsi, di occuparsi e di continuare a formarsi sia nei periodi nei quali è occupato sia in quelli nei quali non è soggetto ad un rapporto di lavoro. Pensiamo la tema dell'eredità sociale dello svantaggio. Cosa significa questa espressione?
Significa che non ci sarà più eredità sociale di svantaggio quando un giovane potrà avere accesso al sapere indipendentemente dalla sua estrazione sociale, dal contesto culturale e dal luogo di nascita.
Le nuove povertà
Un nuovo welfare, dunque, è necessario anche perché nuove sono le situazioni che richiedono un intervento delle politiche sociali. In primo luogo le nuove povertà, quali quelle nelle quali si trovano, gli anziani non autosufficienti e le donne sole con figli a carico ed un solo reddito. Il Welfare della normalità, infatti, non deve perdere di vista la povertà, ossia i momenti nei quali si rompe il rapporto tra il singolo e la socialità.
Perdere la dimensione sociale, infatti, porta fuori dal sistema di protezione costruito nella complessità. Ecco dunque che in questo caso devono funzionare i meccanismi di inclusione che, agendo sui fattori di esclusione, rendano i nuovi poveri di nuovo membri del patto sociale.
Il caso degli anziani soli che vivono in condizioni di non autosufficienza sono un esempio drammatico e violento di queste nuove povertà. Come rispondere a questa emersione di nuovi bisogni? Includendoli di nuovo, sia garantendone il reddito, sia attivandoli, cioè facendoli promotori di attività di interesse sociale. Inoltre, integrazione potrebbe anche voler dire ricreare un ambiente famigliare intorno a loro, ad esempio permettendogli di affittare una stanza a giovani studenti, chiedergli di vigilare le scuole e così via. L'importante è ridargli il senso di appartenenza al patto sociale e alla rete di socialità protettiva.
In sintesi questa può essere l'analisi con le relative proposte:
1) Una rete di servizi sociali per lo sviluppo delle aree rurali.
2) Esigenze delle imprese agricole in un quadro di crescita della competitività: politiche fiscali, welfare, sistema pensionistico.
Prendendo le mosse dal V° Censimento generale dell'agricoltura (2000), il CNEL ha affidato all'Istituto nazionale di sociologia rurale, INSOR, un lavoro prezioso di lettura e di analisi dell'agricoltura italiana tra passato e futuro.
Il rapporto dal titolo "Capitale umano e stratificazione nell'Italia agricola" è stato presentato circa un anno fa.
Ad esso facciamo utilmente riferimento per ancorare, in modo aggiornato, le politiche pubbliche, fiscali, previdenziali e sociali ai soggetti sociali che vivono ed operano nei contesti agricoli e rurali.
1990-2000
Meno SAU; meno giornate lavorative (-27,6%); il part-time perde slancio; permane la frammentazione fondiaria e la polverizzazione delle aziende agricole. Crescono di peso le aziende a condizione diretta 81,3% della SAU e 87% della PLV. Si è arrestato il processo di concentrazione produttiva.
Scarsa attrazione del settore verso i giovani.
Continua l'avanzata dell'impresa al femminile: nel 2000 le imprese dirette da donne sono oltre il 30% del totale.
Prosegue il progressivo invecchiamento degli addetti nel 1990, 55.000 aziende avevano almeno un giovane impegnato a tempo pieno; nel 2000 sono ridotte a 29.000.
I giovani si sono ritirati dalle attività di allevamento, per contro aumentano la presenza nella viticoltura e nella olivicoltura.
Alla data del censimento 2000 oltre 3 milioni e mezzo di ettari SAU erano in mano ad imprenditori ultrasessantenni senza successori palesi.
Un progetto per la competitività dell'impresa agricola e per la valorizzazione del territorio implica politiche che non sono penalizzanti per il fattore lavoro, anzi serve innovazione, qualificazione delle strategie di offerta e sviluppo delle economie di rete.
I servizi alla persona costituiscono un fattore di qualità sociale che contribuisce alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività produttive e migliora la competitività delle imprese e del sistema produttivo.
In Italia la spesa sociale e quella sanitaria sono inferiori alla media europea; dal 1981 la spesa pro-capite per gli anziani è in diminuzione.
Se l'orizzonte di riferimento è l'Agenda di Lisbona dobbiamo immaginare che politica economica, politica per l'occupazione e politica sociale costituiscono i tre lati di un triangolo.
La spesa per le politiche sociali va considerata complementare a quella per le politiche di sviluppo.
Una spesa sociale da ristrutturare e da rinnovare.
Vanno aumentate le risorse sul PIL impiegandole verso il welfare, la sanità, la scuola e il lavoro che costituiscono il volano per la ripresa e lo sviluppo economico.
Questo implica una convergenza e una coerenza tra politiche sociali e politica fiscale.
Le moderne politiche di welfare in ambito europeo e, in particolare, quelle delineate in Italia sulla base della riforma del titolo V della Costituzione e della <a href="http://l.n.328/2000,">L. n. 328/2000,</a> si configurano come politiche di "protezione sociale attiva" (luogo di esercizio dei diritti di cittadinanza).
Politiche sociali che tendono ad integrarsi e coordinarsi con le politiche sanitarie, della formazione e del lavoro.
Politiche non centralistiche, ma che hanno come sfondo la possibile costruzione dell'Europa sociale e si articolano secondo un modello di "governance" a più livelli: nazionale, regionale, locale e richiedono, per essere attuate, il metodo della sussidiarietà e della condivisione di soggetti pubblici e privati sia nella fase della programmazione che in quella dell'attuazione.
Gli agricoltori italiani, per le peculiarità della loro storia e per le caratteristiche socioeconomiche che sono state richiamate, sono protagonisti "paradigmatici" di un'idea del sociale.
Essi rappresentano in modo compiuto con la loro stessa presenza e con la loro attività responsabilità sociale, legame con il territorio, senso di coesione.
Essi sono soggetti fondamentali per incardinare moderne politiche sociali che si propongono di riorganizzare il territorio sulla base di un modello universalistico, partendo dalle esigenze del cittadino e delle comunità.
Politiche sociali che si propongono di recuperare il valore della solidarietà, delle reti di relazione, delle identità comunitarie in contrapposizione all'individualismo, al liberismo, all'atomizzazione sociale che caratterizza una società di meri consumatori.
Gli elementi fin qui evidenziati portano a sostenere la necessità di alcuni provvedimenti essenziali che sono:
- l'adeguamento dei minimi di pensione ai 516,46 euro innalzando i massimali di esclusione previsti dalla normativa: la rivalutazione dei contributi versati al fine di poter favorire la maturazione di pensioni anche superiori ai minimi nel caso di carriere contributive particolarmente lunghe, favorendo così anche la possibilità che chi continua ad essere assicurato anche dopo il pensionamento possa vedere migliorata la propria pensione;
- l'adeguamento degli assegni al nucleo familiare a quello degli altri lavoratori eliminando una pesante ed ingiustificata discriminazione; il riconoscimento dei contributi figurativi, anche attraverso appositi versamenti degli interessati, delle donne a cui negli anni 60 e 70 sono state accreditate solo 104 giornate e non 156 come agli uomini;
- la definizione di un meccanismo, anche per l'INAIL, ed il pagamento di una quota ridotta nel caso dei pensionati che continuano a lavorare in quanto, è vero che il rischio infortuni per gli anziani è maggiore, ma è anche vero che il numero di giornate svolte è di gran lunga inferiore; (oltre l'80 con attività inferiore alle 100 giornate).
La realizzazione di una politica di servizi sociali nelle campagne in grado di eliminare le forti disuguaglianze attualmente esistenti. Questa politica può essere realizzata attraverso una serie di azioni:
- riconoscendo la possibilità di centri multiservizi come previsto dalla proposta di Legge sui piccoli Comuni;
- la possibilità alle Organizzazioni agricole di gestire determinati servizi, realizzando la sussidiarietà, anche attraverso l'attivazione del volontariato.
Sfide difficili ed idee chiare
Se dovessimo semplificare, ulteriormente, potremmo dire che davanti a queste idee difficili occorre avere idee chiare, lenti funzionanti con le quali leggere i fenomeni di trasformazione.
Queste idee sono: partecipazione, inclusione, normalità, formazione e sicurezza.
Area dell'impresa e dell'innovazione
SCHEDA
Tema: Competitività da costi (regole).
Il sistema fiscale, del welfare, pensionistico.
Roma 17 Febbraio 2005
"La semplificazione amministrativa"
La situazione attuale
Le procedure amministrative della politica agraria e di molte politiche connesse in Italia nascono dalla gestione dei miglioramenti fondiari ed agrari nei cosiddetti "piani verdi", alla fine degli anni cinquanta. Queste procedure sono caratterizzate da tre aspetti: individualità della domanda (ogni pratica è un caso a parte), base dichiarativa con allegata documentazione probante dei requisiti aggettivi richiesti, istruttoria amministrativa strettamente connessa al controllo.
Questa tipologia di gestione, nata in ambito ministeriale, ma successivamente ereditata dalle Regioni, presenta diversî limiti di fondo: lentezza dei provvedimenti autorizzativi e delle erogazioni, forti oneri burocratici a carico degli utenti, scarsa efficacia dei controlli ed alta possibilità di manifestazione di fatti corruttivi e collusivi, anche per la difficoltà di distinguere gli errori amministrativi dai veri e propri tentativi di truffa.
La situazione si è aggravata con il tempo per il forte aumento delle procedure amministrative nella politica agraria (sviluppo della Pac, politiche regionali, iniziative territoriali, eccetera) e in molte politiche connesse influenti sulla gestione dell'impresa: sicurezza, ambiente, lavoro, fiscalità.
Vari tentativi di semplificazione sono stati sostanzialmente disattesi o hanno avuto effetti molto limitati: autocertificazione (logiche di sportello unico, decentramento amministrativo), anche per le difficoltà di rinnovamento e per fenomeni di inerzia organizzativa della pubblica amministrazione. Esperienze positive, invece, si sono realizzate negli ultimi dieci anni, con l'implementazione di logiche di sussidiarietà e con il rafforzamento del ruolo delle Regioni unito ad un miglioramento qualitativo (anche se diffuso a "macchie di leopardo) della pubblica amministrazione.
Le esigenze delle impresa
La semplificazione delle procedure amministrative non rappresenta soltanto una necessità per ridurre i costi di gestione ed i tempi nei processi di creazione, ristrutturazione e sviluppo delle imprese, ma un fattore di sviluppo favorendo relazioni efficaci e sinergiche tra impresa ed amministrazione pubblica, orientata al riposizionamento strategico dell'agricoltura italiana, sia sul piano locale, che nazionale ed europeo.
Portare a sistema le esperienze di sussidiarietà insieme all'implementazione ulteriore di nuove tecnologie dell'itiformazione e della comunicazione possono garantire una sostanziale semplificazione amministrativa.
La proposte della Cia
Più che cercare di semplificare le attuali procedure in essere occorre sviluppare una nuova filosofa gestionale, valorizzando, peraltro, diverse esperienze positive attivate a livello centrale e in alcune regioni.
I punti di forza di questa nuova filosofia gestionale sono:
- passaggio sistematico dalla logica della domanda (o della pratica) a quella del flusso informativo relazionale tra utente ed amministrazione;
- sviluppo di un sistema federalistico non frammentato, ma coordinato, anche con supporti centralizzati in grado di favorire economie di scala;
- valorizzazione del principio della sussidiarietà orizzontale, il ruolo dei CAA e la logica del "fascicolo aziendale" come base informativa, documentata, certificata ed autoalimentata, a supporto di tutte le relazioni procedurali con le diverse amministrazioni e con varie altre istituzioni;
- creazione di un sistema informativo in rete, federalistico, non fondato sul principio di un soggetto gestore (che ha in passato alimentato contrasti e conflittualità e di fatto bloccato ogni iniziativa), ma su quello della rete cooperativa, in cui ogni soggetto gestore, certifica e mette a disposizione di tutti le proprie basi di dati; (in questo ambito è fondamentale valorizzare e relazionare le banche dati regionali, quelle relative al sistema AGEA e quelle relative al sistema camerale come il REA);
- sviluppo della telematica e diffusione della firma digitale (anche iniziando la sperimentazione di terminali aziendali);
- valorizzazione del principio della terzietà dei controlli su tutti i segmenti e gli attori del sistema, razionalizzando, qualificando e relazionando i diversi soggetti (organi amministrativi, strutture di polizia e soggetti terzi) oggi operanti a vario titolo;
- valorizzazione del controllo da parte organismi di certificazione accreditati, in anodo complementare con l'azione di vigilanza pubblica (in questo ambito è fondamentale portare a termine la riforma del sistema di accreditamento, con una maggiore presenza del pubblico e delle rappresentanze del mondo produttivo e sociale).
"Il sistema fiscale"
Analisi
Uno stato democratico non può fare a meno di un ordinamento tributario serio e strutturato, quale garanzia di libertà personale ed economica; la fiscalità dunque non rappresenta solo una questione tecnica, ma anche morale e politica.
In forza di questi principi le scelte legate al prelievo fiscale devono necessariamente mantenere una stretta connessione con la spesa pubblica; solo in questo modo è possibile valutarne l'incidenza, l'efficacia e l'equità. Non necessariamente la riduzione del prelievo fiscale porta e risultati attesi, mentre può giustificarsi un suo incremento con vantaggio di tutti se l'impiego del provento è per fini produttivi e se l'imposta viene sottratta, ad un impiego individuale meno utile per la collettività.
Occorre dunque considerare il fisco come strumento di politica economica teso a contribuire allo sviluppo ed alla crescita della ricchezza del Paese; dobbiamo perciò uscire da questo stereotipo sbagliato per cui il sistema tributario è chiamato ad assolvere una funzione di mero reperimento delle risorse.
In questo senso serro uri sistema tributario non vessatorio, improntato su principi di giustizia, di solidarietà e equità, in un contesto di regole definite, comprensibili, attuate; occorre che l'imposta sia sopportabile e non opprimente, in modo da incentivare lo sviluppo e la crescita così da incoraggiate la produzione del reddito.
E' dunque essenziale un corretto e costante rapporto di collaborazione tra Amministrazione pubblica e contribuente, inserito in un contesto in cui la persuasione politica e morale, espressa in atti e fatti, produce la consapevolezza che difendendo il modo razionale ed uguale nell'applicazione dei tributi si difende l'essenza stessa dello Stato.
La stesso richiamo alla capacità contributiva fatto proprio dalla Carta Costituzionale non va visto in modo asettico, come base immutabile, bensì quale risultato di un giudizio che avviluppa una valutazione politica, sociale e sugli elementi oggettivi che qualificano la posizione del singolo contribuente.
Analisi e proposte
Il rapporto fra fisco ed agricoltura non si sottrae al rispetto ed all'affermazione di questi principi fondanti; di equità, capacità contributiva, sostenibilità e progressività.
L'agricoltura continua a rappresentare un settore economico fondamentale per il Paese e come tale va valorizzato e messo nelle condizioni di poter competere efficacemente di fronte ad una concorrenza. che in molti casi disattende o, peggio ancora, opera in completa essenza di regole; va peraltro rimarcato come l'agricoltura assolva anche ad un ruolo sociale rappresentato dalla sua funzione a tutela e salvaguardia del territorio nell'interesse della. collettività che in tale contesto opera e risiede.
Con la legge di Orientamento del 2001 e successive disposizioni queste prerogative sono state rese palesi e codificate primariamente da un punto di vista civilistico, successivamente nell'ambito della disciplina tributarla; il riconoscimento di una fiscalità propria appannaggio di attività sussidiarie legate all'agricoltura essenziale risponde a ragioni di armonizzazione e di attenzione al ruolo ed alla funzione del settore primario nella duplice veste di entità economica e come tale attenta a considerare la fiscalità corno fattore di competizione, e di espressione sociale in cui le esternalità positive ad essa legate meritano un adeguato riconoscimento anche in termini tributari, in particolare nel caso l'imprenditore agricolo si sostituisca all'ente pubblico territoriale nella tutela e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale forestale.
L'interesse manifestato dalla legge di Orientamento bis a favore di una maggiore presenza delle forme societarie in agricoltura risponde all'esigenza di accreditare a livello internazionale imprese agricole adeguatamente strutturare e patrimonializzate e con idonee risorse finanziarie; resta, da valutare e monitorate la fase attuativi per comprendere appieno gli effetti di questa scelta, considerando che (agricoltura italiana è rappresentata da un sistema di imprese diffuse, perciò radicate sul territorio, di piccole e medie dimensioni, a prevalente conduzione familiare, multifunzionali e pluriattive. Intanto occorre apportare sostanziali modifiche alla norma vigente in modo da dipanare qualche elemento di criticità che diversamente potrebbe create i presupposti a che una norma prevista a favore del settore agricolo si tramuti in opportunità più che altro speculativa per soggetti operanti in altri contesti economici.
L'affermazione anche recente del sistema catastale quale forma privilegiata di prelievo erariale verso il settore agricolo, non lascia dubbi su quella che anche per il futuro dovrà rappresentare la modalità preponderante per le imprese agricole di partecipazione alla spesa pubblica.
Nei fatti questa metodologia appare sempre meno ancorata al settore primario e sempre più esplosa anche verso altre categorie di contribuenti; parlare oggi di "catastalizzazione" del reddito o dei ricavi corrisponde ad una dato di fatto, visto che anche per le imprese commerciali e per i professionisti, seppur in termini più evoluti e dinamici, le modalità di accertamento, e dunque di definizione di una sorta di reddito convenzionale, basate sull'applicazione degli studi di settore e dei parametri rispondono ad una logica simile a quella che ha ispirato la definizione e determinazione del reddito agricolo, quale reddito medio ordinario.
Indubbiamente occorre definire modalità diverse nell'utilizzo del sistema catastale, trattandosi di uno strumento eccessivamente statico e per questo talvolta dannoso per le sperequazioni che potrebbe provocare nei confronti degli agricoltori; esso necessità di essere impiegato in modo dinamico cosicché riesca a recuperare il dato reale legato all'effettiva utilizzazione del terreno in ragione della sua concreta destinazione.
Si tratta comunque di un sistema che risponde a prerogative essenziali per l'impresa, quali quelle legate alla semplificazione del processo, alle certezza e determinabilità puntuale del prelievo ed alla sua sopportabilità.
Il riferimento ai soli imprenditori individuali ed alle società semplici quali destinatari del regime catastale, trova la sua ragion d'essere nelle caratteristiche e nelle peculiarità dei soggetti stessi, con le parti escluse che per tipologia e prerogative troverebbero non giustificata una metodologia di determinazione della propria capacità contributiva diversa da quella attuale; non da meno per i pruni andrebbe prevista una flessibilità del sistema catastale in rapporto alla diversa redditività dell'impresa stessa.
Ancora nei confronti delle imprese individuali e delle società semplici, pur limitandone (applicazione a quelle realtà con volume di affari superiore ad rara determinato limite, serve prevedere la possibilità di opzione per la determinazione del reddito nei modi normali in modo da consentire ad un numero nutrito di imprese agricole di beneficiare di possibili e probabili vantaggi legati ad una minore redditività rispetto a quella definita convenzionalmente oppure a specifiche agevolazioni.
La sopportabilità della pressione fiscale risente oggi della diversificata allocazione delle fonti di prelievo; al tradizionale prelievo erariale oramai si e stabilmente affiancato e in talune situazioni sovrapposto quello locale.
L'introduzione prima dell'Imposta comunale sugli immobili, poi dell'imposta regionale sulle attività produttive, per poi proseguire con le varie addizionali comunali e regionali, con la Tarsu, con altre imposte, tasse, tariffe ed altro, di fatto ha spostato molto il baricentro della fiscalità, prima assolutamente statocentrica, oggi più marcatamente localcentrica. La stessa Finanziaria per il 2005 né rappresenta la prova più tangibile.
In tal senso si avvertono una serie di rischi; il primo dei quali e riferito alla eccessiva burocratizzazione nei rapporti e degli adempimenti, a cui si aggiunge il timore pus un inasprimento del prelievo fiscale, in particolare in quelle realtà territoriali maggiormente penalizzate da una ridotta retrocessione delle risorse da parte dello Stato.
Appare fondato pensare ad un allargamento della forbice fra le diverse realtà del nostro territorio, dove il divario rischia di accentuarsi in modo proporzionato rispetto alle risorse che le entità territoriale sono in grado di recuperare attraverso la fiscalità locale; in tal senso occorre dunque che venga salvaguardo il principio di solidarietà su cui il nostro Stato di diritto fino ad ora ha fondato il suo tratto distintivo.
Va evitata qualsiasi scelta o decisione che contrasti con questo principio, diversamente avremo soprattutto le realtà a forte vocazione rurale, con una densità demografica ridotta e con una capacità contributiva mediamente inferiore alle altre categorie a pagarne le conseguenze maggiori; minori entrate per le Amministrazioni locali significa infatti minore possibilità di erogare prestazioni sociali a favore essenzialmente di categorie meno abbienti.
Non va inoltre trascurato un altro elemento di criticità in questo caso di natura economici una contribuzione diffusa e significativa consente di adottare misure tese a ridurre il prelievo fiscale, cosa che viceversa non è possibile in caso di prelievo ridotto, con la conseguenza che taluni produttori di ricchezza (imprese, professionisti, lavoratori dipendenti) potrebbero essere indotti a delocalizzare la propria produzione ed attività a favore di quelle realtà "più ospitali", cosa che non è consentita, nella quasi totalità dei casi, all'agricoltore,
E dunque fattore di competitività è la fiscalità nel suo complesso, abbandonando quindi lo stereotipa riferito alla sola fiscalità erariale; ci si attende che complessivamente essa sia equa, determinata, sostenibile, certa.
La certezza del diritto differita al sistema tributario, e perciò quale sistema delle regole, rappresenta uno degli anelli deboli al cospetto dell'impresa; questa per essere competitiva ha bisogno di programmare investimenti, azioni, iniziative, processi. Una situazione aleatoria come quella che vede coinvolte determinate imposte e la loro applicazione, indubbiamente non giova al sistema delle imprese agricole.
Il riferimento è alla disciplina IVA con la necessità di superare la stagione delle proroghe e ripristinare in modo strutturale il regime speciale a favore della generalità delle imprese agricole, in armonia peraltro con altri Paesi dell'Unione Europea deve sono previsti analoghi regimi contabili, ed all'Imposta regionale sulle attività produttive per cui si chiede di accelerare il processo di graduale soppressione evitando comunque che questo generi ripercussioni negative verso comparti essenziali del nostro Stato sociale, ed in ogni caso va definitivamente superata la norma transitoria e prevista a regime l'aliquota dell'1,9% che rappresenta l'espressione puntuale dell'invarianza di gettito per il settore agricolo rispetto a quanto versato precedentemente all'entrata in vigore dell'IRAP.
La dinamica del mercato premia la creatività., la ricerca, caparbietà, l'entusiasmo, la capacità imprenditoriale, l'elevato grado di managerialità, tutte qualità che per lo più risiedono in imprenditori giovani.
Alcune statistiche ci indicano che a fronte di oltre 960 mila imprese agricole iscritte al Registro delle imprese, neanche la metà sono soggette alla tenuta della contabilità IVA, mentre oltre il 70% ha un volume di affari non superiore a 50 mila curo, e non meno del 70% degli imprenditori ha un'età non inferiore ai 50 anni, con i giovani con meno di 40 anni che si attestano al di sotto del 15%.
Urgono dunque misure tese ad incentivate ed accelerare il ricambio generazionale, per evitare che l'agricoltura resti al traino di altri settori economici ed emarginata di fronte ad una prospettiva di grandi cambiamenti e di significative opportunità.
" Il sistema del welfare e pensionistico"
L'analisi delle politiche sociali, intese quali interventi di protezione sociale volti a rimediare a condizioni di bisogno degli individui, passa oggi necessariamente attraverso lo studio dei fenomeni che stanno trasformando il modello tradizionale di Welfare. I tre fenomeni, tra loro fortemente connessi, sono sostanzialmente quello della globalizzazione, quello della spinta ad accentuare le condizioni di autonomia degli enti territoriali all'interno degli ordinamenti statali (agisca essa in senso federalista o regionalista) ed, infine, quello dell'integrazione europea.
Negli ultimi anni, lo Stato sociale, così come delineato dalla Costituzione italiana del 1948, ha subito dei profondi mutamenti anche a livello normativo. Il grande disegno previsto dall'Assemblea costituente prevede che sia "compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza tra i cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese" (art.3 Cost., comma secondo).
Tale previsione è stata sensibilmente condizionata dalla recente riforma del titolo V della Costituzione, apportata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. Le novità introdotte con questa incisiva innovazione della Carta Costituzionale, infatti, hanno disegnato un modello nuovo di azione dello Stato sociale, il quale, pur allontanandosi dal modello originario, sembra chiaramente intenzionato a seguirne gli alti scopi, pur con mezzi profondamente diversi.
L'articolo appena menzionato, infatti, deve oggi essere letto in combinato disposto con altre norme della Costituzione. In primo luogo, con l'art. 114, in base al quale "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato". E' chiaro, quindi, che il compito di rimuovere tali ostacoli spetti ad un soggetto, quale è la Repubblica, che non è riconducibile solo allo Stato, ma anche agli altri enti territoriali, cioè ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni. Tali enti territoriali autonomi, quindi, sono chiamati a concorrere alla costruzione del welfare state con la stessa rilevanza giuridica e dignità politica riconosciuta allo Stato.
D'altra parte, ciascun ente, a sua volta, è chiamato ad avvalersi dell'azione dei privati. Come recita l'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, infatti, " Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Dunque, a ciascuno dei soggetti che compongono la Repubblica spetta l'onere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociali che si frappongono alla libertà ed eguaglianza dei consociati e, nel farlo sono chiamati ad avvalersi del principio di sussidiarietà orizzontale.
Il quadro normativo costituzionale, inoltre, si compone delle disposizioni riguardanti i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali". Nella graduazione progressiva dell'incidenza dell'intervento sociale, infatti, il legislatore costituzionale nel 2001 ha effettuato una ripartizione tra lo Stato e le singole Regioni. Come recita l'art. 117 della Costituzione (comma secondo, lettera p), spetta allo Stato la determinazione di tali livelli essenziali, mentre spetterebbe alle singole Regioni decidere di fornire (o non fornire) e come farlo tutte quelle prestazioni che concernono livelli superiori a quelli essenziali, fino, in teoria, a coprire i livelli massimi delle prestazioni.
Quello che si ricava dalla lettura complessiva delle disposizioni costituzionali inerenti lo Stato sociale, dunque, è che oggi il "welfare state" è un sistema complesso ed articolato nel quale sono chiamati a svolgere un ruolo significativo, sia le autorità pubbliche, centrali e locali, sia i privati.
Tale complessità si traduce anche in una occasione di differenziazione delle prestazioni dello stato sociale in riferimento alle diverse aree del paese sulle quali è chiamato ad operare. Una volta stabilite (e tutelate) le prestazioni concernenti i livelli essenziali, infatti, in ciascuna zona l'intervento degli altri enti potrebbe articolarsi nel senso delle specifiche richieste che da quel territorio emergono. Qui, dunque, si apre un grande spazio che è compito del welfare locale riempire.
D'altra parte, la stesse legge n. 328 del 2000 aveva disegnato uno scenario convergente con quanto appena descritto. Come si legge all'art. 1 della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce, le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia".
Proprio nella legge adottata nel 2000 è forte e caratterizzante sia l'idea di un sistema sociale costruito con il contributo di diversi attori (pubblici, privati e del "terzo settore"), sia l'attenzione al coinvolgimento degli enti territoriali diversi dallo Stato, quali le Regioni, le Province ed i Comuni con il metodo della programmazione, che pone in stretto contatto risorse ed interventi. Spetta alle Regioni, nell'ambito del piano triennale nazionale, l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, coadiuvata dai Comuni e Province che a tali attività concorrono la stessa Legge del 2000 si preoccupò di definire il contenuto dei livelli essenziali (art.22), aprendo la strada all'approccio sistemico ora previsto in Costituzione.
Venendo nello specifico al settore della previdenza sociale, anche in riferimento ad esso la Costituzione prevede compiti diversi per lo Stato e per le Regioni. Come si legge sempre all'art. 117 della nostra Carta fondamentale, infatti, la materia " previdenza sociale" figura tra le materie sottoposte alla competenza esclusiva della legge statale, senza che vi possa essere margine di intervento per le Regioni. In realtà esse recuperano un ruolo in questo settore, poiché al comma successivo dello stesso articolo si legge che la materia " previdenza complementare ed integrativa" rientra tra quelle sottoposte alla potestà concorrente tra lo Stato e le Regioni. Nelle materie concorrenti, come è noto, spetta alla legge dello Stato porre i principi, mentre le norme di dettaglio sono riservate alle Regioni.
Il sistema previdenziale italiano non brilla certo per equilibrio ed equità fra le varie gestioni e fra i lavoratori assicurati. Il caso agricoltura è originato proprio dal problema dell'equità, delle contribuzioni prima e delle prestazioni pensionistiche poi. In tal senso, il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo nulla ha innovato. Una riforma dovrebbe rappresentare l'occasione per recuperare parte delle disuguaglianze e delle discriminazioni,ma sulla previdenza fino ad oggi ciò non è accaduto. Osservando l'andamento della discussione e del confronto, ci accorgiamo subito che anche in questa occasione non sarà così, anzi rischiamo seriamente che sul secondo pilastro, la tanto invocata previdenza complementare, si trasferiscano le pecche della previdenza obbligatoria. La gestione dei lavoratori agricoli autonomi all'interno dell'Inps è caratterizzata da sempre da un deficit di bilancio, pur essendo le pensioni dei coltivatori diretti le più basse in assoluto. Tali pensioni fino al 1990 sono risultate sempre inferiori al trattamento minimo e successivamente superiori al minimo solo per pochi. Si potrebbe facilmente pensare ad una gestione scellerata, ma non è assolutamente così. Il settore paga a caro prezzo la riduzione continua degli addetti e le scelte politiche nazionali dirette ad una imponente industrializzazione. La conseguenza è che il rapporto si è fortemente sbilanciato e che i titolari di prestazioni superano per numero i lavoratori iscritti alla gestione (rapporto di 3 a 1). Non solo, ad appesantire ulteriormente la situazione concorrono due problemi specifici:
1) Allargamento della platea a figure miste (soprattutto al sud), un problema per il quale chiediamo da sempre una soluzione restando inascoltati;
2) La rigidità del sistema di contribuzione, che non consente a chi può di pagare di più, per avere domani una pensione più dignitosa;
In agricoltura risultano attive circa 1.200.000 partita IVA, di cui, 1.000.000 riguardano aziende iscritte anche al registro imprese della Camera di Commercio. Le posizioni previdenziali aperte presso l'INPS però sono solo 600.000, in virtù di un obbligo che vige solo per coloro che svolgono l'attività in maniera prevalente e continuativa.
Solo allargando la platea possiamo pensare a realizzare maggiori entrate ed il tal sensosono individuabilisei aspetti da prendere in considerazione per realizzare l'obiettivo posto in discussione.
1) conduzione di aziende agricole in maniera non prevalente;
2) collaborazione alla conduzione da parte di familiari occasionali;
3) attività svolta dalle cosiddette figure miste;
4) conduzione da parte di società;
5) famiglie di fatto;
6) contoterzismo agricolo.
Intervenire sulla previdenza agricolatenendo conto dei sei punti di cui sopra, determinerebbe un sostanziale ampliamento della platea, interessando soggetti che effettivamente operano nel settore. Si realizzerebbe inoltre un importante passo avanti, in direzione dell'equità, delle pari opportunità e della dignità della categoria. Riteniamo importante che, anche soggetti che guardano all'agricoltura in maniera non esclusiva, contribuiscano alla crescita della gestione. Per costoro, pur avendo diritto alla pensione in altra gestione , l'iscrizione rappresenterebbe comunque una integrazione della misura della stessa e quindi un beneficio tangibile.
Risolvere il problema delle figure miste significherebbe oltre ad ampliare la platea degli iscritti, alleggerire la gestione dei lavoratori agricoli dipendenti, ottenendo anche una forte diminuzione del ricorso alle indennità di disoccupazione. Occorre però il coraggio di una scelta forte, che consenta la regolarizzazione in prospettiva futura, chiudendo gli occhi sul passato. Infatti, fino a che sui potenziali soggetti regolarizzabili, penderà la spada di damocle dei possibili recuperi retroattivi, con la conseguente perdita del diritto a prestazioni di disoccupazione già percepite e notifica di indebiti per il loro recupero, tali soggetti non emergeranno mai. Più complesso ancora il discorso sulla rigidità del sistema.
Dopo oltre 30 anni di gestione a contribuzione fissa uguale per tutti e prestazioni altrettanto fisse, uguali e mai superiori al minimo neanche con 35 anni di anzianità, con la legge 233/90 si sono fatti alcuni passi in avanti, senza tuttavia risolvere il problema.
L'introduzione delle fasce contributive, delle retribuzioni convenzionali e del calcolo di pensione in pro-rata, hanno apportato benefici sulle pensioni di anzianità. I benefici però si sono ben presto rivelati notevolmente inferiori agli aumenti contributivi, eppure la gestione per i motivi che prima citavo continua a restare deficitaria in maniera sostanziale. Oggi non possiamo negare che una parte delle pensioni agricole superano il trattamento minimo, né che la presenza di contributi agricoli autonomi nella carriera lavorativa grazie al meccanismo del pro-rata per i singoli periodi lavorativi, non penalizza più il calcolo della pensione.
Tuttavia siamo ancora lontani da un ragionamento equo. Ancora oggi un coltivatore diretto collocato in prima fascia (sono la maggioranza degli iscritti), che possa vantare 40 anni di anzianità contributiva, non supera l'importo del trattamento minimo, pur essendo i suoi versamenti dal 90 ad oggi aumentati del 200% ovvero triplicati.
Coloro che invece fin dal 1990 si collocavano nelle fasce superiori, beneficiando del miglioramento di fascia per tutta la carriera lavorativa, con 35 anni di contributi, ricevono una pensione superiore al trattamento minimo. Per ottenere però un beneficio consistente occorre essere collocati in quarta fascia , con una aumento dei contributi versati che arriva al 500%. Come si vede non c'è confronto fra gli aumenti contributivi e quelli pensionistici.
Peraltro il riconoscimento dei benefici di fascia anche sui periodi precedenti al 90 ha creato una assurda discriminazione: periodi nei quali tutti avevano pagato gli stessi contributi hanno assunto un valore diverso. Coincidendo la riforma con i 35 anni dall'istituzione della gestione, ad alcuni è bastato pagare per un solo anno con il nuovo sistema per avere una pensione migliore rispetto a quella di molti altri colleghi e ciò, - consentitemi il termine - è anomalo e curioso.
Il problema principale comunque resta la rigidità del sistema. Le quattro fasce sono ancorate ad un unico parametro: il reddito agrario. La redditività di un'azienda moderna invece non è più legata a tale reddito, bensì agli investimenti effettuati e alla capacità imprenditoriale del titolare dell'azienda, pertanto a parità di reddito agrario, il reddito effettivo può cambiare radicalmente e con esso ovviamente cambia la capacità di contribuzione. Ci troviamo così di fronte a due casistiche opposte:
1) L'azienda è collocata in una fascia contributiva che l'agricoltore non può sostenere;
2) L'agricoltore ha un reddito che gli consentirebbe una contribuzione maggiore e di conseguenza una pensione maggiore, ma il sistema glielo impedisce, salvo per alcuni più giovani che possono almeno optare per la fascia superiore a quella cui è inquadrata l'azienda;
Queste considerazioni, inducono a sostenere che occorrono nuove modifiche in grado di dare respiro al sistema, renderlo sostenibile per chi ha redditi bassi e aumentare le entrate aumentando la contribuzione di chi ha redditi più alti. Le fasce possono essere mantenute, magari riducendole per eliminazione di quelle a maggiore contribuzione, in modo da mantenere ai livelli più bassi la contribuzione minima che tutti gli iscritti devono versare. Vanno però individuati ed affiancati alle fasce altri criteri per il versamento di contributi percentuali, come già accade per artigiani e commercianti. Il parametro di riferimento potrebbe essere il reddito netto ai fini Irap, ovviamente quando questo supera le soglie di retribuzione convenzionale coperte dalla contribuzione minima della fascia di appartenenza. Parallelamente occorre riconoscere non a parole ma nei fatti l'anomalia di una gestione sovraccarica di problemi del passato. Problemi come prima dicevo, derivati dalle scelte politiche del nostro paese e dal conseguente esodo dalle campagne di soggetti che successivamente pensionandosi sono stati posti a carico della gestione. Gli oneri provenienti dal passato devono essere separati dalla gestione corrente e posti a carico del bilancio dello stato, consentendo così un riequilibrio fra iscritti attivi e pensionati, rispondente alla reale situazione dell'agricoltura italiana.
Non ci convince l'idea di una previdenza complementare basata sul trasferimento obbligatorio del TFR, se prima non si definiscono bene i parametri di compensazione per le imprese e di rendimento per i lavoratori. IL trasferimento ai fondi pensione del TFR non convince nessuno: non convince le imprese che si vedono sottrarre nell'immediato risorse economiche; non convince i lavoratori che vedono trasformarsi una risorsa certa incassata interamente al momento del pensionamento, in una risorsa dal rendimento incerto e per di più incassata in forma dilazionata; non convince il mondo del lavoro autonomo che non ha il TFR su cui discutere. Il mondo del lavoro autonomo attende quindi di sapere come la previdenza complementare si cala al suo interno. Per i lavoratori autonomi una cosa è certa: per finanziare la previdenza complementare devono reperire risorse proprie, rinunciare nell'immediato ad ulteriore liquidità oppure restarne fuori. Per questo la vera leva per il decollo dei fondi pensione sta nella defiscalizzazione e nella garanzia di stabilità. Se gli incentivi fiscali sono appetibili e purtroppo oggi non lo sono, i fondi possono attrarre risorse, altrimenti se ne continuerà a discutere ed i lavoratori continueranno a snobbarli. Quanto alle garanzie di stabilità, oggi non ve ne sono, tutto è affidato al mercato privato che si è dimostrato volatile e incerto. Il governo se vuole veramente far decollare la previdenza complementare e noi siamo convinti che debba essere così deve accettare un confronto serio e aperto.
Occorrono garanzie sul recupero del capitale investito e rendimenti minimi prefissati. Non si tratta di questioni impossibili, bensì di meccanismi che altre forme di investimento privato già offrono. Complessivamente quindi le modificazioni del sistema previdenziale ed il passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo per il mondo agricolo ha complicato una situazione già abbastanza critica. L'abbassamento del tasso di sostituzione in un settore dalla pensioni già poco consistenti e soprattutto il superamento dell'integrazione al trattamento minimo, che fino ad oggi ha garantito comunque una prestazione certa destabilizzano la gestione creando forti preoccupazioni. Se a ciò aggiungiamo l'impossibilità di inserirsi in sistema di previdenza complementare dai costi troppo alti per il settore, si giunge ad una unica conclusione: per evitare nel futuro la comparsa di un vero e proprio problema sociale degli ex agricoltori, oggi occorre fare di più.
In questo quadro occorre prima ancora di entrare nel merito della riforma dello Stato sociale definire un primo punto della discussione.
Sedi e soggetti della concertazione.
Questo punto è di forma (se vogliamo, possiamo anche dire che è un profilo procedurale) ma, allo stesso tempo è un profilo sostanziale.
Non possiamo permetterci il lusso di lasciare che il dibattito sulla riforma delle politiche sociali sia svolto negli stessi modi e con gli stessi soggetti di venti, trenta o addirittura quaranta anni fa. Con ciò si fa riferimento sia alle sedi dove si svolge il metodo della concertazione, sia ai soggetti che siedono alle prime fila di quei tavoli.
Ciclicamente, infatti, i sindacati ed il Governo nazionale si incontrano nelle stanze del potere centrale e si confrontano. La parte dei leoni, come sappiamo, è giocata, all'interno della rappresentanza sociale, dai sindacati dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
Queste procedure e questi metodi della concertazione devono essere radicalmente aggiornati perché è mutato in maniera evidente il contesto sociale per il quale, in quelle riunioni, si cercano nuove politiche.
Iniziando dal primo dei due aspetti, occorre dunque superare l'idea, generalmente accettata da quasi tutte le forze politiche, che la sede della concertazione sia esclusivamente quella del Governo centrale. Tuttavia, come è noto, non è così semplice, anzi le politiche sociali oggi sono investite da fenomeni di complessità come la legge n. 328 del 2000 ha ben colto.
Questa necessaria riforma organizzativa, d'altro canto, non è solo richiesta dalla strutturazione multilivello delle politiche sociali e dall'affermazione delle logiche federaliste, ma è anche l'unico vero strumento con il quale si possa subito dare una risposta alla crisi della rappresentanza che investe il Paese.
La classe dirigente dei sindacati e delle organizzazioni professionali, in questo modo, sarebbe il vero canale di semplificazione e rappresentanza degli interessi del territorio, di ciascuna realtà, delle sue peculiarità e delle sue esigenze sociali. Le esigenze del territorio e la logica della partecipazione alle scelte sociali ne beneficerebbe, le scelte sociali stesse accrescerebbero le loro capacità risolutive.
Per quanto riguarda, poi, i soggetti della trattativa tra le rappresentanze degli interessi e gli organi di governo, occorre togliere l'egemonia della discussione sul Welfare ai sindacati dei lavoratori dipendenti; sia chiaro, non si propone di estromettere soggetti importanti del panorama sindacale del Paese, tantomeno, di allontanare dai tavoli della concertazione gli interessi rappresentati da quegli stessi soggetti.
Quello che occorre fare è recuperare una dimensione di "complessità degli interessi", senza che nessuno possa monopolizzarli, né, tantomeno ridurre tale complessità.
Come sottolinea in un bel libro, recentemente tradotto in Italia, il filosofo francese André Gorz, le trasformazioni delle economie occidentali stanno riducendo sensibilmente il ruolo del lavoro salariato, mentre sempre di più ciascuno di noi è "imprenditore di se stesso" all'interno di un'economia della conoscenza.
Il concetto di lavoratore salariato si è trasformato, poiché sempre di più ciascuno sente su di se il peso della sua forza lavorativa. Bisogna, quindi, far emergere nella discussione sulle politiche sociali anche il disegno di stato sociale quale richiesto dai lavoratori autonomi.
Non dimentichiamoci, poi, che alcuni degli interessi che sono recentemente sorti nella realtà sociale hanno difficoltà ad essere rappresentati. Chi rappresenta le future generazioni che non avranno né domani una pensione dal sistema pubblico, né tantomeno hanno oggi le borse di studio e gli incentivi alla formazione?
Formazione ed accrescimento del capitale umano
La formazione, appunto: è questo il vero, forte e determinante perno del sistema sociale del prossimo millennio. Il cittadino (per essere un lavoratore protetto) deve essere messo nella condizione di accedere alle forme del sapere culturale e professione, deve poter contare sulla disponibilità di tempo per formarsi e rimanere formato durante gli anni. Ecco perché occorre, in primo luogo, liberare risorse per le politiche sociali della formazione giovanile e d'ingresso al mercato del lavoro.
Ma non basta, non è così semplice. Se il cittadino deve essere messo nelle condizioni di crescere e competere, allo stesso tempo deve potersi muovere con sicurezza, perché è sicuro che se cade sotto di lui c'è una rete che lo protegge: una rete di politiche sociali che è "normalmente" sotto di lui.
Un Welfare a rete per tutti che combatte l'eredità dello svantaggio
Questa logica trasforma il concetto stesso di stato sociale. Il nuovo Welfare, infatti, deve essere allo stesso tempo sociale e liberale. Sociale, nella misura in cui include un numero maggiore di soggetti tra i destinatari delle proprie politiche; esso si configura come un welfare della normalità, cioè un sistema sociale che si rivolge a tutti, senza essere proiettato su di una categoria specifica (di lavoratori, di età, di sesso). Esso deve permettere a ciascuno di formarsi, di occuparsi e di continuare a formarsi sia nei periodi nei quali è occupato sia in quelli nei quali non è soggetto ad un rapporto di lavoro. Pensiamo la tema dell'eredità sociale dello svantaggio. Cosa significa questa espressione?
Significa che non ci sarà più eredità sociale di svantaggio quando un giovane potrà avere accesso al sapere indipendentemente dalla sua estrazione sociale, dal contesto culturale e dal luogo di nascita.
Le nuove povertà
Un nuovo welfare, dunque, è necessario anche perché nuove sono le situazioni che richiedono un intervento delle politiche sociali. In primo luogo le nuove povertà, quali quelle nelle quali si trovano, gli anziani non autosufficienti e le donne sole con figli a carico ed un solo reddito. Il Welfare della normalità, infatti, non deve perdere di vista la povertà, ossia i momenti nei quali si rompe il rapporto tra il singolo e la socialità.
Perdere la dimensione sociale, infatti, porta fuori dal sistema di protezione costruito nella complessità. Ecco dunque che in questo caso devono funzionare i meccanismi di inclusione che, agendo sui fattori di esclusione, rendano i nuovi poveri di nuovo membri del patto sociale.
Il caso degli anziani soli che vivono in condizioni di non autosufficienza sono un esempio drammatico e violento di queste nuove povertà. Come rispondere a questa emersione di nuovi bisogni? Includendoli di nuovo, sia garantendone il reddito, sia attivandoli, cioè facendoli promotori di attività di interesse sociale. Inoltre, integrazione potrebbe anche voler dire ricreare un ambiente famigliare intorno a loro, ad esempio permettendogli di affittare una stanza a giovani studenti, chiedergli di vigilare le scuole e così via. L'importante è ridargli il senso di appartenenza al patto sociale e alla rete di socialità protettiva.
In sintesi questa può essere l'analisi con le relative proposte:
1) Una rete di servizi sociali per lo sviluppo delle aree rurali.
2) Esigenze delle imprese agricole in un quadro di crescita della competitività: politiche fiscali, welfare, sistema pensionistico.
Prendendo le mosse dal V° Censimento generale dell'agricoltura (2000), il CNEL ha affidato all'Istituto nazionale di sociologia rurale, INSOR, un lavoro prezioso di lettura e di analisi dell'agricoltura italiana tra passato e futuro.
Il rapporto dal titolo "Capitale umano e stratificazione nell'Italia agricola" è stato presentato circa un anno fa.
Ad esso facciamo utilmente riferimento per ancorare, in modo aggiornato, le politiche pubbliche, fiscali, previdenziali e sociali ai soggetti sociali che vivono ed operano nei contesti agricoli e rurali.
1990-2000
Meno SAU; meno giornate lavorative (-27,6%); il part-time perde slancio; permane la frammentazione fondiaria e la polverizzazione delle aziende agricole. Crescono di peso le aziende a condizione diretta 81,3% della SAU e 87% della PLV. Si è arrestato il processo di concentrazione produttiva.
Scarsa attrazione del settore verso i giovani.
Continua l'avanzata dell'impresa al femminile: nel 2000 le imprese dirette da donne sono oltre il 30% del totale.
Prosegue il progressivo invecchiamento degli addetti nel 1990, 55.000 aziende avevano almeno un giovane impegnato a tempo pieno; nel 2000 sono ridotte a 29.000.
I giovani si sono ritirati dalle attività di allevamento, per contro aumentano la presenza nella viticoltura e nella olivicoltura.
Alla data del censimento 2000 oltre 3 milioni e mezzo di ettari SAU erano in mano ad imprenditori ultrasessantenni senza successori palesi.
Un progetto per la competitività dell'impresa agricola e per la valorizzazione del territorio implica politiche che non sono penalizzanti per il fattore lavoro, anzi serve innovazione, qualificazione delle strategie di offerta e sviluppo delle economie di rete.
I servizi alla persona costituiscono un fattore di qualità sociale che contribuisce alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo delle attività produttive e migliora la competitività delle imprese e del sistema produttivo.
In Italia la spesa sociale e quella sanitaria sono inferiori alla media europea; dal 1981 la spesa pro-capite per gli anziani è in diminuzione.
Se l'orizzonte di riferimento è l'Agenda di Lisbona dobbiamo immaginare che politica economica, politica per l'occupazione e politica sociale costituiscono i tre lati di un triangolo.
La spesa per le politiche sociali va considerata complementare a quella per le politiche di sviluppo.
Una spesa sociale da ristrutturare e da rinnovare.
Vanno aumentate le risorse sul PIL impiegandole verso il welfare, la sanità, la scuola e il lavoro che costituiscono il volano per la ripresa e lo sviluppo economico.
Questo implica una convergenza e una coerenza tra politiche sociali e politica fiscale.
Le moderne politiche di welfare in ambito europeo e, in particolare, quelle delineate in Italia sulla base della riforma del titolo V della Costituzione e della <a href="http://l.n.328/2000,">L. n. 328/2000,</a> si configurano come politiche di "protezione sociale attiva" (luogo di esercizio dei diritti di cittadinanza).
Politiche sociali che tendono ad integrarsi e coordinarsi con le politiche sanitarie, della formazione e del lavoro.
Politiche non centralistiche, ma che hanno come sfondo la possibile costruzione dell'Europa sociale e si articolano secondo un modello di "governance" a più livelli: nazionale, regionale, locale e richiedono, per essere attuate, il metodo della sussidiarietà e della condivisione di soggetti pubblici e privati sia nella fase della programmazione che in quella dell'attuazione.
Gli agricoltori italiani, per le peculiarità della loro storia e per le caratteristiche socioeconomiche che sono state richiamate, sono protagonisti "paradigmatici" di un'idea del sociale.
Essi rappresentano in modo compiuto con la loro stessa presenza e con la loro attività responsabilità sociale, legame con il territorio, senso di coesione.
Essi sono soggetti fondamentali per incardinare moderne politiche sociali che si propongono di riorganizzare il territorio sulla base di un modello universalistico, partendo dalle esigenze del cittadino e delle comunità.
Politiche sociali che si propongono di recuperare il valore della solidarietà, delle reti di relazione, delle identità comunitarie in contrapposizione all'individualismo, al liberismo, all'atomizzazione sociale che caratterizza una società di meri consumatori.
Gli elementi fin qui evidenziati portano a sostenere la necessità di alcuni provvedimenti essenziali che sono:
- l'adeguamento dei minimi di pensione ai 516,46 euro innalzando i massimali di esclusione previsti dalla normativa: la rivalutazione dei contributi versati al fine di poter favorire la maturazione di pensioni anche superiori ai minimi nel caso di carriere contributive particolarmente lunghe, favorendo così anche la possibilità che chi continua ad essere assicurato anche dopo il pensionamento possa vedere migliorata la propria pensione;
- l'adeguamento degli assegni al nucleo familiare a quello degli altri lavoratori eliminando una pesante ed ingiustificata discriminazione; il riconoscimento dei contributi figurativi, anche attraverso appositi versamenti degli interessati, delle donne a cui negli anni 60 e 70 sono state accreditate solo 104 giornate e non 156 come agli uomini;
- la definizione di un meccanismo, anche per l'INAIL, ed il pagamento di una quota ridotta nel caso dei pensionati che continuano a lavorare in quanto, è vero che il rischio infortuni per gli anziani è maggiore, ma è anche vero che il numero di giornate svolte è di gran lunga inferiore; (oltre l'80 con attività inferiore alle 100 giornate).
La realizzazione di una politica di servizi sociali nelle campagne in grado di eliminare le forti disuguaglianze attualmente esistenti. Questa politica può essere realizzata attraverso una serie di azioni:
- riconoscendo la possibilità di centri multiservizi come previsto dalla proposta di Legge sui piccoli Comuni;
- la possibilità alle Organizzazioni agricole di gestire determinati servizi, realizzando la sussidiarietà, anche attraverso l'attivazione del volontariato.
Sfide difficili ed idee chiare
Se dovessimo semplificare, ulteriormente, potremmo dire che davanti a queste idee difficili occorre avere idee chiare, lenti funzionanti con le quali leggere i fenomeni di trasformazione.
Queste idee sono: partecipazione, inclusione, normalità, formazione e sicurezza.