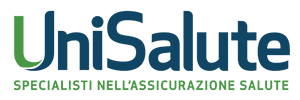27 Ottobre 2005
Tavola rotonda "Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia". L'intervento di Alberto Giombetti
Archivio
Condividi
Nei giorni scorsi si è svolta a Macerata una tavola rotonda sul tema "Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia". All'incontro è intervenuto Alberto Giombetti, presidente nazionale del Patronato Inac e responsabile dell'Area del Sociale e dell'Inclusione della Cia. Di seguito riportiamo una sintesi dell'intervento.
Ringrazio il prof. Francesco Adornato e l'università di Macerata in tutte le sue articolazioni per aver organizzato questo importante appuntamento di riflessione sulla nota mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia.Il 1492 non è soltanto l'anno della scoperta dell'America ma è anche l'anno in cui Macerata prima di ogni altra città del centro Italia si costituì per opera di una Confraternita il "Monte Frumentario".
Il Monte Frumentario è il deposito di una notevole quantità di cereali (specialmente grano e granoturco) da tenersi in serbo nei momenti di più grande bisogno. Tale scelta avveniva quasi periodicamente nei mesi che di poco precedevano la semina, quando i piccoli contadini – sempre famiglie molto numerose e di scarse risorse si erano consumati non solo tutte le quantità disponibili del raccolto dell'anno precedente, ma perfino quella quantità che doveva servire per la semina. Allora si aprivano i magazzini di quei Monti e si prestava ai coltivatori tanto grano quanto ne occorreva per tale bisogno. Il prestito era fatto al massimo favore, cioè pagando solo le spese per il magazzinaggio e la custodia. Il primo grano del nuovo raccolto doveva essere consegnato al Monte, nella stessa quantità ricevuta in prestito. Poteva accadere che o la scarsità del raccolto nuovo fosse così "paurosa" da non potersi pretendere la restituzione integrale, o che le condizioni del mutuatario si fossero tanto peggiorate che sarebbe stata crudeltà demandare la totale restituzione. In tal caso, le autorità provvedevano obbligando i proprietari terrieri ad integrare il deposito primitivo, supplendo per quella parte che non si era potuto recuperare. Così, la riserva disponibile era sempre integra e pronta al bisogno, anno per anno.
Poi, in questa splendida Regione, le Marche, per fare un altro esempio, basta pensare, ai monaci Camaldolesi che vivono nell'eremo di Fonte Avellana e al loro ruolo decisivo nella coltura e governo dei boschi, infatti il primo trattato sulla forestazione è opera di un frate camaldolese così come pure la prima carta geografica è stata disegnata da un camaldolese di Fonte Avellana, che passò gli ultimi anni della sua vita nella prigione dei Piombi a Venezia per non aver esaudito le richieste del Doge che voleva Venezia più in evidenza nella carta da lui disegnata del mondo allora conosciuto.
Questi brevi richiami alla storia della città e Regione ospitante mi servono per riannodare il filo del rapporto tra chiesa e società, tra chiesa e conflitti sociali, tra chiesa e internazionalizzazione e la capacità della chiesa di governarli.
La Cia ha recentemente lanciato la proposta di "Un nuovo patto tra agricoltura e società" attraverso il quale si ridefiniscano funzioni e missioni della nostra agricoltura, e con esso diritti e doveri reciproci.
Tutto ciò nella presunzione di un irriducibile ruolo dello spazio rurale anche, e soprattutto, nelle avanzate società moderne come la nostra.
La Cia sta, dunque, dibattendo e non solo dibattendo, ma proponendo e lottando, sullo stesso terreno su cui si sta interrogando la Chiesa cattolica.
È superfluo osservare quanto per la Cia sia decisivo che l'alto magistero della Chiesa vada svolgendo la sua ricerca su un'area di problematiche e di interrogativi del tutto analoghi alla sua.
Confortante che parametri e valori di riferimento di questa ricerca siano gli stessi che motivano e muovono la Cia.
La cosa ci dà speranza perché con così tanta condivisione lo spazio rurale e la popolazione in esso insediata non hanno che da trovare auspici positivi.
Il punto di riferimento e di partenza ineludibile è il giudizio che si pronuncia intorno al fenomeno che oggi va sotto il nome di globalizzazione.
La mia opinione, su questo tema, è che lentamente stia giungendo a compimento la visione universalistica del cristianesimo e, più propriamente, del cattolicesimo.
E' col cristianesimo che si esce fuori da ogni popolo di Dio e tutta l'umanità diventa popolo di Dio.
Se la dimensione divina è questa -come presupposto di ogni serio confronto tra religione e laicato- il giudizio sulla globalizzazione non può che essere che quello su una eccezionale occasione di grande incontro tra i popoli e di costruzione della comunità mondiale.
La globalizzazione se valorizza il territorio, le sue pecularietà, le sue tipicità, se non é soltanto omogeneizzazione agli stili di vita del nord del mondo è inclusione, perché la terra include e non esclude.
Non nascondiamoci, tuttavia, che il travaglio sarà ancora doloroso a lungo, che sussulti, conflitti e perfino guerre non mancheranno.
Importante è che qualcuno tenga in mano il filo di coesione per venire a capo di questo processo il cui esito, secondo me, non può che essere che quello annunciato della fratellanza, della giustizia e della liberazione
Questi sono i valori di riferimento della Cia ed essi imprimono il loro segno sulla sua ricerca di un rinnovato e fondamentale ruolo dello spazio rurale nell'epoca della globalizzazione.
La globalizzazione è stata finora dominata della ricerca scientifica, dalla tecnica e dal capitalismo, dalla libera concorrenza e dalla ricerca esclusiva del profitto.
Niente di male se questi sono, e lo sono, i venti di un disegno lanciato sulla terra per abbattere e spezzare via gli egoismi delle etnie e delle razze, dei singoli popoli e delle nazioni.
Tuttavia ciò ha provocato un grande disordine, grandi effetti di spaesamento e di smarrimento, ha inferto ferite profonde.
In particolare ha inferto ferite profonde allo spazio rurale, alle relazioni tra sole, stelle, firmamento e terra (basti pensare all'allargamento del buco dell'ozono e ai grandi cambiamenti climatici) come alle relazioni umane.
Nella sostanza è stata inferta una ferita profonda al concetto di comunità, sia cosmica che umana.
Dalla famiglia alla scuola alle grandi formazioni politiche, nel nostro paese in maniera drammatica, l'individualismo, privatistico ha prevalso sull'individualismo, della persona che è tale perché ha un riferimento alle altre persone in una sostanza etica comune.
Lo spazio rurale, non meno dello spazio urbano, ha subito queste ferite con la fine dell'impresa familiare e conseguente scomparsa dell'azienda appoderata, con la crisi dei borghi, con la rottura di un equilibrato rapporto città – campagna.
Addirittura oggi si mette in dubbio la stessa possibilità di uno spazio rurale antropizzato, quasi che un paese possa sopravvivere all'incuria in cui verrebbe a trovarsi l'insieme dei rapporti tra la terra ed il cielo.
La Chiesa fa bene a richiamare il forte ed insostituibile valore metaforico e, ancora più che metaforico, simbolico di termini come acqua, vino, pane, olio che accompagnano la nostra vita dalla nascita alla morte.
E', in generale, il terreno della comunità che va di nuovo dissodato ma, accanto ed insieme, quello della liberazione.
Lo spazio rurale ricordando la tradizione ma "proiettandosi nel futuro" è irrinunciabile, prezioso bene che non può mancare ad un paese ancor più se moderno.
Per questo la nuova Pac dovrà mettere al centro la ruralità, nella concezione di Delors, cioè integrazione tra agricoltura artigianato, commercio, territorio e ambiente superando la vecchia concezione della vecchia politica agricola che ha privilegiato il capitale rispetto al lavoro e ci dovrà riportare ad un rinnovato rapporto tra uomo e territorio, tra impresa e socialità, tra prodotti tipici e cultura millenaria e tra tutto questo e la internazionalizzazione di mercati.
La Cia è disposta a lavorare con la Chiesa, con le sue parrocchie nel territorio, se esse saranno capaci di "intessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini" come recita la nota pastorale.
Si tratta però, e la nota pastorale lo dice con chiarezza, di evitare nostalgie, sogni di ritorno al passato peraltro ingiusti rispetto ai nuovi livelli di affratellamento umano che oggi sono possibili.
Si tratta di riannodare, in maniera nuova e moderna, i rapporti generazionali, sessuali, tra gli abitanti della città e quelli delle campagne, di tessere la rete dell'accoglienza per gli immigrati e per il disagio sociale.
Ciò va fatto, i tempi sono maturi, il disorientamento delle genti lo reclama, riattrezzando in ogni senso, utilizzando la scienza e la tecnica moderna, lo spazio rurale.
L'importante però è che la fede non sia solo in una Autorità, ma anche nella sua promessa, che sempre si rinnova, di una nuova terra.
L'Italia, il nostro paese, ha bisogno di questa dimensione dello spazio. Questo il senso del Nuovo patto che la Cia propone di sottoscrive tra agricoltori e società. E' per questo che essa si rivolge non ai consumatori ma ai cittadini.
Nei giorni scorsi si è svolta a Macerata una tavola rotonda sul tema "Mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia". All'incontro è intervenuto Alberto Giombetti, presidente nazionale del Patronato Inac e responsabile dell'Area del Sociale e dell'Inclusione della Cia. Di seguito riportiamo una sintesi dell'intervento.
Ringrazio il prof. Francesco Adornato e l'università di Macerata in tutte le sue articolazioni per aver organizzato questo importante appuntamento di riflessione sulla nota mondo rurale che cambia e Chiesa in Italia.Il 1492 non è soltanto l'anno della scoperta dell'America ma è anche l'anno in cui Macerata prima di ogni altra città del centro Italia si costituì per opera di una Confraternita il "Monte Frumentario".
Il Monte Frumentario è il deposito di una notevole quantità di cereali (specialmente grano e granoturco) da tenersi in serbo nei momenti di più grande bisogno. Tale scelta avveniva quasi periodicamente nei mesi che di poco precedevano la semina, quando i piccoli contadini – sempre famiglie molto numerose e di scarse risorse si erano consumati non solo tutte le quantità disponibili del raccolto dell'anno precedente, ma perfino quella quantità che doveva servire per la semina. Allora si aprivano i magazzini di quei Monti e si prestava ai coltivatori tanto grano quanto ne occorreva per tale bisogno. Il prestito era fatto al massimo favore, cioè pagando solo le spese per il magazzinaggio e la custodia. Il primo grano del nuovo raccolto doveva essere consegnato al Monte, nella stessa quantità ricevuta in prestito. Poteva accadere che o la scarsità del raccolto nuovo fosse così "paurosa" da non potersi pretendere la restituzione integrale, o che le condizioni del mutuatario si fossero tanto peggiorate che sarebbe stata crudeltà demandare la totale restituzione. In tal caso, le autorità provvedevano obbligando i proprietari terrieri ad integrare il deposito primitivo, supplendo per quella parte che non si era potuto recuperare. Così, la riserva disponibile era sempre integra e pronta al bisogno, anno per anno.
Poi, in questa splendida Regione, le Marche, per fare un altro esempio, basta pensare, ai monaci Camaldolesi che vivono nell'eremo di Fonte Avellana e al loro ruolo decisivo nella coltura e governo dei boschi, infatti il primo trattato sulla forestazione è opera di un frate camaldolese così come pure la prima carta geografica è stata disegnata da un camaldolese di Fonte Avellana, che passò gli ultimi anni della sua vita nella prigione dei Piombi a Venezia per non aver esaudito le richieste del Doge che voleva Venezia più in evidenza nella carta da lui disegnata del mondo allora conosciuto.
Questi brevi richiami alla storia della città e Regione ospitante mi servono per riannodare il filo del rapporto tra chiesa e società, tra chiesa e conflitti sociali, tra chiesa e internazionalizzazione e la capacità della chiesa di governarli.
La Cia ha recentemente lanciato la proposta di "Un nuovo patto tra agricoltura e società" attraverso il quale si ridefiniscano funzioni e missioni della nostra agricoltura, e con esso diritti e doveri reciproci.
Tutto ciò nella presunzione di un irriducibile ruolo dello spazio rurale anche, e soprattutto, nelle avanzate società moderne come la nostra.
La Cia sta, dunque, dibattendo e non solo dibattendo, ma proponendo e lottando, sullo stesso terreno su cui si sta interrogando la Chiesa cattolica.
È superfluo osservare quanto per la Cia sia decisivo che l'alto magistero della Chiesa vada svolgendo la sua ricerca su un'area di problematiche e di interrogativi del tutto analoghi alla sua.
Confortante che parametri e valori di riferimento di questa ricerca siano gli stessi che motivano e muovono la Cia.
La cosa ci dà speranza perché con così tanta condivisione lo spazio rurale e la popolazione in esso insediata non hanno che da trovare auspici positivi.
Il punto di riferimento e di partenza ineludibile è il giudizio che si pronuncia intorno al fenomeno che oggi va sotto il nome di globalizzazione.
La mia opinione, su questo tema, è che lentamente stia giungendo a compimento la visione universalistica del cristianesimo e, più propriamente, del cattolicesimo.
E' col cristianesimo che si esce fuori da ogni popolo di Dio e tutta l'umanità diventa popolo di Dio.
Se la dimensione divina è questa -come presupposto di ogni serio confronto tra religione e laicato- il giudizio sulla globalizzazione non può che essere che quello su una eccezionale occasione di grande incontro tra i popoli e di costruzione della comunità mondiale.
La globalizzazione se valorizza il territorio, le sue pecularietà, le sue tipicità, se non é soltanto omogeneizzazione agli stili di vita del nord del mondo è inclusione, perché la terra include e non esclude.
Non nascondiamoci, tuttavia, che il travaglio sarà ancora doloroso a lungo, che sussulti, conflitti e perfino guerre non mancheranno.
Importante è che qualcuno tenga in mano il filo di coesione per venire a capo di questo processo il cui esito, secondo me, non può che essere che quello annunciato della fratellanza, della giustizia e della liberazione
Questi sono i valori di riferimento della Cia ed essi imprimono il loro segno sulla sua ricerca di un rinnovato e fondamentale ruolo dello spazio rurale nell'epoca della globalizzazione.
La globalizzazione è stata finora dominata della ricerca scientifica, dalla tecnica e dal capitalismo, dalla libera concorrenza e dalla ricerca esclusiva del profitto.
Niente di male se questi sono, e lo sono, i venti di un disegno lanciato sulla terra per abbattere e spezzare via gli egoismi delle etnie e delle razze, dei singoli popoli e delle nazioni.
Tuttavia ciò ha provocato un grande disordine, grandi effetti di spaesamento e di smarrimento, ha inferto ferite profonde.
In particolare ha inferto ferite profonde allo spazio rurale, alle relazioni tra sole, stelle, firmamento e terra (basti pensare all'allargamento del buco dell'ozono e ai grandi cambiamenti climatici) come alle relazioni umane.
Nella sostanza è stata inferta una ferita profonda al concetto di comunità, sia cosmica che umana.
Dalla famiglia alla scuola alle grandi formazioni politiche, nel nostro paese in maniera drammatica, l'individualismo, privatistico ha prevalso sull'individualismo, della persona che è tale perché ha un riferimento alle altre persone in una sostanza etica comune.
Lo spazio rurale, non meno dello spazio urbano, ha subito queste ferite con la fine dell'impresa familiare e conseguente scomparsa dell'azienda appoderata, con la crisi dei borghi, con la rottura di un equilibrato rapporto città – campagna.
Addirittura oggi si mette in dubbio la stessa possibilità di uno spazio rurale antropizzato, quasi che un paese possa sopravvivere all'incuria in cui verrebbe a trovarsi l'insieme dei rapporti tra la terra ed il cielo.
La Chiesa fa bene a richiamare il forte ed insostituibile valore metaforico e, ancora più che metaforico, simbolico di termini come acqua, vino, pane, olio che accompagnano la nostra vita dalla nascita alla morte.
E', in generale, il terreno della comunità che va di nuovo dissodato ma, accanto ed insieme, quello della liberazione.
Lo spazio rurale ricordando la tradizione ma "proiettandosi nel futuro" è irrinunciabile, prezioso bene che non può mancare ad un paese ancor più se moderno.
Per questo la nuova Pac dovrà mettere al centro la ruralità, nella concezione di Delors, cioè integrazione tra agricoltura artigianato, commercio, territorio e ambiente superando la vecchia concezione della vecchia politica agricola che ha privilegiato il capitale rispetto al lavoro e ci dovrà riportare ad un rinnovato rapporto tra uomo e territorio, tra impresa e socialità, tra prodotti tipici e cultura millenaria e tra tutto questo e la internazionalizzazione di mercati.
La Cia è disposta a lavorare con la Chiesa, con le sue parrocchie nel territorio, se esse saranno capaci di "intessere rapporti diretti con tutti i suoi abitanti, cristiani e non cristiani, partecipi della vita della comunità o ai suoi margini" come recita la nota pastorale.
Si tratta però, e la nota pastorale lo dice con chiarezza, di evitare nostalgie, sogni di ritorno al passato peraltro ingiusti rispetto ai nuovi livelli di affratellamento umano che oggi sono possibili.
Si tratta di riannodare, in maniera nuova e moderna, i rapporti generazionali, sessuali, tra gli abitanti della città e quelli delle campagne, di tessere la rete dell'accoglienza per gli immigrati e per il disagio sociale.
Ciò va fatto, i tempi sono maturi, il disorientamento delle genti lo reclama, riattrezzando in ogni senso, utilizzando la scienza e la tecnica moderna, lo spazio rurale.
L'importante però è che la fede non sia solo in una Autorità, ma anche nella sua promessa, che sempre si rinnova, di una nuova terra.
L'Italia, il nostro paese, ha bisogno di questa dimensione dello spazio. Questo il senso del Nuovo patto che la Cia propone di sottoscrive tra agricoltori e società. E' per questo che essa si rivolge non ai consumatori ma ai cittadini.