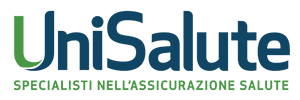04 Novembre 2003
Melissa: lotta contro il latifondo per la riforma agraria
Archivio
Condividi
Pubblichiamo la relazione che il presidente della Fondazione Abc Giuseppe Avolio ha tenuto il 30 ottobre scorso al convegno, svoltosi a Melissa (Crotone) sul tema "Giornata della terra. La lotta contro il latifondo, leva decisiva per la riforma agraria e lo sviluppo equilibrato del Paese".
I lavori di questa bella e significativa iniziativa per ricordare i tragici fatti di Melissa del 29 ottobre 1949 sono giunti al termine, secondo il programma. Consentite, ora, a me, di svolgere alcune brevi considerazioni finali. Innanzi tutto, una precisazione: uno dei "filoni" più importanti dell'impegno politico-culturale della "Fondazione ABC per il progresso dell'agricoltura", è volto a valorizzare l'azione e la lotta per la Riforma agraria: l'agricoltura e il Mezzogiorno sono considerate due leve decisive per lo sviluppo equilibrato del Paese.Si può aggiungere, inoltre, che nella fase delicata, economica e politica, che attraversa l'Italia e molti altri Paesi del mondo, appare utile e opportuna una riflessione sulla funzione decisiva di un'agricoltura moderna - fondata sull'impresa - per una prospettiva di sviluppo equilibrato – territoriale ed economico – condizione essenziale per debellare la fame e la povertà e favorire l'evoluzione sociale e civile di ogni nazione. Questa nostra iniziativa, denominata "Giornata della terra", partendo dai tragici fatti di Melissa, ha inteso mettere in risalto proprio il valore della "Riforma agraria", in Italia e nel mondo, sottolineando il nesso diretto tra l'ammodernamento dell'agricoltura e il progresso democratico della società.E credo opportuno riaffermare da questo territorio dove il sangue contadino è stato versato per affermare il diritto alla terra e alla libertà, che, se si vuole veramente debellare la fame nei paesi del terzo mondo, bisogna partire proprio dalla Riforma agraria. Nazioni come il Brasile, l'Argentina, la Colombia, il Mozambico, la Nigeria, per citarne solo alcuni, dive esistono ancora grandi proprietà private con estensioni che vanno dai 10 mila ai 100 mila ettari e anche più, intorno alle quali milioni di persone, senza terra e senza libertà, soffrono la fame endemica, devono convincersi che la vera soluzione del problema della fame comincia dalla Riforma agraria, cioè dando la terra ai contadini senza terra. Essi, in questo modo, si daranno subito da fare, lavorando e producendo il nutrimento necessario alla vita per sé e per gli altri. Voglio anche ricordare che, negli anni scorsi, ho proposto alla FIPA (Federazione Internazionale Produttori Agricoli), che è membro consultivo dell'ONU, di presentare un ordine del giorno con il quale l'Assemblea deve raccomandare a tutti gli stati membri di impostare e risolvere il problema della Riforma agraria, secondo le condizioni specifiche di ciascun paese. Le richieste di aiuti e le proposte di istituire, una sorta di "tessera del pane" da distribuire ai poveri dei paesi sottosviluppati che non producono alimenti sufficienti, si sono dimostrate inidonee a risolvere il problema. Occorre un vero rimedio: la Riforma agraria!Poi, una sottolineatura: la principale anomalia italiana – cioè il "dualismo" produttivo e territoriale – è conseguenza diretta delle insufficienze dello sviluppo capitalistico. Questi elementi si manifestano a partire dal 1860, cioè subito dopo la conquista regia. In altre parole, il capitalismo italiano – industriale e finanziario – ha avuto sempre una visione miope dei problemi dello sviluppo della nazione, declassando a questioni marginali le esigenze di crescita dell'agricoltura e di progresso delle regioni meridionali. Più precisamente, la causa principale del mancato sviluppo equilibrato dell'Italia, è da attribuire all'incapacità del capitalismo e dei partiti politici al potere, di favorire, dopo il 1860, con una visione moderna e nazionale dei problemi, il cambiamento strutturale delle basi produttive dell'economia italiana, condizione essenziale per costruire l'Italia nuova, una e indivisibile. Questi concetti, elementari e semplici, sono stati, però, trascurati per decenni ed a questa trascuratezza sono da addebitare i ritardi nello sviluppo di una nazione moderna e progredita. Poi venne il fascismo, che accentuò questi elementi negativi e, con la follia della guerra e della disfatta, condusse il Paese a una vera catastrofe. Nel secondo dopoguerra, infatti, la situazione era talmente pesante che in molte regioni del Mezzogiorno cominciarono subito a manifestarsi le prime azioni contadine per la terra e la libertà. Era, quella, un'esigenza primaria di tanti, non solo contadini, angustiati dall'insufficienza alimentare. Pane e lavoro erano, infatti, gli slogan di quel tempo.L'azione di massa per la terra, con il suo carattere non violento, e la richiesta di rispetto e applicazione della Costituzione Repubblicana - che pone un limite alla proprietà terriera e ne impone una "funzione sociale" – ebbe, perciò, subito, in quel periodo fervido ed esaltante, uno sviluppo impetuoso, investendo non solo le regioni meridionali – Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania Abruzzo e Molise – ma anche quelle centrali e del nord, Lazio, Toscana, Emilia, Veneto.Attorno alle azioni dei contadini, che andavano a "spezzare" i confini del feudo incolto con in mano la Costituzione e gli attrezzi di lavoro, con le bandiere tricolori accanto a quelle rosse e verdi dei sindacati e delle associazioni di categoria, con le donne e i figli, si determinò subito un clima di vasta solidarietà popolare. Spesso, infatti, coi contadini c'erano anche i sacerdoti, che benedivano la terra che veniva "occupata" non per recare una "offesa" ad altri, ma per "lavorarla" e farla "fruttificare" per dare il "pane" a tutti. "Cristo si è mosso da Eboli coi contadini che vogliono giustizia". Era, questo, il titolo sintomatico di un articolo da me scritto per il giornale "Il Lavoratore Comasco".Il governo del tempo, guidato da Alcide De Gasperi, inizialmente si schierò a difesa degli "agrari", e contro il popolo, che si diceva sobillato dai socialcomunisti. In questo clima si spiegano i tragici "fatti di Melissa", di Montescaglioso, di Celano, di Villa Literno. Ma, successivamente, considerando l'ampiezza del movimento e la validità delle motivazioni, si decise di appoggiare la richiesta di varare una legge di riforma fondiaria. Anzi, per fare più in fretta, il Parlamento "stralciò" alcuni capitoli da un provvedimento più ampio e complessivo e la legge varata si chiamò, perciò, "legge stralcio" di riforma agraria. Bisognava dare subito risposte concrete alle richieste provenienti dalle campagne: più tardi, si sarebbe tutto sistemato con una legge organica.La legge "stralcio" consentì, comunque, di espropriare circa 800.000 ettari, che vennero distribuiti in proprietà ai contadini in varie forme e mediante contratti per il pagamento in 30 anni. Per molti contadini si trattò di un grande evento: finalmente, avere la terra in proprietà! Ma l'affare lo fecero soprattutto gli agrari, che incassarono somme cospicue per terre che non sempre valevano molto.In linea principale, muovendo, pacificamente, contro i confini del feudo incolto per affermare il diritto alla terra e alla libertà, i contadini del Mezzogiorno diventavano protagonisti del loro proprio riscatto e padroni del proprio destino contribuendo – con ciò stesso – a liberare dall'oppressione feudale, sociale e giuridica, tutte le campagne italiane. In questo modo si aprivano nuovi varchi al progresso economico, civile e culturale non solo del Mezzogiorno, ma dell'Italia tutta. Proprio con la riforma agraria, infatti, comincia la "svolta" e l'Italia, in pochi anni, da Paese con un'economia prevalentemente agricola, e con un'agricoltura arretrata, diventa un Paese con un'economia prevalentemente industriale, che si colloca fra i 7 Paesi industriali del mondo. Anche l'agricoltura rapidamente progredisce.Per ottenere un effetto più organico di modernizzazione bisognava, però, attuare anche la riforma dei patti agrari, col superamento della colonia e della mezzadria e la liquidazione di contratti d'affitto per l'uso della terra di stampo feudale. I contratti di affitto, particolarmente esosi, prevedevano, ad esempio, l'affitto del suolo e non del soprasuolo; l'obbligo delle regalie e di "prestazioni" servili, che toccavano la dignità della persona umana dell'affittuario. In uno, per esempio, in provincia di Avellino, era previsto addirittura l'obbligo per la moglie dell'affittuario di allattare i figli del padrone. Ma la riforma dei patti agrari, allora, non si fece: altro errore! Si deve attendere il 1982 per vedere risolto questo problema con la legge N.203.L'Associazione Contadini del Mezzogiorno d'Italia, presieduta dall'On. Pietro Grifone, organizzò, a Cosenza, nel 1953, una "Convenzione antifeudale" per la riforma dei patti agrari, allo scopo di sensibilizzare tutte le forze sociali e i partiti politici, per approfondire e risolvere questo problema decisivo per il progresso nelle campagne basato sul primato dell'"impresa" coltivatrice.Le responsabilità delle classi dominanti e dei vari governi per i ritardi nella soluzione di questo problema le abbiamo più volte denunciate e non vale ripetersi. Ma, per comprendere bene le cose, dobbiamo anche dire che non sempre l'azione delle forze democratiche ebbe uno svolgimento coerente. In quel periodo, i condizionamenti nascevano soprattutto dalle scelte politiche influenzate dalla rottura internazionale dell'unità antifascista e antinazista e dalla conseguente nascita della "guerra fredda" e della "cortina di ferro". Ciò imponeva l'obbligo di "schierarsi", su tutti gli argomenti. In altre parole, in Italia, bisognava essere sempre contro il governo, che si era allineato con l'America. Un esempio calzante ci viene proprio dall'azione per la riforma agraria. Dopo aver lavorato e lottato, per la terra e la libertà, per indurre il Parlamento - a maggioranza centrista - ad elaborare e approvare una legge che consentisse l'accesso alla proprietà della terra per i contadini poveri e senza terra, le sinistre, al momento del voto finale, si schierarono contro.Posizione incomprensibile, non solo nelle campagne, che causò non poche difficoltà. Ruggero Grieco, con Rodolfo Morandi, consapevole dell'errore, fu uno di quelli che si diede da fare più degli altri per mettere, come si dice a Napoli, una "pezza a colore". Grieco riuscì, infatti, a presentare al Senato, con le firme congiunte di Giuseppe Medici e Ruggero Grieco, un ordine del giorno che impegnava il governo ad applicare , correttamente, la riforma. Ma valse a poco. Molte simpatie furono perse e non più riguadagnate.In quel tempo, giocò un ruolo negativo – come già si è detto - la politica di "schieramento", che "prescindeva" dal contenuto e dal valore delle leggi in discussione. In ogni modo, è da considerare come un grave errore non aver deciso il voto a favore della legge che, pur chiamandosi "legge stralcio" e malgrado i suoi numerosi limiti, dava la terra in proprietà ai contadini, che la chiedevano da anni. Prevalse, invece, la preoccupazione politica di non "confondersi" col governo. E si sbagliò! Tutto ciò mostra chiaramente il valore della scelta dell'autonomia dai partiti e dai governi per le organizzazioni professionali, che solo in questo modo potranno difendere, senza condizionamento alcuno, gli interessi dei coltivatori.Un'altra considerazione è opportuna. La riforma agraria liberò nuove forze produttive, che vennero utilizzate dall'industria. Si può oggi dire, anzi, con certezza, che lo sviluppo impetuoso dell'industria fu aiutato dall'agricoltura, che fornì mano d'opera abbondante e, per anni, a basso costo. Ma chi ha ripagato l'agricoltura di questo sforzo? Chi le ha riconosciuto questo merito? Centinaia di migliaia di giovani nati e cresciuti nelle campagne, senza alcun aiuto da parte delle istituzioni, sono poi, diventati operai, e ciò ha contribuito a favorire il cosiddetto "boom economico" e la modernizzazione del Paese. Ma all'agricoltura chi ha dato qualche riconoscimento? Nessuno! Essa è stata sempre considerata con sufficienza, se non, qualche volta, con disprezzo!
ooo
In questa giornata abbiamo ascoltato tante testimonianze sui fatti tragici di Melissa, sulle responsabilità gravi del governo del tempo e delle forze di polizia, che spararono su cittadini inermi intenti al lavoro: ritengo che non sia necessario aggiungere altro in proposito. Ma qualche rapida riflessione su queste "nostre" esperienze, facendo i conti con la "nostra" storia, senza abbellimenti e senza posizioni precostituite, appare opportuna.Stando alle questioni dell'agricoltura, si deve subito dire che, dopo la riforma agraria, il settore si è modernizzato; anzi, mi pare giusto precisare che l'agricoltura italiana è diventata la prima in Europa per valore aggiunto, superando la Francia; risultato ottenuto grazie alle scelte produttive nei settori dell'ortofrutta, dell'olio, del vino. E, proprio qui nel Mezzogiorno, questi settori sono all'avanguardia, soprattutto nelle zone di riforma fondiaria. La bontà del clima e le capacità dei nostri agricoltori - che subito si impegnarono in questi settori, nel metapontino, a Lamezia, a Villa Literno scegliendo soprattutto la coltivazione delle "primizie", a cominciare dalle "fragole" - ci fecero rapidamente conquistare, soprattutto per la qualità del prodotto, i principali mercati del Nord-Europa.Dobbiamo rimarcare, tuttavia, che i vari governi succedutisi alla direzione del Paese, non sempre hanno saputo individuare, per tempo, il protagonista principale dello sviluppo dell'agricoltura. E il protagonista è l'imprenditore coltivatore, per le responsabilità che gli appartengono, per le decisioni che deve prendere da solo, per le scelte produttive che deve sempre fare in rapporto al mercato. Certo, su questo punto c'è ancora molto da fare, ma si può dire che l'esame è superato.Ed ecco il tema del mercato. Abbiamo usato questo termine quasi sempre per demonizzarlo. Ed è stato un errore. Come è un errore esaltare il mercato senza regole, che conduce al darwinismo economico: il grande si mangia il piccolo. E questo non va bene. Mercato con le regole va meglio. In questo quadro dev'essere considerata la proposta della CIA di un "patto alla pari" tra produzione, trasformazione e distribuzione. Ciò, certo, non per bloccare la "competizione" e la libera concorrenza tra i vari settori produttivi – come qualcuno erroneamente ritiene - ma per affermare principi di lealtà e impedire, ad esempio, che nella vendita delle merci si trascuri di citare la provenienza dei prodotti agricoli, mentre compare solo la sigla del distributore, senza neanche citare il trasformatore. In altre parole, regole giuste per un libero mercato.Fatta questa precisazione, si può dire, senza alcuna enfasi, che il mercato – se non è alterato – è un mezzo idoneo per comprendere e soddisfare le esigenze dei consumatori, che sono i destinatari veri e ultimi del processo produttivo. E ciò non si può dimenticare, se non si vuol considerare l'agricoltura come la "Croce rossa", che deve fornire ciò che serve alla società senza che abbia nulla a pretendere in cambio, perché è il suo "dovere".Questa teoria ha creato situazioni di difficoltà, nel primo e nel secondo dopoguerra. Un esempio: si deve considerare proprio l'errata politica agricola – basata su questi principi - una delle cause maggiori delle difficoltà dell'Urss. La scelta della "collettivizzazione" forzata portò alla liquidazione dei protagonisti dell'evoluzione dell'agricoltura, cioè degli imprenditori, liberi e responsabili. Ciò causò una disaffezione crescente verso i problemi di fondo del settore agricolo, con gravi conseguenze per la modernizzazione nelle campagne. Le Monde – cioè un giornale autorevole non anticomunista - scrisse, intorno agli anni '60, che nell'Urss si era così tanto affievolito il rapporto dell'uomo con la terra da dover scrivere sulla Pravda: è tempo di seminare, è tempo di raccogliere. Una delle cause principali della dissoluzione dell'Unione Sovietica dev'essere individuata, infatti, proprio nella sua errata politica agricola. L'Urss riuscì ad andare per prima nello Spazio, ma non era in grado di assicurare il pane per i suoi abitanti. Adesso l'Urss non c'è più. A me, che pur sono stato molto critico in passato, proprio su questi punti, non mi sta bene. Giacché adesso comanda solo l'America. E neanche questo va bene, come le recenti vicende internazionali dimostrano: vedi la guerra in Iraq.Di questo ho parlato in altre occasioni e sedi, e, perciò, non mi ripeto. Naturalmente, io sono stato dirigente e sono legato a una grande organizzazione professionale agricola – laica, non ideologica, autonoma dai partiti, dai sindacati e dai governi - la CIA, che ha il compito di difendere l'agricoltura e gli agricoltori, e sento, perciò, il dovere di affermare che questi ultimi non possono essere più considerati subalterni: essi non sono e non si sentono inferiori a nessuno. Gli agricoltori intendono contribuire – alla pari con gli altri lavoratori e ceti sociali – a determinare le condizioni di uno sviluppo equilibrato, in Italia e in Europa, in modo che le scelte da compiere siano conformi anche alle loro necessità e alle loro prospettive. In ogni caso, si deve affermare che un'agricoltura moderna dev'essere fondata sulla libertà di produzione, che può svilupparsi solo in rapporto al mercato e alla responsabilità e autogoverno degli imprenditori. Da ciò nasce la giusta richiesta – da parte delle forze agricole – della "concertazione" e della istituzione del "Tavolo verde", sede sempre idonea per definire – tra governo e organizzazioni agricole – le linee di indirizzo per il progresso del settore primario, che non potrà mai essere favorito da un regime di pianificazione lineare, che porta alla scelta delle quote personali di produzione, come è avvenuto, a livello europeo, per il settore del latte. I risultati negativi sono a tutti noti.E così ho toccato un altro aspetto importante, quello dell'Unione Europea e della politica agricola comune. Il nostro futuro è l'Europa! Sbagliano coloro i quali vorrebbero farci tornare al passato, alle cinte daziarie, alle tasse sul "macinato". Nell'Europa, naturalmente, dobbiamo stare facendo valere le nostre ragioni e, per quello che riguarda l'agricoltura, affermando che occorre, sì, avere una politica giusta di apertura verso i nuovi Paesi dell'est, senza trascurare, però, le esigenze dell'agricoltura mediterranea. Più attenzione ai problemi dell'acqua, della diversificazione produttiva, del miglioramento della qualità, soprattutto, per i due aspetti principali: sanità e tipicità legata al territorio. Per anni mi sono battuto affinché tali problemi fossero affrontati con serietà e competenza, con proposte precise, come quella di costituire in ogni paese una "autorità unica per le acque", in modo da poter istituire una "autorità unica" anche a livello internazionale. Bisogna combinare l'azione per la pace e la collaborazione fra le nazioni e i popoli di quest'area mediterranea, che è stata la culla della nostra civiltà e deve tornare ad essere la cerniera che unisce, in opere di pace, il Nord e il Sud del Pianeta. Noi siamo al centro del Mediterraneo e, perciò, su questi problemi dobbiamo fare di più, operando nel Comitato Mediterraneo della FIPA e in tutte le istituzioni europee, sollecitando una seconda "Conferenza Euromediterranea sull'agricoltura", da tenere a Strasburgo, come la prima. Se si creano le condizioni di collaborazione tra i diversi Paesi di quest'area, si possono stabilire giusti accordi per concordare la forma, le quantità e i tempi, dei flussi migratori, onde evitare le tragedie continue dovute al fatto che tutto accade senza controlli e la gente si avventura sotto la spinta della disperazione.Alla Conferenza Euromediterranea di Strasburgo, voluta dalla CIA e patrocinata dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo, questi concetti, infatti, furono affermati e accolti da tutti. Ora bisogna andare avanti. Come? Sono molte le cose da fare, ma a me par giusto sceglierne tre. Ecco: valorizzare il ruolo dell'agricoltura nell'economia; esaltare la funzione dell'impresa nell'agricoltura; migliorare la posizione degli agricoltori nella società. Sono queste le tre indicazioni principali da seguire per agevolare uno sviluppo equilibrato dell'Italia, per combattere il dualismo, per costruire un futuro migliore, soprattutto nelle campagne, nel nostro Paese e in Europa.Io credo che, operando in questo modo, noi onoriamo degnamente coloro che sono caduti per la terra e per la libertà, tentando, qui da noi, di spezzare i confini del feudo incolto a Fragalà, in territorio di Melissa, nel marchesato di Crotone.E consentitemi di chiudere questa manifestazione ricordando, ancora, con memore rispetto, i nomi di Giovanni Zito, Giuseppe Nigro e Angelina Mauro, caduti per la terra, ciascuno fedele al proprio ideale, con le nobili parole pronunciate, al Senato, da Pietro Mancini, semplici e musicali, come furono allora definite: "voli a quei tumuli lacrimati l'omaggio nostro devoto e imperituro. Il sangue non è stato versato invano se esso varrà a seppellire la vecchia storia ed a foggiarne una nuova. La rinascita della Calabria sarà il loro degno monumento".
I lavori di questa bella e significativa iniziativa per ricordare i tragici fatti di Melissa del 29 ottobre 1949 sono giunti al termine, secondo il programma. Consentite, ora, a me, di svolgere alcune brevi considerazioni finali. Innanzi tutto, una precisazione: uno dei "filoni" più importanti dell'impegno politico-culturale della "Fondazione ABC per il progresso dell'agricoltura", è volto a valorizzare l'azione e la lotta per la Riforma agraria: l'agricoltura e il Mezzogiorno sono considerate due leve decisive per lo sviluppo equilibrato del Paese.Si può aggiungere, inoltre, che nella fase delicata, economica e politica, che attraversa l'Italia e molti altri Paesi del mondo, appare utile e opportuna una riflessione sulla funzione decisiva di un'agricoltura moderna - fondata sull'impresa - per una prospettiva di sviluppo equilibrato – territoriale ed economico – condizione essenziale per debellare la fame e la povertà e favorire l'evoluzione sociale e civile di ogni nazione. Questa nostra iniziativa, denominata "Giornata della terra", partendo dai tragici fatti di Melissa, ha inteso mettere in risalto proprio il valore della "Riforma agraria", in Italia e nel mondo, sottolineando il nesso diretto tra l'ammodernamento dell'agricoltura e il progresso democratico della società.E credo opportuno riaffermare da questo territorio dove il sangue contadino è stato versato per affermare il diritto alla terra e alla libertà, che, se si vuole veramente debellare la fame nei paesi del terzo mondo, bisogna partire proprio dalla Riforma agraria. Nazioni come il Brasile, l'Argentina, la Colombia, il Mozambico, la Nigeria, per citarne solo alcuni, dive esistono ancora grandi proprietà private con estensioni che vanno dai 10 mila ai 100 mila ettari e anche più, intorno alle quali milioni di persone, senza terra e senza libertà, soffrono la fame endemica, devono convincersi che la vera soluzione del problema della fame comincia dalla Riforma agraria, cioè dando la terra ai contadini senza terra. Essi, in questo modo, si daranno subito da fare, lavorando e producendo il nutrimento necessario alla vita per sé e per gli altri. Voglio anche ricordare che, negli anni scorsi, ho proposto alla FIPA (Federazione Internazionale Produttori Agricoli), che è membro consultivo dell'ONU, di presentare un ordine del giorno con il quale l'Assemblea deve raccomandare a tutti gli stati membri di impostare e risolvere il problema della Riforma agraria, secondo le condizioni specifiche di ciascun paese. Le richieste di aiuti e le proposte di istituire, una sorta di "tessera del pane" da distribuire ai poveri dei paesi sottosviluppati che non producono alimenti sufficienti, si sono dimostrate inidonee a risolvere il problema. Occorre un vero rimedio: la Riforma agraria!Poi, una sottolineatura: la principale anomalia italiana – cioè il "dualismo" produttivo e territoriale – è conseguenza diretta delle insufficienze dello sviluppo capitalistico. Questi elementi si manifestano a partire dal 1860, cioè subito dopo la conquista regia. In altre parole, il capitalismo italiano – industriale e finanziario – ha avuto sempre una visione miope dei problemi dello sviluppo della nazione, declassando a questioni marginali le esigenze di crescita dell'agricoltura e di progresso delle regioni meridionali. Più precisamente, la causa principale del mancato sviluppo equilibrato dell'Italia, è da attribuire all'incapacità del capitalismo e dei partiti politici al potere, di favorire, dopo il 1860, con una visione moderna e nazionale dei problemi, il cambiamento strutturale delle basi produttive dell'economia italiana, condizione essenziale per costruire l'Italia nuova, una e indivisibile. Questi concetti, elementari e semplici, sono stati, però, trascurati per decenni ed a questa trascuratezza sono da addebitare i ritardi nello sviluppo di una nazione moderna e progredita. Poi venne il fascismo, che accentuò questi elementi negativi e, con la follia della guerra e della disfatta, condusse il Paese a una vera catastrofe. Nel secondo dopoguerra, infatti, la situazione era talmente pesante che in molte regioni del Mezzogiorno cominciarono subito a manifestarsi le prime azioni contadine per la terra e la libertà. Era, quella, un'esigenza primaria di tanti, non solo contadini, angustiati dall'insufficienza alimentare. Pane e lavoro erano, infatti, gli slogan di quel tempo.L'azione di massa per la terra, con il suo carattere non violento, e la richiesta di rispetto e applicazione della Costituzione Repubblicana - che pone un limite alla proprietà terriera e ne impone una "funzione sociale" – ebbe, perciò, subito, in quel periodo fervido ed esaltante, uno sviluppo impetuoso, investendo non solo le regioni meridionali – Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania Abruzzo e Molise – ma anche quelle centrali e del nord, Lazio, Toscana, Emilia, Veneto.Attorno alle azioni dei contadini, che andavano a "spezzare" i confini del feudo incolto con in mano la Costituzione e gli attrezzi di lavoro, con le bandiere tricolori accanto a quelle rosse e verdi dei sindacati e delle associazioni di categoria, con le donne e i figli, si determinò subito un clima di vasta solidarietà popolare. Spesso, infatti, coi contadini c'erano anche i sacerdoti, che benedivano la terra che veniva "occupata" non per recare una "offesa" ad altri, ma per "lavorarla" e farla "fruttificare" per dare il "pane" a tutti. "Cristo si è mosso da Eboli coi contadini che vogliono giustizia". Era, questo, il titolo sintomatico di un articolo da me scritto per il giornale "Il Lavoratore Comasco".Il governo del tempo, guidato da Alcide De Gasperi, inizialmente si schierò a difesa degli "agrari", e contro il popolo, che si diceva sobillato dai socialcomunisti. In questo clima si spiegano i tragici "fatti di Melissa", di Montescaglioso, di Celano, di Villa Literno. Ma, successivamente, considerando l'ampiezza del movimento e la validità delle motivazioni, si decise di appoggiare la richiesta di varare una legge di riforma fondiaria. Anzi, per fare più in fretta, il Parlamento "stralciò" alcuni capitoli da un provvedimento più ampio e complessivo e la legge varata si chiamò, perciò, "legge stralcio" di riforma agraria. Bisognava dare subito risposte concrete alle richieste provenienti dalle campagne: più tardi, si sarebbe tutto sistemato con una legge organica.La legge "stralcio" consentì, comunque, di espropriare circa 800.000 ettari, che vennero distribuiti in proprietà ai contadini in varie forme e mediante contratti per il pagamento in 30 anni. Per molti contadini si trattò di un grande evento: finalmente, avere la terra in proprietà! Ma l'affare lo fecero soprattutto gli agrari, che incassarono somme cospicue per terre che non sempre valevano molto.In linea principale, muovendo, pacificamente, contro i confini del feudo incolto per affermare il diritto alla terra e alla libertà, i contadini del Mezzogiorno diventavano protagonisti del loro proprio riscatto e padroni del proprio destino contribuendo – con ciò stesso – a liberare dall'oppressione feudale, sociale e giuridica, tutte le campagne italiane. In questo modo si aprivano nuovi varchi al progresso economico, civile e culturale non solo del Mezzogiorno, ma dell'Italia tutta. Proprio con la riforma agraria, infatti, comincia la "svolta" e l'Italia, in pochi anni, da Paese con un'economia prevalentemente agricola, e con un'agricoltura arretrata, diventa un Paese con un'economia prevalentemente industriale, che si colloca fra i 7 Paesi industriali del mondo. Anche l'agricoltura rapidamente progredisce.Per ottenere un effetto più organico di modernizzazione bisognava, però, attuare anche la riforma dei patti agrari, col superamento della colonia e della mezzadria e la liquidazione di contratti d'affitto per l'uso della terra di stampo feudale. I contratti di affitto, particolarmente esosi, prevedevano, ad esempio, l'affitto del suolo e non del soprasuolo; l'obbligo delle regalie e di "prestazioni" servili, che toccavano la dignità della persona umana dell'affittuario. In uno, per esempio, in provincia di Avellino, era previsto addirittura l'obbligo per la moglie dell'affittuario di allattare i figli del padrone. Ma la riforma dei patti agrari, allora, non si fece: altro errore! Si deve attendere il 1982 per vedere risolto questo problema con la legge N.203.L'Associazione Contadini del Mezzogiorno d'Italia, presieduta dall'On. Pietro Grifone, organizzò, a Cosenza, nel 1953, una "Convenzione antifeudale" per la riforma dei patti agrari, allo scopo di sensibilizzare tutte le forze sociali e i partiti politici, per approfondire e risolvere questo problema decisivo per il progresso nelle campagne basato sul primato dell'"impresa" coltivatrice.Le responsabilità delle classi dominanti e dei vari governi per i ritardi nella soluzione di questo problema le abbiamo più volte denunciate e non vale ripetersi. Ma, per comprendere bene le cose, dobbiamo anche dire che non sempre l'azione delle forze democratiche ebbe uno svolgimento coerente. In quel periodo, i condizionamenti nascevano soprattutto dalle scelte politiche influenzate dalla rottura internazionale dell'unità antifascista e antinazista e dalla conseguente nascita della "guerra fredda" e della "cortina di ferro". Ciò imponeva l'obbligo di "schierarsi", su tutti gli argomenti. In altre parole, in Italia, bisognava essere sempre contro il governo, che si era allineato con l'America. Un esempio calzante ci viene proprio dall'azione per la riforma agraria. Dopo aver lavorato e lottato, per la terra e la libertà, per indurre il Parlamento - a maggioranza centrista - ad elaborare e approvare una legge che consentisse l'accesso alla proprietà della terra per i contadini poveri e senza terra, le sinistre, al momento del voto finale, si schierarono contro.Posizione incomprensibile, non solo nelle campagne, che causò non poche difficoltà. Ruggero Grieco, con Rodolfo Morandi, consapevole dell'errore, fu uno di quelli che si diede da fare più degli altri per mettere, come si dice a Napoli, una "pezza a colore". Grieco riuscì, infatti, a presentare al Senato, con le firme congiunte di Giuseppe Medici e Ruggero Grieco, un ordine del giorno che impegnava il governo ad applicare , correttamente, la riforma. Ma valse a poco. Molte simpatie furono perse e non più riguadagnate.In quel tempo, giocò un ruolo negativo – come già si è detto - la politica di "schieramento", che "prescindeva" dal contenuto e dal valore delle leggi in discussione. In ogni modo, è da considerare come un grave errore non aver deciso il voto a favore della legge che, pur chiamandosi "legge stralcio" e malgrado i suoi numerosi limiti, dava la terra in proprietà ai contadini, che la chiedevano da anni. Prevalse, invece, la preoccupazione politica di non "confondersi" col governo. E si sbagliò! Tutto ciò mostra chiaramente il valore della scelta dell'autonomia dai partiti e dai governi per le organizzazioni professionali, che solo in questo modo potranno difendere, senza condizionamento alcuno, gli interessi dei coltivatori.Un'altra considerazione è opportuna. La riforma agraria liberò nuove forze produttive, che vennero utilizzate dall'industria. Si può oggi dire, anzi, con certezza, che lo sviluppo impetuoso dell'industria fu aiutato dall'agricoltura, che fornì mano d'opera abbondante e, per anni, a basso costo. Ma chi ha ripagato l'agricoltura di questo sforzo? Chi le ha riconosciuto questo merito? Centinaia di migliaia di giovani nati e cresciuti nelle campagne, senza alcun aiuto da parte delle istituzioni, sono poi, diventati operai, e ciò ha contribuito a favorire il cosiddetto "boom economico" e la modernizzazione del Paese. Ma all'agricoltura chi ha dato qualche riconoscimento? Nessuno! Essa è stata sempre considerata con sufficienza, se non, qualche volta, con disprezzo!
ooo
In questa giornata abbiamo ascoltato tante testimonianze sui fatti tragici di Melissa, sulle responsabilità gravi del governo del tempo e delle forze di polizia, che spararono su cittadini inermi intenti al lavoro: ritengo che non sia necessario aggiungere altro in proposito. Ma qualche rapida riflessione su queste "nostre" esperienze, facendo i conti con la "nostra" storia, senza abbellimenti e senza posizioni precostituite, appare opportuna.Stando alle questioni dell'agricoltura, si deve subito dire che, dopo la riforma agraria, il settore si è modernizzato; anzi, mi pare giusto precisare che l'agricoltura italiana è diventata la prima in Europa per valore aggiunto, superando la Francia; risultato ottenuto grazie alle scelte produttive nei settori dell'ortofrutta, dell'olio, del vino. E, proprio qui nel Mezzogiorno, questi settori sono all'avanguardia, soprattutto nelle zone di riforma fondiaria. La bontà del clima e le capacità dei nostri agricoltori - che subito si impegnarono in questi settori, nel metapontino, a Lamezia, a Villa Literno scegliendo soprattutto la coltivazione delle "primizie", a cominciare dalle "fragole" - ci fecero rapidamente conquistare, soprattutto per la qualità del prodotto, i principali mercati del Nord-Europa.Dobbiamo rimarcare, tuttavia, che i vari governi succedutisi alla direzione del Paese, non sempre hanno saputo individuare, per tempo, il protagonista principale dello sviluppo dell'agricoltura. E il protagonista è l'imprenditore coltivatore, per le responsabilità che gli appartengono, per le decisioni che deve prendere da solo, per le scelte produttive che deve sempre fare in rapporto al mercato. Certo, su questo punto c'è ancora molto da fare, ma si può dire che l'esame è superato.Ed ecco il tema del mercato. Abbiamo usato questo termine quasi sempre per demonizzarlo. Ed è stato un errore. Come è un errore esaltare il mercato senza regole, che conduce al darwinismo economico: il grande si mangia il piccolo. E questo non va bene. Mercato con le regole va meglio. In questo quadro dev'essere considerata la proposta della CIA di un "patto alla pari" tra produzione, trasformazione e distribuzione. Ciò, certo, non per bloccare la "competizione" e la libera concorrenza tra i vari settori produttivi – come qualcuno erroneamente ritiene - ma per affermare principi di lealtà e impedire, ad esempio, che nella vendita delle merci si trascuri di citare la provenienza dei prodotti agricoli, mentre compare solo la sigla del distributore, senza neanche citare il trasformatore. In altre parole, regole giuste per un libero mercato.Fatta questa precisazione, si può dire, senza alcuna enfasi, che il mercato – se non è alterato – è un mezzo idoneo per comprendere e soddisfare le esigenze dei consumatori, che sono i destinatari veri e ultimi del processo produttivo. E ciò non si può dimenticare, se non si vuol considerare l'agricoltura come la "Croce rossa", che deve fornire ciò che serve alla società senza che abbia nulla a pretendere in cambio, perché è il suo "dovere".Questa teoria ha creato situazioni di difficoltà, nel primo e nel secondo dopoguerra. Un esempio: si deve considerare proprio l'errata politica agricola – basata su questi principi - una delle cause maggiori delle difficoltà dell'Urss. La scelta della "collettivizzazione" forzata portò alla liquidazione dei protagonisti dell'evoluzione dell'agricoltura, cioè degli imprenditori, liberi e responsabili. Ciò causò una disaffezione crescente verso i problemi di fondo del settore agricolo, con gravi conseguenze per la modernizzazione nelle campagne. Le Monde – cioè un giornale autorevole non anticomunista - scrisse, intorno agli anni '60, che nell'Urss si era così tanto affievolito il rapporto dell'uomo con la terra da dover scrivere sulla Pravda: è tempo di seminare, è tempo di raccogliere. Una delle cause principali della dissoluzione dell'Unione Sovietica dev'essere individuata, infatti, proprio nella sua errata politica agricola. L'Urss riuscì ad andare per prima nello Spazio, ma non era in grado di assicurare il pane per i suoi abitanti. Adesso l'Urss non c'è più. A me, che pur sono stato molto critico in passato, proprio su questi punti, non mi sta bene. Giacché adesso comanda solo l'America. E neanche questo va bene, come le recenti vicende internazionali dimostrano: vedi la guerra in Iraq.Di questo ho parlato in altre occasioni e sedi, e, perciò, non mi ripeto. Naturalmente, io sono stato dirigente e sono legato a una grande organizzazione professionale agricola – laica, non ideologica, autonoma dai partiti, dai sindacati e dai governi - la CIA, che ha il compito di difendere l'agricoltura e gli agricoltori, e sento, perciò, il dovere di affermare che questi ultimi non possono essere più considerati subalterni: essi non sono e non si sentono inferiori a nessuno. Gli agricoltori intendono contribuire – alla pari con gli altri lavoratori e ceti sociali – a determinare le condizioni di uno sviluppo equilibrato, in Italia e in Europa, in modo che le scelte da compiere siano conformi anche alle loro necessità e alle loro prospettive. In ogni caso, si deve affermare che un'agricoltura moderna dev'essere fondata sulla libertà di produzione, che può svilupparsi solo in rapporto al mercato e alla responsabilità e autogoverno degli imprenditori. Da ciò nasce la giusta richiesta – da parte delle forze agricole – della "concertazione" e della istituzione del "Tavolo verde", sede sempre idonea per definire – tra governo e organizzazioni agricole – le linee di indirizzo per il progresso del settore primario, che non potrà mai essere favorito da un regime di pianificazione lineare, che porta alla scelta delle quote personali di produzione, come è avvenuto, a livello europeo, per il settore del latte. I risultati negativi sono a tutti noti.E così ho toccato un altro aspetto importante, quello dell'Unione Europea e della politica agricola comune. Il nostro futuro è l'Europa! Sbagliano coloro i quali vorrebbero farci tornare al passato, alle cinte daziarie, alle tasse sul "macinato". Nell'Europa, naturalmente, dobbiamo stare facendo valere le nostre ragioni e, per quello che riguarda l'agricoltura, affermando che occorre, sì, avere una politica giusta di apertura verso i nuovi Paesi dell'est, senza trascurare, però, le esigenze dell'agricoltura mediterranea. Più attenzione ai problemi dell'acqua, della diversificazione produttiva, del miglioramento della qualità, soprattutto, per i due aspetti principali: sanità e tipicità legata al territorio. Per anni mi sono battuto affinché tali problemi fossero affrontati con serietà e competenza, con proposte precise, come quella di costituire in ogni paese una "autorità unica per le acque", in modo da poter istituire una "autorità unica" anche a livello internazionale. Bisogna combinare l'azione per la pace e la collaborazione fra le nazioni e i popoli di quest'area mediterranea, che è stata la culla della nostra civiltà e deve tornare ad essere la cerniera che unisce, in opere di pace, il Nord e il Sud del Pianeta. Noi siamo al centro del Mediterraneo e, perciò, su questi problemi dobbiamo fare di più, operando nel Comitato Mediterraneo della FIPA e in tutte le istituzioni europee, sollecitando una seconda "Conferenza Euromediterranea sull'agricoltura", da tenere a Strasburgo, come la prima. Se si creano le condizioni di collaborazione tra i diversi Paesi di quest'area, si possono stabilire giusti accordi per concordare la forma, le quantità e i tempi, dei flussi migratori, onde evitare le tragedie continue dovute al fatto che tutto accade senza controlli e la gente si avventura sotto la spinta della disperazione.Alla Conferenza Euromediterranea di Strasburgo, voluta dalla CIA e patrocinata dal Consiglio d'Europa e dal Parlamento europeo, questi concetti, infatti, furono affermati e accolti da tutti. Ora bisogna andare avanti. Come? Sono molte le cose da fare, ma a me par giusto sceglierne tre. Ecco: valorizzare il ruolo dell'agricoltura nell'economia; esaltare la funzione dell'impresa nell'agricoltura; migliorare la posizione degli agricoltori nella società. Sono queste le tre indicazioni principali da seguire per agevolare uno sviluppo equilibrato dell'Italia, per combattere il dualismo, per costruire un futuro migliore, soprattutto nelle campagne, nel nostro Paese e in Europa.Io credo che, operando in questo modo, noi onoriamo degnamente coloro che sono caduti per la terra e per la libertà, tentando, qui da noi, di spezzare i confini del feudo incolto a Fragalà, in territorio di Melissa, nel marchesato di Crotone.E consentitemi di chiudere questa manifestazione ricordando, ancora, con memore rispetto, i nomi di Giovanni Zito, Giuseppe Nigro e Angelina Mauro, caduti per la terra, ciascuno fedele al proprio ideale, con le nobili parole pronunciate, al Senato, da Pietro Mancini, semplici e musicali, come furono allora definite: "voli a quei tumuli lacrimati l'omaggio nostro devoto e imperituro. Il sangue non è stato versato invano se esso varrà a seppellire la vecchia storia ed a foggiarne una nuova. La rinascita della Calabria sarà il loro degno monumento".