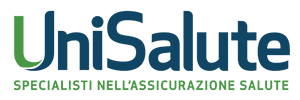20 Maggio 2005
Intervento di Carlo Liviantoni – Assessore all'agricoltura Regione Umbria
Archivio
Condividi
1. Premessa
Non è semplice, oggi, parlare di agricoltura:
a livello internazionale, per le scelte di tentato riequilibrio economico fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo e per una esasperata competitività indotta dalla globalizzazione, di prezzi e di prodotti;
a livello europeo, per una tendenza dei più a non riconoscerne ruolo e valore economico tali da giustificare e mantenere senza discussioni la spesa programmata giacché per l'agricoltura non possono valore le regole omologanti dell'intera economia;
per le tematiche a carattere orizzontale, quali l'ambiente, le risorse naturali, l'energia, la salute, che vedono riflettere sul settore aspettative ma ancor più accuse e richieste;
per un quadro istituzionale nazionale oltremodo composto nel quale, se pure la materia agricoltura sia espressamente di competenza regionale, le connessioni e le contiguità con gli altri settori, di competenza concorrente Stato-Regioni o esclusiva dello Stato, richiedono necessariamente mediazioni di interessi differenziati;
per una debole politica nazionale;
per un impianto amministrativo e normativo imposto in misura sempre maggiore per mantenerla come settore economico, ma che, invece, contribuisce a soffocarla;
per un sistema produttivo che sta dimostrando, nell'attuale crisi, notevoli carenze strutturali.
Eppure, le evoluzioni sociali ed economiche di questi ultimi anni hanno messo in evidenza che il settore agroalimentare può essere un importante fattore propulsivo di sviluppo.
2) Agricoltura ed agroalimentare come fattore di sviluppo
Il quadro di riferimento in cui si muove la nostra agricoltura è cambiato completamente negli ultimi quattro-cinque anni. Si viene, infatti, da un modello nel quale tutto, cosa, quanto, dove e come produrre, ed ancora prezzi ed integrazioni di reddito, era regolato dalla politica di settore. In quello scenario, competitività, cultura di impresa, mercato, erano termini non usati. Per molti anni la politica di settore è stata, se non l'unica, la più condizionante variabile per le scelte della maggior parte degli imprenditori agricoli. Una politica che, pur avendo garantito una valida condizione economica, è stata così pervasiva rispetto al ruolo dei decisori da lasciare pochi o nulli gradi di libertà. Tanto ai decisori singoli, quanto a quelli pubblici.
Oggi viene indicato un nuovo modo di fare agricoltura, volto a recuperare ruolo ed autonomia, e la sfida dovrebbe essere quella in cui l'agricoltura torni ad essere il perno dei nuovi modelli di sviluppo, che crescono intorno al valore distintivo del territorio. In verità, attualmente il settore vive una difficoltà particolare, di operatività (notevolissimo calo dei redditi per i prezzi di mercato, per gli elevati costi di produzione, per una inesistente redistribuzione del valore lungo la catena produttiva) e strutturale (filiere destrutturate, a bassa integrazione). L'avviata operazione di tirare fuori il settore agricolo da una certa marginalità, sembra dover segnare il passo a fronte di uno scenario economico generale che non aiuta a velocizzare il percorso innovativo che dovrebbe concretizzarsi anche in maggiori redditi per le imprese.
Si è detto che le evoluzioni sociali ed economiche di questi ultimi anni hanno messo in evidenza che il settore agroalimentare può essere un importante fattore propulsivo dello sviluppo per i territori. Non solo perché l'agricoltura con l'agroindustria è il comparto con maggiore capacità di attivazione di indotto e quindi del sistema economico nel suo complesso, ma anche perché ha mantenuto una stretta connessione con le specificità del territorio, esprimendo quindi l'abilità di seguire le dinamiche della domanda di aumentare la produttività senza determinare una disconnessione dell'attività economica dalle sue radici territoriali e culturali. Il sistema agroalimentare è, inoltre, connesso a grandi questioni sociali, da quello ambientale e quello della sicurezza alimentare.
E' per questo che rivendicare una politica agricola va ben oltre le piccole percentuali di occupati e di PIL che rappresenta. Non esiste una paese al mondo che oggi non abbia una politica agricola. Possono essere diverse le sensibilità politiche e quindi molto diversi gli approcci, le misure di intervento o le risorse complessivamente destinate, ma tutti i paesi, dai più liberisti ai più protezionisti attuano politiche a sostegno del settore agricolo.
Per noi, perseguire obiettivi di sviluppo del sistema agroalimentare vuol dire anche ricercare azioni di sviluppo rurale e quindi proporsi finalità di valorizzazione del territorio, dell'economia e della società rurale; ovvero individuare strategie anche sottese alle politiche per l'ambiente ed il territorio (tutela delle risorse idriche, naturali e paesaggistiche), per il sistema produttivo (innovazione, ricerca, competitività, fonti energetiche alternative), per il turismo, per la società (di sicurezza alimentare, di qualità della vita dei residenti), che devono trovare forme esplicite di sinergie e di integrazione di sistema. In questo quadro vanno collocate nuove ed efficaci azioni di politica agricola nazionale e regionale e la programmazione per lo sviluppo rurale, di rafforzamento delle peculiarità e potenzialità dell'agroalimentare italiano. Significa quindi:
far comprendere ai cittadini come l'agricoltura sia componente della loro quotidianità, nella fruizione del paesaggio, nell'ambiente, nella sicurezza alimentare, nella tradizione, ecc.;
porre l'interesse agricolo quale interesse positivo da privilegiare con logiche positive di sostegno anziché di vincolo all'interno delle politiche di uso del territorio;
riposizionare la componente ambientale non come peculiarità dell'agricoltura, bensì materia orizzontale o interconnessa con tutte le attività umane. Non è pensabile che oggi sono per l'agricoltura si parli di "sviluppo sostenibile" e per gli altri settori produttivi di "sviluppo";
recuperare tutte le connessioni con un sistema di ricerca e di produzione di innovazione al quale si chiede di essere sempre più orientato a sostenere lo svulippo.
Significa, infine, definire un piano di sviluppo rurale che, per percorrere validamente la strategia della competitività di sistema, dovrà porre massima attenzione alle politiche di coesione economica e sociali all'interno dei sistemi.
3) Le possibili leve per le imprese e per il territorio
Alla vigilia della predisposizione del piano regionale di sviluppo rurale vanno espressi obiettivi prevalenti e modalità di perseguimento, ovviamente conformi agli obiettivi ed alle modalità previste dalla normativa.
Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, per il periodo 2007-2013, se pure amplia consistentemente il menù delle misure possibili, ripercorre un'impostazione abbastanza consolidata e vincola la programmazione, almeno per il 50% rispetto alla destinazione delle risorse. Sembrerebbe, quindi, più facile del previsto; se non si tiene conto del fatto che la prossima programmazione andrà quasi sicuramente ad agire su una realtà diversa da quella attuale. In più, non si può trascurare il fatto che l'obiettivo competitività (ovvero il nuovo obiettivo 2) esclude alcune tipologie di interventi (es. infrastrutture) che apriranno il fronte della concorrenza sulle azioni s sui beneficiari del settore agricolo.
Generalmente, il percorso seguito per predisporre un piano è quello che vede lo svolgimento di una fase di analisi dello scenario di riferimento, quindi di diagnosi della situazione della realtà verso la quale è rivolta l'azione di programmazione, con la individuazione dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi, per arrivare infine alla definizione del documento di programmazione.
Le condizioni attuali di profondo cambiamento che sta investendo il settore agricolo ed agroalimentare impongono di aggiungere alle diverse fasi sopra indicate, quella "previsiva" di nuovo posizionamento delle imprese. Non basta sapere che si puà far leva su alcuni punti di forza quali:
il valore distintivo ed esclusivo del territorio per l'esaltazione di un contenuto di specificità ed identità dei nostri prodotti agroalimentari;
un qualificato e collaudato modello concertativi
e quindi scegliere come "parole d'ordine" identità e sistema.
Questa volta occorre anche "immaginare" il futuro.
E' probabile, infatti, che la realtà produttiva si assesti, nel medio periodo (tralasciando l'agricoltura delle piccole superfici – frutto di una tramandata affezione alla terra – importante per il mantenimento del territorio, ma a carattere quasi hobbistico) su due tipi di imprese: quella prevalentemente indirizzata alla produzione di commodities e quella che sceglie il percorso della diversificazione ed integrazione intersettoriale. Rispetto alla prima tipologia di impresa si pensa, cioè, che possa scomparire la media azienda, dando posto ad imprese di grandi dimensioni, ampliate attraverso l'uso principale dell'affitto. Tutto facilitato da una presenza "invecchiata" degli operatori agricoli che, vissuta fino ad oggi come una penalizzazione rispetto alla necessitò di una velocizzazione dell'assorbimento e/o proposizione di innovazione, diventa un fattore positivo nella misura in cui può semplificare e consentire la trasformazione in modo del tutto indolore.
Ecco, allora, l'urgenza a che il mondo imprenditoriale agricolo, insieme a tutti i soggetti interessati al settore, utilizzi questi anni in cui ancora esiste la certezza degli aiuti per mettere a punto un percorso di sviluppo innovativo basato tanto sulla razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione aziendale, quanto sulla definizione di linee strategiche in grado di considerare i cambiamenti in atto, ottenendone il massimo rendimento. Il percorso di sviluppo dovrebbe essere quello di sfruttare tutte le componenti insite nell'agricoltura.
Se quindi la direzione di riferimento è quella della multifunzionalità, diventa, in ogni caso necessario fissare le modalità operative per praticarla.
La multifunzionalità dell'agricoltura altro non è che la condizione in grado di utilizzare la varietà implicita del settore e la varietà dei sistemi territoriali nei quali l'agricoltura si propone, al fine di promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile dei territori rurali. La varietà ambientale, sociale, strutturale, culturale ed economica dei vari ambiti rurali non può essere interpretata come fattore di debolezza. Tutte queste differenza, gestite in modo appropriato, costituiscono il presupposto essenziale per determinare soluzioni efficaci dello sviluppo rurale sostenibile.
Accettare questa interpretazione, significa essere consapevoli che la multifunzionalità dell'agricoltura rappresenta una condizione multidimensionale che al suo interno ne ingloba diverse altre. Quella della sostenibilità economica ed ambientale delle attività agricole; quella della diversificazione, che esprime la forte eterogeneità produttiva, tecnologica e funzionale presente nella realtà agricola; quella della multi-settorialità, che evidenzia la capacità dell'imprenditoria agricola di affrontare attività produttive tradizionalmente non proprie; quella della integrabilità, ceh rivela l'esigenza di un inserimento attivo delle imprese all'interno di un sistema territoriale; quello di autoriproduttività, che manifesta il bisogno prioritario di qualsiasi soggetto di raggiungere il fine per il quale è attivo: quello di continuare ad essere vitale.
Se la multifunzionalità è l'obiettivo da centrare per promuovere la vitalità delle imprese agricole e lo sviluppo dei territori rurali, la competitività è il criterio al quale le unità produttive devono fare affidamento prioritario nell'organizzazione e gestione delle loro attività. Una condizione che, data la situazione strutturale delle imprese europee e dato il sempre più spinto confronto internazionale che le stesse devono affrontare, risulta molto difficile da mantenere. Difficile, ma, forse, non impossibile. La direzioni per la competitività delle imprese possono essere diverse: in ogni caso, dovranno essere innovative e , per questo, richiederanno un forte impegno di tutti i soggetti coinvolti. Ben consapevoli che se saranno solo le imprese agricole a muoversi per il raggiungimento dello sviluppo, le prospettive per le stesse imprese e per i sistemi rurali saranno tutt'altro che rosee. Non è sufficiente, cioè, il solo impegno delle imprese. Esse devono essere coadiuvate da tutto il sistema, valorizzando i fattori che sono determinanti per lo sviluppo di queste nuove attività: l'attrattività del territorio, la sua dotazione in infrastrutture ed in servizi e la capacità dell'intera comunità locale di cercare condizioni per lo sviluppo ed il mantenimento di un mercato per le nuove produzioni di beni e servizi che provengono dal settore agricolo. Questo percorso sarà determinante in modo particolare, per le aree interne, risultate marginali, nel corso del processo di direzioni di sviluppo de non si avrà la capacità di superare la scarsità di servizi alle persone ed alle imprese.
Quanto detto, non intende ridimensionare, in nessun modo, l'importanza del credito dell'efficienza nel processo di produzione. Le imprese agricole, qualsiasi attività svolgano e qualsiasi siano le funzioni che con tali attività esercitano, devono, prima di tutto, essere vitali: devono, cioè essere in grado di remunerare in termini adeguati il lavoro ed il capitale impegnati. Esse possono manche sfruttare le iniziative volte a tutelare i valori ambientali e quelli paesaggistici, a difendere il territorio e garantire il patrimonio culturale ed artistico a più diretto contatto con l'ambiente naturale, finanche a salvaguardare i valori etici che sono espressi negli ambienti sociali delle realtà rurali. Ma per sfruttare queste potenzialità è indispensabile che siano capaci di riprodursi nel tempo e, per questo, la competitività deve essere il criterio primo che anima il comportamento di qualsiasi imprenditore.
In primo luogo, quindi, va promossa una competitività delle imprese e delle economie rurali che ne garantisca, nel nuovo scenario comunitario ed internazionale, una sostenibilità delle attività che è premessa indispensabile per il mantenimento di una presenza umana necessaria al presidio ambientale e culturale del territorio.
Un particolare impegno dovrà essere profuso, accanto alle azioni tradizionali della competitività, per la formazione ed informazione degli imprenditori, per assistere le imprese nelle decisioni di breve e medio periodo, per dare risposte alle richieste di innovazioni organizzative e tecnologiche, per introdurre ed utilizzare strumenti e forme di accordi di filiera. Attraverso un rinnovato ed appropriato modo di intraprendere, infatti, le imprese agricole potranno frequentare in modo vantaggioso le strade dell'efficienza economica e della diversificazione, di processo e di prodotto.
Se la presenza di imprese efficienza costituisce un prerequisito per il mantenimento del sistema, la capacità effettiva di progresso passa attraverso altre strategie, tra le quali quella della integrazione, orizzontale e verticale. E nell'ambito delle integrazioni orizzontali, e verticali, si ritrovano tutte le azioni, diverse rispetto alle differenti tipologie, per la qualificazione dei prodotti.
In secondo luogo, si tratta di promuovere la componente di servizio al territorio ed alla popolazione delle attività agricole, forestali e venatorie. Ciò, dalla conoscenza derivante dall'analisi dei sistemi locali, della insufficienza, in alcune aree, di servizi sia relativi alla qualità della vita delle produzioni rurali sia allo sviluppo economico degli stessi territori.
In terzo luogo si tratta di promuovere l'inserimento di tutte le componenti attrattive presenti nel mondo rurale nell'ambito dei nuovi prodotti turistici o di filiera di cui, quasi sempre, rappresentano elementi di maggior interesse e successo.
Per l'Umbria, la scelta, sul versante del nuovo programma di sviluppo rurale, sarà quella di una proposizione di tutte le misure possibili, volendo offrire il massimo ventaglio di opportunità alle imprese ed al territorio.
Sarà operata nella fase di determinazione delle risorse finanziarie, e quindi con il piano finanziario, l'opzione delle priorità.
Ciò dovrà rispondere alle esigenze espresse nel percorso di concertazione effettuato con le parti sociali, di rappresentanza del mondo agricolo e dei diversi locali. La modalità di confronto saranno molteplici: istituzionali – attraverso il tavolo del patto per lo sviluppo – e non (focus group, incontri sul territorio, concorso di idee) anche per facilitare come metodo generale quello bottom-up.
Sarà comunque probabile che il confronto convalidi l'idea di agire in modo significativo sia sull' "oggetto impresa" che sull' "oggetto territorio".
Per l'impresa:
misure per l'accrescimento della competitività, tese al miglioramento dell'efficienza economica delle unità di produzione. Misure, quindi, per l'introduzione di innovazione finalizzata prevalentemente alla riduzione dei costi (sul piano delle tecniche produttive, dell'uso di macchine innovative, di economie di scala, di riorganizzazione aziendale, di risparmio energetico), per la utilizzazione di strumenti e forme commerciali innovative.
misure per la diversificazione di prodotti e di processo nelle quali possa trovare spazio una diversificazione orientata alla produzione di qualità, tipica, alla produzione di servizi (agriturismo, ippoturismo, attività faunistico-venatorie, etc.) ma anche alla produzione di prodotti con finalità energetiche
misure per l'integrazione di filiera che, oltre che migliorare l'efficienza e l'efficacia degli stadi che concorrono a portare la produzione dell'azienda agricola al consumatore finale, deve dare alla produzione agricola la possibilità di far proprio parte del valore aggiunto che si definisce lungo la filiera stessa. In questo una strategia di aggregazione supporta da un processo a latore di rinnovamento delle differenti forme associative che, però, potrebbe risultare non sufficiente per l'obiettivo della vitalità se le imprese agricole non riusciranno a riappropriarsi di una parte del valore dei prodotti alimentari finiti. Quindi misure anche per far sì che gli operatori agricoli si facciano promotori di nuove iniziative imprenditoriali, aggregate, nella distribuzione delle produzioni.
Per il territorio:
misure che aiutino a ridisegnare le opportunità del territorio, dove le zone di montagna a "bassa reputazione", ma anche le zone a tradizione produttiva intensiva, non diventino zone "sensibili" da un punto di vista economici:
misure agroambientale utilizzate non solo per recuperare e/o mantenere ambiti e connotazioni paesaggistiche, ma per favorire orientamenti produttivi verso colture energetiche ed ancor più supportate, attraverso l'inserimento di nuovi meccanismi di certificazione, se di prodotto, una forma di visibilità e valorizzazione di produzioni di qualità, se ambientale, una forma di identità territoriale.
Si è già detto che la fase di profondo cambiamento in atto del modello agricolo europeo pone l'agricoltura in uno scenario del tutto nuovo e sollecita la attivazione di modalità e strumenti idonei alle nuove esigenze, in particolare rivolti a ridurre il grado di incertezza nella operatività e capaci di offrire nuove garanzie già assicurate dal "protezionismo" della stessa politica comunitaria, per un modello di sviluppo agricolo che nei punti al potenziamento delle sue caratteristiche così da fare perno su una forte identità territoriale.
Sono conosciuti gli elementi di forte preoccupazione per la vitalità del sistema agricolo ed agroalimentare tra i quali:
dal lato dell'impresa agricola, la progressiva destrutturazione ed il sempre maggiore livello di costi produttivi;
dal lato dell'impresa agroalimentare, la limitata innovazione, la dimensione medio-piccola che impedisce investimenti sulla ricerca, la debolezza nei confronti della GDO:
che chiedono di intervenire quanto più possibile sulla creazione ed ottimizzazione delle relazioni fra i soggetti-attori delle diverse filiere e quindi del sistema produttivo, ma anche sella offerta di servizi e sulla integrazione dei soggetti che offrono servizi alle imprese. E' noto, infatti, come il tipo e l'intensità della domanda di servizi sia strettamente connessa allo stadio di sviluppo del sistema agricolo ed agroalimentare e richiede diverse modalità e forme di offerta.
Quindi, accanto alla esigenza di :
nuove relazioni fra i soggetti, compresa la GDO,
aggregazioni delle imprese,
incorporazione nei prodotti di nuovi servizi aderenti alle esigenze del consumatore.
Vi è quella della offerta dei servizi, amministrativi, finanziari, tecnici, di consulenza, formazione, orientamento commerciale. A questo concorrono numerosi soggetti, pubblici e privati, con diverso ruolo e partecipazione, e per diversi ambiti di competenza. In primis, pertanto, l'obiettivo di una maggiore competitività istituzionale con la messa a sistema dell'insieme di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica per la massima sinergia delle azioni.
1. Premessa
Non è semplice, oggi, parlare di agricoltura:
a livello internazionale, per le scelte di tentato riequilibrio economico fra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo e per una esasperata competitività indotta dalla globalizzazione, di prezzi e di prodotti;
a livello europeo, per una tendenza dei più a non riconoscerne ruolo e valore economico tali da giustificare e mantenere senza discussioni la spesa programmata giacché per l'agricoltura non possono valore le regole omologanti dell'intera economia;
per le tematiche a carattere orizzontale, quali l'ambiente, le risorse naturali, l'energia, la salute, che vedono riflettere sul settore aspettative ma ancor più accuse e richieste;
per un quadro istituzionale nazionale oltremodo composto nel quale, se pure la materia agricoltura sia espressamente di competenza regionale, le connessioni e le contiguità con gli altri settori, di competenza concorrente Stato-Regioni o esclusiva dello Stato, richiedono necessariamente mediazioni di interessi differenziati;
per una debole politica nazionale;
per un impianto amministrativo e normativo imposto in misura sempre maggiore per mantenerla come settore economico, ma che, invece, contribuisce a soffocarla;
per un sistema produttivo che sta dimostrando, nell'attuale crisi, notevoli carenze strutturali.
Eppure, le evoluzioni sociali ed economiche di questi ultimi anni hanno messo in evidenza che il settore agroalimentare può essere un importante fattore propulsivo di sviluppo.
2) Agricoltura ed agroalimentare come fattore di sviluppo
Il quadro di riferimento in cui si muove la nostra agricoltura è cambiato completamente negli ultimi quattro-cinque anni. Si viene, infatti, da un modello nel quale tutto, cosa, quanto, dove e come produrre, ed ancora prezzi ed integrazioni di reddito, era regolato dalla politica di settore. In quello scenario, competitività, cultura di impresa, mercato, erano termini non usati. Per molti anni la politica di settore è stata, se non l'unica, la più condizionante variabile per le scelte della maggior parte degli imprenditori agricoli. Una politica che, pur avendo garantito una valida condizione economica, è stata così pervasiva rispetto al ruolo dei decisori da lasciare pochi o nulli gradi di libertà. Tanto ai decisori singoli, quanto a quelli pubblici.
Oggi viene indicato un nuovo modo di fare agricoltura, volto a recuperare ruolo ed autonomia, e la sfida dovrebbe essere quella in cui l'agricoltura torni ad essere il perno dei nuovi modelli di sviluppo, che crescono intorno al valore distintivo del territorio. In verità, attualmente il settore vive una difficoltà particolare, di operatività (notevolissimo calo dei redditi per i prezzi di mercato, per gli elevati costi di produzione, per una inesistente redistribuzione del valore lungo la catena produttiva) e strutturale (filiere destrutturate, a bassa integrazione). L'avviata operazione di tirare fuori il settore agricolo da una certa marginalità, sembra dover segnare il passo a fronte di uno scenario economico generale che non aiuta a velocizzare il percorso innovativo che dovrebbe concretizzarsi anche in maggiori redditi per le imprese.
Si è detto che le evoluzioni sociali ed economiche di questi ultimi anni hanno messo in evidenza che il settore agroalimentare può essere un importante fattore propulsivo dello sviluppo per i territori. Non solo perché l'agricoltura con l'agroindustria è il comparto con maggiore capacità di attivazione di indotto e quindi del sistema economico nel suo complesso, ma anche perché ha mantenuto una stretta connessione con le specificità del territorio, esprimendo quindi l'abilità di seguire le dinamiche della domanda di aumentare la produttività senza determinare una disconnessione dell'attività economica dalle sue radici territoriali e culturali. Il sistema agroalimentare è, inoltre, connesso a grandi questioni sociali, da quello ambientale e quello della sicurezza alimentare.
E' per questo che rivendicare una politica agricola va ben oltre le piccole percentuali di occupati e di PIL che rappresenta. Non esiste una paese al mondo che oggi non abbia una politica agricola. Possono essere diverse le sensibilità politiche e quindi molto diversi gli approcci, le misure di intervento o le risorse complessivamente destinate, ma tutti i paesi, dai più liberisti ai più protezionisti attuano politiche a sostegno del settore agricolo.
Per noi, perseguire obiettivi di sviluppo del sistema agroalimentare vuol dire anche ricercare azioni di sviluppo rurale e quindi proporsi finalità di valorizzazione del territorio, dell'economia e della società rurale; ovvero individuare strategie anche sottese alle politiche per l'ambiente ed il territorio (tutela delle risorse idriche, naturali e paesaggistiche), per il sistema produttivo (innovazione, ricerca, competitività, fonti energetiche alternative), per il turismo, per la società (di sicurezza alimentare, di qualità della vita dei residenti), che devono trovare forme esplicite di sinergie e di integrazione di sistema. In questo quadro vanno collocate nuove ed efficaci azioni di politica agricola nazionale e regionale e la programmazione per lo sviluppo rurale, di rafforzamento delle peculiarità e potenzialità dell'agroalimentare italiano. Significa quindi:
far comprendere ai cittadini come l'agricoltura sia componente della loro quotidianità, nella fruizione del paesaggio, nell'ambiente, nella sicurezza alimentare, nella tradizione, ecc.;
porre l'interesse agricolo quale interesse positivo da privilegiare con logiche positive di sostegno anziché di vincolo all'interno delle politiche di uso del territorio;
riposizionare la componente ambientale non come peculiarità dell'agricoltura, bensì materia orizzontale o interconnessa con tutte le attività umane. Non è pensabile che oggi sono per l'agricoltura si parli di "sviluppo sostenibile" e per gli altri settori produttivi di "sviluppo";
recuperare tutte le connessioni con un sistema di ricerca e di produzione di innovazione al quale si chiede di essere sempre più orientato a sostenere lo svulippo.
Significa, infine, definire un piano di sviluppo rurale che, per percorrere validamente la strategia della competitività di sistema, dovrà porre massima attenzione alle politiche di coesione economica e sociali all'interno dei sistemi.
3) Le possibili leve per le imprese e per il territorio
Alla vigilia della predisposizione del piano regionale di sviluppo rurale vanno espressi obiettivi prevalenti e modalità di perseguimento, ovviamente conformi agli obiettivi ed alle modalità previste dalla normativa.
Il nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, per il periodo 2007-2013, se pure amplia consistentemente il menù delle misure possibili, ripercorre un'impostazione abbastanza consolidata e vincola la programmazione, almeno per il 50% rispetto alla destinazione delle risorse. Sembrerebbe, quindi, più facile del previsto; se non si tiene conto del fatto che la prossima programmazione andrà quasi sicuramente ad agire su una realtà diversa da quella attuale. In più, non si può trascurare il fatto che l'obiettivo competitività (ovvero il nuovo obiettivo 2) esclude alcune tipologie di interventi (es. infrastrutture) che apriranno il fronte della concorrenza sulle azioni s sui beneficiari del settore agricolo.
Generalmente, il percorso seguito per predisporre un piano è quello che vede lo svolgimento di una fase di analisi dello scenario di riferimento, quindi di diagnosi della situazione della realtà verso la quale è rivolta l'azione di programmazione, con la individuazione dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e dei rischi, per arrivare infine alla definizione del documento di programmazione.
Le condizioni attuali di profondo cambiamento che sta investendo il settore agricolo ed agroalimentare impongono di aggiungere alle diverse fasi sopra indicate, quella "previsiva" di nuovo posizionamento delle imprese. Non basta sapere che si puà far leva su alcuni punti di forza quali:
il valore distintivo ed esclusivo del territorio per l'esaltazione di un contenuto di specificità ed identità dei nostri prodotti agroalimentari;
un qualificato e collaudato modello concertativi
e quindi scegliere come "parole d'ordine" identità e sistema.
Questa volta occorre anche "immaginare" il futuro.
E' probabile, infatti, che la realtà produttiva si assesti, nel medio periodo (tralasciando l'agricoltura delle piccole superfici – frutto di una tramandata affezione alla terra – importante per il mantenimento del territorio, ma a carattere quasi hobbistico) su due tipi di imprese: quella prevalentemente indirizzata alla produzione di commodities e quella che sceglie il percorso della diversificazione ed integrazione intersettoriale. Rispetto alla prima tipologia di impresa si pensa, cioè, che possa scomparire la media azienda, dando posto ad imprese di grandi dimensioni, ampliate attraverso l'uso principale dell'affitto. Tutto facilitato da una presenza "invecchiata" degli operatori agricoli che, vissuta fino ad oggi come una penalizzazione rispetto alla necessitò di una velocizzazione dell'assorbimento e/o proposizione di innovazione, diventa un fattore positivo nella misura in cui può semplificare e consentire la trasformazione in modo del tutto indolore.
Ecco, allora, l'urgenza a che il mondo imprenditoriale agricolo, insieme a tutti i soggetti interessati al settore, utilizzi questi anni in cui ancora esiste la certezza degli aiuti per mettere a punto un percorso di sviluppo innovativo basato tanto sulla razionalizzazione dell'organizzazione e della gestione aziendale, quanto sulla definizione di linee strategiche in grado di considerare i cambiamenti in atto, ottenendone il massimo rendimento. Il percorso di sviluppo dovrebbe essere quello di sfruttare tutte le componenti insite nell'agricoltura.
Se quindi la direzione di riferimento è quella della multifunzionalità, diventa, in ogni caso necessario fissare le modalità operative per praticarla.
La multifunzionalità dell'agricoltura altro non è che la condizione in grado di utilizzare la varietà implicita del settore e la varietà dei sistemi territoriali nei quali l'agricoltura si propone, al fine di promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile dei territori rurali. La varietà ambientale, sociale, strutturale, culturale ed economica dei vari ambiti rurali non può essere interpretata come fattore di debolezza. Tutte queste differenza, gestite in modo appropriato, costituiscono il presupposto essenziale per determinare soluzioni efficaci dello sviluppo rurale sostenibile.
Accettare questa interpretazione, significa essere consapevoli che la multifunzionalità dell'agricoltura rappresenta una condizione multidimensionale che al suo interno ne ingloba diverse altre. Quella della sostenibilità economica ed ambientale delle attività agricole; quella della diversificazione, che esprime la forte eterogeneità produttiva, tecnologica e funzionale presente nella realtà agricola; quella della multi-settorialità, che evidenzia la capacità dell'imprenditoria agricola di affrontare attività produttive tradizionalmente non proprie; quella della integrabilità, ceh rivela l'esigenza di un inserimento attivo delle imprese all'interno di un sistema territoriale; quello di autoriproduttività, che manifesta il bisogno prioritario di qualsiasi soggetto di raggiungere il fine per il quale è attivo: quello di continuare ad essere vitale.
Se la multifunzionalità è l'obiettivo da centrare per promuovere la vitalità delle imprese agricole e lo sviluppo dei territori rurali, la competitività è il criterio al quale le unità produttive devono fare affidamento prioritario nell'organizzazione e gestione delle loro attività. Una condizione che, data la situazione strutturale delle imprese europee e dato il sempre più spinto confronto internazionale che le stesse devono affrontare, risulta molto difficile da mantenere. Difficile, ma, forse, non impossibile. La direzioni per la competitività delle imprese possono essere diverse: in ogni caso, dovranno essere innovative e , per questo, richiederanno un forte impegno di tutti i soggetti coinvolti. Ben consapevoli che se saranno solo le imprese agricole a muoversi per il raggiungimento dello sviluppo, le prospettive per le stesse imprese e per i sistemi rurali saranno tutt'altro che rosee. Non è sufficiente, cioè, il solo impegno delle imprese. Esse devono essere coadiuvate da tutto il sistema, valorizzando i fattori che sono determinanti per lo sviluppo di queste nuove attività: l'attrattività del territorio, la sua dotazione in infrastrutture ed in servizi e la capacità dell'intera comunità locale di cercare condizioni per lo sviluppo ed il mantenimento di un mercato per le nuove produzioni di beni e servizi che provengono dal settore agricolo. Questo percorso sarà determinante in modo particolare, per le aree interne, risultate marginali, nel corso del processo di direzioni di sviluppo de non si avrà la capacità di superare la scarsità di servizi alle persone ed alle imprese.
Quanto detto, non intende ridimensionare, in nessun modo, l'importanza del credito dell'efficienza nel processo di produzione. Le imprese agricole, qualsiasi attività svolgano e qualsiasi siano le funzioni che con tali attività esercitano, devono, prima di tutto, essere vitali: devono, cioè essere in grado di remunerare in termini adeguati il lavoro ed il capitale impegnati. Esse possono manche sfruttare le iniziative volte a tutelare i valori ambientali e quelli paesaggistici, a difendere il territorio e garantire il patrimonio culturale ed artistico a più diretto contatto con l'ambiente naturale, finanche a salvaguardare i valori etici che sono espressi negli ambienti sociali delle realtà rurali. Ma per sfruttare queste potenzialità è indispensabile che siano capaci di riprodursi nel tempo e, per questo, la competitività deve essere il criterio primo che anima il comportamento di qualsiasi imprenditore.
In primo luogo, quindi, va promossa una competitività delle imprese e delle economie rurali che ne garantisca, nel nuovo scenario comunitario ed internazionale, una sostenibilità delle attività che è premessa indispensabile per il mantenimento di una presenza umana necessaria al presidio ambientale e culturale del territorio.
Un particolare impegno dovrà essere profuso, accanto alle azioni tradizionali della competitività, per la formazione ed informazione degli imprenditori, per assistere le imprese nelle decisioni di breve e medio periodo, per dare risposte alle richieste di innovazioni organizzative e tecnologiche, per introdurre ed utilizzare strumenti e forme di accordi di filiera. Attraverso un rinnovato ed appropriato modo di intraprendere, infatti, le imprese agricole potranno frequentare in modo vantaggioso le strade dell'efficienza economica e della diversificazione, di processo e di prodotto.
Se la presenza di imprese efficienza costituisce un prerequisito per il mantenimento del sistema, la capacità effettiva di progresso passa attraverso altre strategie, tra le quali quella della integrazione, orizzontale e verticale. E nell'ambito delle integrazioni orizzontali, e verticali, si ritrovano tutte le azioni, diverse rispetto alle differenti tipologie, per la qualificazione dei prodotti.
In secondo luogo, si tratta di promuovere la componente di servizio al territorio ed alla popolazione delle attività agricole, forestali e venatorie. Ciò, dalla conoscenza derivante dall'analisi dei sistemi locali, della insufficienza, in alcune aree, di servizi sia relativi alla qualità della vita delle produzioni rurali sia allo sviluppo economico degli stessi territori.
In terzo luogo si tratta di promuovere l'inserimento di tutte le componenti attrattive presenti nel mondo rurale nell'ambito dei nuovi prodotti turistici o di filiera di cui, quasi sempre, rappresentano elementi di maggior interesse e successo.
Per l'Umbria, la scelta, sul versante del nuovo programma di sviluppo rurale, sarà quella di una proposizione di tutte le misure possibili, volendo offrire il massimo ventaglio di opportunità alle imprese ed al territorio.
Sarà operata nella fase di determinazione delle risorse finanziarie, e quindi con il piano finanziario, l'opzione delle priorità.
Ciò dovrà rispondere alle esigenze espresse nel percorso di concertazione effettuato con le parti sociali, di rappresentanza del mondo agricolo e dei diversi locali. La modalità di confronto saranno molteplici: istituzionali – attraverso il tavolo del patto per lo sviluppo – e non (focus group, incontri sul territorio, concorso di idee) anche per facilitare come metodo generale quello bottom-up.
Sarà comunque probabile che il confronto convalidi l'idea di agire in modo significativo sia sull' "oggetto impresa" che sull' "oggetto territorio".
Per l'impresa:
misure per l'accrescimento della competitività, tese al miglioramento dell'efficienza economica delle unità di produzione. Misure, quindi, per l'introduzione di innovazione finalizzata prevalentemente alla riduzione dei costi (sul piano delle tecniche produttive, dell'uso di macchine innovative, di economie di scala, di riorganizzazione aziendale, di risparmio energetico), per la utilizzazione di strumenti e forme commerciali innovative.
misure per la diversificazione di prodotti e di processo nelle quali possa trovare spazio una diversificazione orientata alla produzione di qualità, tipica, alla produzione di servizi (agriturismo, ippoturismo, attività faunistico-venatorie, etc.) ma anche alla produzione di prodotti con finalità energetiche
misure per l'integrazione di filiera che, oltre che migliorare l'efficienza e l'efficacia degli stadi che concorrono a portare la produzione dell'azienda agricola al consumatore finale, deve dare alla produzione agricola la possibilità di far proprio parte del valore aggiunto che si definisce lungo la filiera stessa. In questo una strategia di aggregazione supporta da un processo a latore di rinnovamento delle differenti forme associative che, però, potrebbe risultare non sufficiente per l'obiettivo della vitalità se le imprese agricole non riusciranno a riappropriarsi di una parte del valore dei prodotti alimentari finiti. Quindi misure anche per far sì che gli operatori agricoli si facciano promotori di nuove iniziative imprenditoriali, aggregate, nella distribuzione delle produzioni.
Per il territorio:
misure che aiutino a ridisegnare le opportunità del territorio, dove le zone di montagna a "bassa reputazione", ma anche le zone a tradizione produttiva intensiva, non diventino zone "sensibili" da un punto di vista economici:
misure agroambientale utilizzate non solo per recuperare e/o mantenere ambiti e connotazioni paesaggistiche, ma per favorire orientamenti produttivi verso colture energetiche ed ancor più supportate, attraverso l'inserimento di nuovi meccanismi di certificazione, se di prodotto, una forma di visibilità e valorizzazione di produzioni di qualità, se ambientale, una forma di identità territoriale.
Si è già detto che la fase di profondo cambiamento in atto del modello agricolo europeo pone l'agricoltura in uno scenario del tutto nuovo e sollecita la attivazione di modalità e strumenti idonei alle nuove esigenze, in particolare rivolti a ridurre il grado di incertezza nella operatività e capaci di offrire nuove garanzie già assicurate dal "protezionismo" della stessa politica comunitaria, per un modello di sviluppo agricolo che nei punti al potenziamento delle sue caratteristiche così da fare perno su una forte identità territoriale.
Sono conosciuti gli elementi di forte preoccupazione per la vitalità del sistema agricolo ed agroalimentare tra i quali:
dal lato dell'impresa agricola, la progressiva destrutturazione ed il sempre maggiore livello di costi produttivi;
dal lato dell'impresa agroalimentare, la limitata innovazione, la dimensione medio-piccola che impedisce investimenti sulla ricerca, la debolezza nei confronti della GDO:
che chiedono di intervenire quanto più possibile sulla creazione ed ottimizzazione delle relazioni fra i soggetti-attori delle diverse filiere e quindi del sistema produttivo, ma anche sella offerta di servizi e sulla integrazione dei soggetti che offrono servizi alle imprese. E' noto, infatti, come il tipo e l'intensità della domanda di servizi sia strettamente connessa allo stadio di sviluppo del sistema agricolo ed agroalimentare e richiede diverse modalità e forme di offerta.
Quindi, accanto alla esigenza di :
nuove relazioni fra i soggetti, compresa la GDO,
aggregazioni delle imprese,
incorporazione nei prodotti di nuovi servizi aderenti alle esigenze del consumatore.
Vi è quella della offerta dei servizi, amministrativi, finanziari, tecnici, di consulenza, formazione, orientamento commerciale. A questo concorrono numerosi soggetti, pubblici e privati, con diverso ruolo e partecipazione, e per diversi ambiti di competenza. In primis, pertanto, l'obiettivo di una maggiore competitività istituzionale con la messa a sistema dell'insieme di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica per la massima sinergia delle azioni.