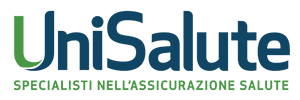17 Febbraio 2005
Il rilancio della competitività
Archivio
Condividi
SCHEDA 8: Il rilancio della competitività
Il riconoscimento economico dei crediti di carbonio al settore agricolo e forestale.
L'agricoltura, un freno all'effetto serra.
Parole chiave:
q Riconoscimento economico dei benefici apportati dagli agricoltori dalla mitigazione dell'effetto serra.
q Appropriate gestioni dei terreni agricoli e forestali potrebbero contribuire per il 25% a cogliere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
q Commercio dei crediti di carbonio realizzati dal settore agricolo e forestale
Il dibattito sui cambiamenti climatici in atto all'interno della comunità scientifica e tra i decisori politici sempre più spesso coinvolge il settore agroforestale. Ciò è legato al ruolo essenziale (riconosciuto dalla Convenzione Onu sui cambiamenti climatici e dal Protocollo di Kyoto) che le modalità di gestione dei suoli agricoli e delle foreste possono avere nelle strategie nazionali e internazionali di mitigazione dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.
Ormai numerosi studi e solide ricerche scientifiche (tra cui una recente della Iea Bioenergy, Task 38,«Sink forestali di carbonio e loro ruolo nei cambiamenti climatici globali», pubblicato anche in italiano) concludono che attraverso forme appropriate di gestione dei terreni agricoli e delle foreste esistenti la costituzione di nuove foreste e uno sviluppo delle biomasse per la produzione di energia in sostituzione delle fonti fossili (quali carbone, gas, gasolio) si potrebbe contribuire per il 25% al raggiungimento degli impegni che i Paesi si sono imposti, a seguito della firma del Protocollo di Kyoto, per mitigare i cambiamenti climatici.
Gli Accordi di Marrakech (2001) hanno esplicitamente definito le opzioni offerte dal settore agroforestale nelle strategie nazionali e internazionali di mitigazione dell'effetto serra. Oltre all'attività di costituzione di nuove piantagioni forestali e di contenimento della deforestazione (articolo 3.3 del Protocollo di Kyoto), a un Paese industrializzato è concesso di utilizzare all'interno dei propri confini le attività relative alla gestione delle foreste già esistenti al 1990 e alla rivegetazione, ma anche alla gestione della superficie agricola utilizzata e dei pascoli.
Ecco dunque che il settore agricolo è chiamato a essere parte delle politiche e delle azioni che dovranno portare al raggiungimento, tra il 2008 e il 2012, degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto.
Impegni che, a scala globale, sono del 5,2% rispetto al livello delle emissioni registrate nel 1990 e per il nostro Paese del 6,5%. Una percentuale, quest'ultima, che tenendo conto degli aumenti verificatisi dal 1990 in poi, corrisponde a circa 90 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (MtCO2eq.). Questo è quanto afferma il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la delibera approvata dal Cipe nel dicembre 2002 che definisce le strategie nazionali per tenere fede agli impegni di Kyoto.
Possibilità concrete
Il contributo che può essere fornito dall'agricoltura è legato alla:
q adozione di pratiche che favoriscono il «sequestro» di carbonio nella biomassa (nel caso delle colture arboree) e nei suoli (nel caso delle colture erbacee);
q fornitura di biomassa per finalità energetiche in sostituzione di fonti fossili di energia;
q riduzione delle emissioni nette di CO2 e di altri gas serra.
Quest'ultima opzione è abbastanza intuitiva. Nel 1990, secondo i dati presentati nel Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra allegato alla delibera Cipe, l'agricoltura italiana ha immesso in atmosfera 51,6 MtCO2 eq., tra emissioni dirette (non solo di CO2 ma anche di metano e ossido di azoto) e consumo di combustibili fossili.
A questo riguardo, va detto pure che il minor peso rivestito dall'agricoltura italiana nel quadro economico nazionale (fenomeno legato anche alla riduzione, tra il 1990 e il 2000, del 12,2% della superficie agricola utilizzata e del 14,6% del numero delle aziende agricole) contribuirà a far diminuire, senza eccessivi sforzi, la proporzione delle emissioni di gas serra generate dall'agricoltura italiana.
La seconda possibilità offerta dall'agricoltura è legata invece alla fornitura di biomassa per finalità energetiche in sostituzione delle fonti fossili di energia: dalle colture arboree e forestali, dalle colture dedicate (girasole, colza, ecc.) ai residui delle potature e delle industrie agroalimentari. Rispetto al tema dei cambiamenti climatici, e nel contesto del Protocollo di Kyoto, c'è una differenza sostanziale tra l'energia prodotta con combustibili fossili e con biomassa: bruciare i primi rilascia CO2 immobilizzata
per milioni di anni nei giacimenti biologici; viceversa, la combustione della biomassa restituisce all'atmosfera la CO2 già assorbita dalle piante e, se il ciclo produttivo e l'uso delle risorse rimangono inalterati nel tempo, non causa un aumento complessivo di CO2.
Esiste infine un'ulteriore possibilità legata alla capacità delle colture agrarie e forestali di sequestrare carbonio. Ad esempio recenti studi ( Cannel 1999; Maclaren 2000) hanno calcolato che mezzo ettaro di bosco compenserebbe approssimativamente le emissioni prodotte da un autoveicolo per il periodo di vita del conducente. Un'opzione che consente anche di andare nella direzione indicata dal Trattato dell'UE di incorporare le politiche ambientali in tutte le politiche settoriali della Comunità e dagli indirizzi di politica agricola comunitaria che perseguono lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, in grado di ridurre l'inquinamento e il degrado ambientale, di fornire servizi e beni ambientali e, al tempo stesso, mantenere una buona capacità di produzione e di reddito. In altre parole, una situazione doppiamente vincente dal punto di vista ambientale ed economico.
Concretamente gli interventi sulle superfici agricole che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono la promozione dell'agricoltura biologica, l'inerbimento dei frutteti, l'adozione di rotazioni e avvicendamenti, il sovescio, la creazione di siepi e filari, la minima o la non lavorazione e tutte quelle pratiche che comunque concorrono all'aumento della biomassa e della sostanza organica nei suoli.
Il mercato dei crediti di carbonio –Situazione attuale
I benefici che il sistema agricolo e forestale può apportare all'assorbimento di carbonio possono essere riconosciuti economicamente attraverso alcuni specifici strumenti:
q IL PIANO TRIENNIALE 2004-2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIALE MASSIMO NAZIONALE DI ASSORBIMENTO DI CARBONIO
(DELIBERA CIPE n°123 DEL 19 DICEMBRE 2002).
q IL REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATORI DI CARBONIO AGRO-FORESTALI
La delibera CIPE 123/2002 e il Piano triennale assorbimento di carbonio
A seguito dell'approvazione della delibera CIPE n°123 del 19 dicembre 2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT), di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovrà presentare al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il Piano dettagliato riferito al primo triennio 2004-2006, per la realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio, nell'ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.
Questo piano, attualmente redatto in bozza, è ancora oggetto di discussione tra i vari soggetti interessati: Regioni, MIPAF, CFS, Organizzazioni agricole. Vi sono ancora elementi di confronto non ancora del tutto risolti e si prevede ( si auspica ) che possa essere approvato in conferenza Stato Regioni nel giro di alcuni mesi.
Il piano contiene gli elementi per contabilizzare i crediti di carbonio e per assegnare i diritti di proprietà degli stessi crediti esistenti sui serbatoi di carbonio e sulle aree agroforestali, ovverosia sui suoli e sui soprassuoli.
Interventi nel settore dell'Uso del Suolo, della Variazione d'Uso del Suolo e della Selvicoltura per la generazione e certificazione dei crediti di carbonio
Le attività per l'assorbimento del carbonio sul territorio nazionale, riassunte nella tabella 6 della delibera CIPE n°123 del 19/12/2002, sono qui riportate nella tabella 1 ed hanno radice negli articoli del Protocollo di Kyoto ivi indicati.
Tabella 1 - Potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio
Assorbimento
(Mt CO2 eq.)
Investimento
(Meuro)
Costo netto
(euro/t CO2 eq.)
Art. 3.4: Gestione forestale
4,1
10
0,2
Art. 3.4: Gestione delle terre agricole e dei pascoli, e rivegetazione
0,1<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftn1" name=_ftnref1>[1]</a>
4,2
4,2
Art. 3.3: Riforestazione naturale
3,0
6,5
0,2
Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti)
1,0
6,0
0,2
Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti)
1,0
200
4,0
Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a dissesto idrogeologico<a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftn2" name=_ftnref2>[2]</a>
1,0
300
6,0
Totale
10,2
526,7
Produzione di biomasse per l'energia
Nella bozza di piano triennale oltre alle azioni riportate in tabella si fa esplicito riferimento alla produzione di biomassa a scopo energetico, tra le iniziative utili alla riduzione delle emissioni, in quanto sostitutive di combustibili fossi emettitori netti di CO2 nell'atmosfera.
Riportiamo qui di seguito ed i modo letterale il passaggio su questo argomento nella bozza di documento predisposto dal MATT:
" L'Italia considera di prioritaria importanza la realizzazione di impianti per la produzione di biomasse per l'energia.
A tal fine:
q sostiene, in accordo con quanto previsto nel Programma Nazionale Energia Rinnovabile da biomasse, le misure in tal senso disposte all'interno dei Piani di Sviluppo Rurale (Regolamento UE 1257/99) ed all'interno della Politica Agricola Comune;
q destina fino ad un massimo del 10% delle risorse disposte per i nuovi impianti di afforestazione e riforestazione previsti all'interno della delibera del CIPE n°123/2002, alla realizzazione di impianti per la produzione di biomasse per l'energia che varino l'uso del suolo da non forestato (nella classificazione del Registro) a forestato (nella classificazione del Registro), con conseguente variazione della qualità e della classe presso il catasto."
Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali
Il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali (Registro), previsto al punto 7.4 della delibera del CIPE n°123/2002, quale focal point italiano della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) svolge la funzione di struttura di raccolta di tutta la documentazione e di autorizzazione di tutte le procedure, previste nel piano a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Il Registro è lo strumento:
a) della certificazione delle quantità di carbonio sequestrato nei serbatoi dei sistemi agroforestali italiani e delle emissioni nette, dalle aree gestite agroforestali, degli altri gas serra diversi dalla CO2; e
b) del conseguente rilascio dei relativi crediti di carbonio.
Il Registro stabilisce, in conformità con le decisioni adottate dall'UNFCCC ed in accordo con ogni Linea Guida fornita dal Gruppo di esperti Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (IPCC), le metodologie da utilizzarsi per la quantificazione dei crediti di carbonio generati dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso del Suolo, Variazione di Uso del Suolo e Selvicoltura.
Il proprietario di un serbatoio o di un'area inclusa nel Registro può, in qualsiasi momento, denunciare al Registro il suo diritto di proprietà sui crediti di carbonio esigibili per il flusso netto di gas serra 1 da esso generato, se non diversamente stabilito nel presente Piano. Una volta che un diritto di proprietà è stato acceso può essere ceduto ma non estinto se non in accordo con il Registro.
In assenza di tale denuncia i crediti di carbonio esigibili per il flusso netto di gas serra generato dal serbatoio sono di proprietà del Registro.
Per ogni unità di area e per tutti i serbatoi di carbonio che su di essa insistono, la certificazione ed il rilascio dei crediti relativi ad ogni attività deve essere effettuata una sola volta, alla fine di ogni periodo d'impegno. Tale cadenza temporale della certificazione, è comunicata entro il 31 dicembre 2006 al Segretariato dell'UNFCCC per ognuna delle attività previste dagli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto.
[1] Il flusso netto di gas serra viene calcolato secondo le metodologie definite dal Registro ed è la sommatoria dei flussi negativi (rimozione di gas serra dall'atmosfera) e dei flussi positivi (emissione di gas serra in atmosfera) generati dal serbatoio o dall'area in oggetto, evitando il doppio conteggio con altro serbatoio e/o area
La certificazione, ed il conseguente rilascio, dei crediti di carbonio è diretta conseguenza della contabilizzazione delle variazioni, nei cinque anni del periodo d'impegno, del contenuto di carbonio nei serbatoi e delle emissioni nette dei gas serra diversi dalla CO2 dei sistemi agroforestali per le attività d'Uso del Suolo, di Variazione d'Uso del Suolo e Selvicolturali presenti nel Registro. Tali attività (forestali; agropastorali; rivegetazione) si differenziano in base alle metodologie di contabilizzazione dei crediti di carbonio generati.
Il Calcolo della quantità dei crediti di carbonio
La bozza di piano triennale assorbimento di carbonio prevede dei modelli di stima con punti di campionamento riferiti alle diverse azioni ( Gestione delle terre agricole e dei pascoli, Gestione Forestale, Afforestazione, Riforestazione, ecc) .
Se per le ultime tre azioni qui sopra indicate è molto probabile che il calcolo dimostri l'aumento del carbonio immagazzinato e quindi un credito di carbonio nel periodo di riferimento, nella gestione delle terre agricole il credito di carbonio potrà risultare positivo solo nei casi di adozione di pratiche agricole a basso input e condotte secondo le tecniche di gestione sostenibile dei suoli agricoli ( ad. Esempio l'agricoltura biologica, l'inerbimento delle colture arboree, la minima lavorazione dei terreni, il sovescio, l'avvicendamento colturale con specie miglioratrici della fertilità del terreno, ecc). In sostanza si tratta di pratiche agricole che consentono di aumentare la capacità del terreno di immagazzinare sostanza organica.
Ne deriva che le tecniche di coltivazione intensiva non avranno la possibilità di accedere al sistema dei crediti di carbonio perché spesso riducono la quantità di carbonio immagazzinato nel suolo piuttosto che aumentarlo.
La gestione delle terre agricole o gestione agraria è una delle attività addizionali opzionali previste dall'articolo 3.4 del Protocollo di Kyoto che possono essere utilizzate, quali pozzi di carbonio, per l'adempimento degli impegni di riduzione della quantità netta nazionale di emissioni. Ciò significa che entro il 31 dicembre 2006 il Governo Italiano dovrà comunicare al Segretariato dell'UNFCCC, se intende avvalersi della opzione e di voler utilizzare la gestione delle terre agricole come pozzo di carbonio, specificandone la tipologia.
Per l'Italia la gestione delle terre agricole rappresenta una grossa opportunità per sostenere con extra-redditi (la generazione di crediti di carbonio) la conversione dell'agricoltura verso pratiche colturali meno intensive e più sostenibili, proprie, ad esempio, delle colture biologiche tipiche.
Il valore dei crediti di carbonio
Attualmente non esiste un vero e proprio "mercato" dei crediti di carbonio ma possiamo ragionevolmente ipotizzare che verrà attivato prima del 2008 data di inizio del primo periodo di riferimento ( 2008-2012). Si possono prevedere due diverse situazioni:
- un riconoscimento economico dei crediti generati dai proprietari di un serbatoio o di un'area inclusa nel Registro da parte delle risorse nazionali attivate per conseguire gli impegni di riduzione di emissioni ;
- la possibilità di vendere i crediti generati a imprese o sistemi produttivi che per non superare le proprie quote di emissioni sono interessate a reperirle sul mercato internazionale.
Per stimare il valore di detti crediti possiamo considerare che la sanzione economica prevista per i soggetti che superano la quota di emissioni assentita, è di 40 euro per tonnellata di CO2 .
E' ipotizzabile assegnare prudenzialmente ai crediti di carbonio generati dal sistema agricolo forestale e certificati con l'iscrizione al registro, un valore tra i 10 e 20 euro tonn. di CO2. Valore che potrebbe ulteriormente aumentare se le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici diventeranno più stringenti a seguito di manifestazioni e fenomeni ancora più preoccupanti.
PROPOSTE DELLA CIA
Le richieste della CIA al Governo
Innanzi tutto è necessario sollecitare una rapida approvazione del "Piano Dettagliato per il Triennio 2004-2006 per la Realizzazione del Potenziale Massimo Nazionale di Assorbimento di Carbonio" da parte del CIPE , concertato tra il MATT e il MIPAF, e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, completando il confronto tra i vai soggetti interessati alla sua attivazione e gestione. Le organizzazioni agricole sono state consultate in una sola occasione dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) al quale hanno presentato informalmente alcune osservazioni.
Solo a seguito della approvazione del piano è possibile attivare il registro nazionale al quale i soggetti interessati possono iscriversi.
Vanno sollecitati il MATT e il MIPAF a modificare la tabella 6 della delibera CIPE n°123 del 19/12/2002, che per le attività di gestione delle terre agricole, dei pascoli e rivegetazione prevede un assorbimento di carbonio pari a 0,1 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, dato assolutamente sottostimato, tanto che nella stessa bozza di piano attualmente in discussione si ipotizza di portare il dato a 1,2 milioni di tonn di CO2. Va predisposta una analisi tecnica supportata scientificamente per stimare le effettive potenzialità delle attività di gestione dei suoli agricoli per il sequestro e l'accumulo di carbonio.
E' necessario che nella programmazione di spesa ( leggi finanziarie) dei prossimi anni siano previste le risorse per la attivazione dei piano, la gestione del registro e soprattutto il riconoscimento economico dei crediti di carbonio generati dai serbatoi Agricolo-Forestali a partire dal 2008.
Deve inoltre essere richiesto dalle organizzazioni agricole un tavolo negoziale con il Governo per la definizione del concetto CROP LAND MANAGEMENT, cioè delle attività di gestione sostenibile dei suoli agricoli che potranno rientrare tra quelle a cui vengono riconosciuti i crediti di carbonio (agricoltura biologica, tecniche a basso input, avvicendamenti, minima lavorazione dei terreni, sovescio, ecc). Il Governo deve essere sollecitato a chiedere al segretariato dell' UNFCCC entro il 31 dicenbre 2006 l'opzione di inserire la GESTIONE DELLE TERRE AGRICOLE tra le azioni previste per la riduzione delle emissioni .
Le iniziative da attivare all'interno del sistema CIA
In vista della prossima attivazione dei crediti di carbonio generati dal sistema agricolo- forestale è utile attivare alcune specifiche iniziative tra le quali:
a) organizzare occasioni interne di informazione ed approfondimento per le nostre organizzazioni territoriali per far conoscere le opportunità per le imprese agricole e forestali che il sistema dei crediti di carbonio potrà mettere in moto;
b) elaborare all'interno della CIA un sistema organizzato per:
q offrire un supporto tecnico e di consulenza alle nostre imprese che sono interessate alla iscrizione al registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali;
q costituire la banca dati dei crediti di carbonio generati dalle imprese agricole associate alla CIA, contenente tutti i dati relativi alle superfici catastali e le quote certificate dal registro nazionale, in modo da poter svolgere per loro conto la collocazione, in modo associato, dei futuri crediti di carbonio sul mercato internazionale.
<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftnref1" name=_ftn1>[1]</a> Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha rivisto la stima del potenziale di assorbimento dell'anidride carbonica nella biomassa e nel suolo attraverso la gestione dell'attività agricola (art. 3.4. del Protocollo di Kyoto) portandola da 0,1 Mt di CO2 equivalente per anno, come indicato nella delibera CIPE 123/2002, a 0,7 Mt di CO2 equivalente per anno. Ulteriori 0,4 Mt di CO2 possono essere generate se si attuano addizionali misure, esclusive del settore agricolo, per un costo aggiuntivo di 187 M€, suddivise nelle seguenti categorie:
o Gestione coltivazioni (riduzione delle perdite di carbonio / apporti di carbonio);
o Gestione dei prati e dei pascoli;
o Variazioni d'uso del suolo.
È stata valutata sotto il profilo economico l'effettiva applicabilità delle misure selezionate, evidenziando il costo associato alla capacità di assorbimento di CO2 di ogni misura agroambientale. Nel procedimento di stima si è tenuto conto che le misure producono anche benefici indiretti - ragionevolmente ipotizzabili nel caso di politiche agroambientali - ma difficilmente valutabili in termini monetari.
A partire dalle superfici agricole di riferimento e utilizzando opportuni coefficienti di conversione sono stati calcolati i potenziali di assorbimento di carbonio per ogni singola pratica agricola.
È importante sottolineare che in alcuni casi si propongono misure già sperimentate, eventualmente da rifinanziare trattandosi delle misure "agroambientali" di accompagnamento della PAC incluse successivamente nelle azioni di sviluppo rurale dei PSR; altre misure sono invece da proporre ex novo e non dispongono di risorse finanziarie.
<a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftnref2" name=_ftn2>[2]</a> Legge n. 183 del 18 maggio 1989
SCHEDA 8: Il rilancio della competitività
Il riconoscimento economico dei crediti di carbonio al settore agricolo e forestale.
L'agricoltura, un freno all'effetto serra.
Parole chiave:
q Riconoscimento economico dei benefici apportati dagli agricoltori dalla mitigazione dell'effetto serra.
q Appropriate gestioni dei terreni agricoli e forestali potrebbero contribuire per il 25% a cogliere gli obiettivi del Protocollo di Kyoto.
q Commercio dei crediti di carbonio realizzati dal settore agricolo e forestale
Il dibattito sui cambiamenti climatici in atto all'interno della comunità scientifica e tra i decisori politici sempre più spesso coinvolge il settore agroforestale. Ciò è legato al ruolo essenziale (riconosciuto dalla Convenzione Onu sui cambiamenti climatici e dal Protocollo di Kyoto) che le modalità di gestione dei suoli agricoli e delle foreste possono avere nelle strategie nazionali e internazionali di mitigazione dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.
Ormai numerosi studi e solide ricerche scientifiche (tra cui una recente della Iea Bioenergy, Task 38,«Sink forestali di carbonio e loro ruolo nei cambiamenti climatici globali», pubblicato anche in italiano) concludono che attraverso forme appropriate di gestione dei terreni agricoli e delle foreste esistenti la costituzione di nuove foreste e uno sviluppo delle biomasse per la produzione di energia in sostituzione delle fonti fossili (quali carbone, gas, gasolio) si potrebbe contribuire per il 25% al raggiungimento degli impegni che i Paesi si sono imposti, a seguito della firma del Protocollo di Kyoto, per mitigare i cambiamenti climatici.
Gli Accordi di Marrakech (2001) hanno esplicitamente definito le opzioni offerte dal settore agroforestale nelle strategie nazionali e internazionali di mitigazione dell'effetto serra. Oltre all'attività di costituzione di nuove piantagioni forestali e di contenimento della deforestazione (articolo 3.3 del Protocollo di Kyoto), a un Paese industrializzato è concesso di utilizzare all'interno dei propri confini le attività relative alla gestione delle foreste già esistenti al 1990 e alla rivegetazione, ma anche alla gestione della superficie agricola utilizzata e dei pascoli.
Ecco dunque che il settore agricolo è chiamato a essere parte delle politiche e delle azioni che dovranno portare al raggiungimento, tra il 2008 e il 2012, degli impegni di riduzione delle emissioni di gas serra previsti dal Protocollo di Kyoto.
Impegni che, a scala globale, sono del 5,2% rispetto al livello delle emissioni registrate nel 1990 e per il nostro Paese del 6,5%. Una percentuale, quest'ultima, che tenendo conto degli aumenti verificatisi dal 1990 in poi, corrisponde a circa 90 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti (MtCO2eq.). Questo è quanto afferma il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la delibera approvata dal Cipe nel dicembre 2002 che definisce le strategie nazionali per tenere fede agli impegni di Kyoto.
Possibilità concrete
Il contributo che può essere fornito dall'agricoltura è legato alla:
q adozione di pratiche che favoriscono il «sequestro» di carbonio nella biomassa (nel caso delle colture arboree) e nei suoli (nel caso delle colture erbacee);
q fornitura di biomassa per finalità energetiche in sostituzione di fonti fossili di energia;
q riduzione delle emissioni nette di CO2 e di altri gas serra.
Quest'ultima opzione è abbastanza intuitiva. Nel 1990, secondo i dati presentati nel Piano nazionale di riduzione delle emissioni di gas serra allegato alla delibera Cipe, l'agricoltura italiana ha immesso in atmosfera 51,6 MtCO2 eq., tra emissioni dirette (non solo di CO2 ma anche di metano e ossido di azoto) e consumo di combustibili fossili.
A questo riguardo, va detto pure che il minor peso rivestito dall'agricoltura italiana nel quadro economico nazionale (fenomeno legato anche alla riduzione, tra il 1990 e il 2000, del 12,2% della superficie agricola utilizzata e del 14,6% del numero delle aziende agricole) contribuirà a far diminuire, senza eccessivi sforzi, la proporzione delle emissioni di gas serra generate dall'agricoltura italiana.
La seconda possibilità offerta dall'agricoltura è legata invece alla fornitura di biomassa per finalità energetiche in sostituzione delle fonti fossili di energia: dalle colture arboree e forestali, dalle colture dedicate (girasole, colza, ecc.) ai residui delle potature e delle industrie agroalimentari. Rispetto al tema dei cambiamenti climatici, e nel contesto del Protocollo di Kyoto, c'è una differenza sostanziale tra l'energia prodotta con combustibili fossili e con biomassa: bruciare i primi rilascia CO2 immobilizzata
per milioni di anni nei giacimenti biologici; viceversa, la combustione della biomassa restituisce all'atmosfera la CO2 già assorbita dalle piante e, se il ciclo produttivo e l'uso delle risorse rimangono inalterati nel tempo, non causa un aumento complessivo di CO2.
Esiste infine un'ulteriore possibilità legata alla capacità delle colture agrarie e forestali di sequestrare carbonio. Ad esempio recenti studi ( Cannel 1999; Maclaren 2000) hanno calcolato che mezzo ettaro di bosco compenserebbe approssimativamente le emissioni prodotte da un autoveicolo per il periodo di vita del conducente. Un'opzione che consente anche di andare nella direzione indicata dal Trattato dell'UE di incorporare le politiche ambientali in tutte le politiche settoriali della Comunità e dagli indirizzi di politica agricola comunitaria che perseguono lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile, in grado di ridurre l'inquinamento e il degrado ambientale, di fornire servizi e beni ambientali e, al tempo stesso, mantenere una buona capacità di produzione e di reddito. In altre parole, una situazione doppiamente vincente dal punto di vista ambientale ed economico.
Concretamente gli interventi sulle superfici agricole che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici sono la promozione dell'agricoltura biologica, l'inerbimento dei frutteti, l'adozione di rotazioni e avvicendamenti, il sovescio, la creazione di siepi e filari, la minima o la non lavorazione e tutte quelle pratiche che comunque concorrono all'aumento della biomassa e della sostanza organica nei suoli.
Il mercato dei crediti di carbonio –Situazione attuale
I benefici che il sistema agricolo e forestale può apportare all'assorbimento di carbonio possono essere riconosciuti economicamente attraverso alcuni specifici strumenti:
q IL PIANO TRIENNIALE 2004-2006 PER LA REALIZZAZIONE DEL POTENZIALE MASSIMO NAZIONALE DI ASSORBIMENTO DI CARBONIO
(DELIBERA CIPE n°123 DEL 19 DICEMBRE 2002).
q IL REGISTRO NAZIONALE DEI SERBATORI DI CARBONIO AGRO-FORESTALI
La delibera CIPE 123/2002 e il Piano triennale assorbimento di carbonio
A seguito dell'approvazione della delibera CIPE n°123 del 19 dicembre 2002, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT), di concerto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (MIPAF) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dovrà presentare al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) il Piano dettagliato riferito al primo triennio 2004-2006, per la realizzazione del potenziale massimo nazionale di assorbimento di carbonio, nell'ambito delle risorse pubbliche destinate allo scopo.
Questo piano, attualmente redatto in bozza, è ancora oggetto di discussione tra i vari soggetti interessati: Regioni, MIPAF, CFS, Organizzazioni agricole. Vi sono ancora elementi di confronto non ancora del tutto risolti e si prevede ( si auspica ) che possa essere approvato in conferenza Stato Regioni nel giro di alcuni mesi.
Il piano contiene gli elementi per contabilizzare i crediti di carbonio e per assegnare i diritti di proprietà degli stessi crediti esistenti sui serbatoi di carbonio e sulle aree agroforestali, ovverosia sui suoli e sui soprassuoli.
Interventi nel settore dell'Uso del Suolo, della Variazione d'Uso del Suolo e della Selvicoltura per la generazione e certificazione dei crediti di carbonio
Le attività per l'assorbimento del carbonio sul territorio nazionale, riassunte nella tabella 6 della delibera CIPE n°123 del 19/12/2002, sono qui riportate nella tabella 1 ed hanno radice negli articoli del Protocollo di Kyoto ivi indicati.
Tabella 1 - Potenziale nazionale massimo di assorbimento di carbonio
Assorbimento
(Mt CO2 eq.)
Investimento
(Meuro)
Costo netto
(euro/t CO2 eq.)
Art. 3.4: Gestione forestale
4,1
10
0,2
Art. 3.4: Gestione delle terre agricole e dei pascoli, e rivegetazione
0,1<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftn1" name=_ftnref1>[1]</a>
4,2
4,2
Art. 3.3: Riforestazione naturale
3,0
6,5
0,2
Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (vecchi impianti)
1,0
6,0
0,2
Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti)
1,0
200
4,0
Art. 3.3: Afforestazione e Riforestazione (nuovi impianti) su aree soggette a dissesto idrogeologico<a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftn2" name=_ftnref2>[2]</a>
1,0
300
6,0
Totale
10,2
526,7
Produzione di biomasse per l'energia
Nella bozza di piano triennale oltre alle azioni riportate in tabella si fa esplicito riferimento alla produzione di biomassa a scopo energetico, tra le iniziative utili alla riduzione delle emissioni, in quanto sostitutive di combustibili fossi emettitori netti di CO2 nell'atmosfera.
Riportiamo qui di seguito ed i modo letterale il passaggio su questo argomento nella bozza di documento predisposto dal MATT:
" L'Italia considera di prioritaria importanza la realizzazione di impianti per la produzione di biomasse per l'energia.
A tal fine:
q sostiene, in accordo con quanto previsto nel Programma Nazionale Energia Rinnovabile da biomasse, le misure in tal senso disposte all'interno dei Piani di Sviluppo Rurale (Regolamento UE 1257/99) ed all'interno della Politica Agricola Comune;
q destina fino ad un massimo del 10% delle risorse disposte per i nuovi impianti di afforestazione e riforestazione previsti all'interno della delibera del CIPE n°123/2002, alla realizzazione di impianti per la produzione di biomasse per l'energia che varino l'uso del suolo da non forestato (nella classificazione del Registro) a forestato (nella classificazione del Registro), con conseguente variazione della qualità e della classe presso il catasto."
Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali
Il Registro Nazionale dei Serbatoi di carbonio agro-forestali (Registro), previsto al punto 7.4 della delibera del CIPE n°123/2002, quale focal point italiano della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC) svolge la funzione di struttura di raccolta di tutta la documentazione e di autorizzazione di tutte le procedure, previste nel piano a carico del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
Il Registro è lo strumento:
a) della certificazione delle quantità di carbonio sequestrato nei serbatoi dei sistemi agroforestali italiani e delle emissioni nette, dalle aree gestite agroforestali, degli altri gas serra diversi dalla CO2; e
b) del conseguente rilascio dei relativi crediti di carbonio.
Il Registro stabilisce, in conformità con le decisioni adottate dall'UNFCCC ed in accordo con ogni Linea Guida fornita dal Gruppo di esperti Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici delle Nazioni Unite (IPCC), le metodologie da utilizzarsi per la quantificazione dei crediti di carbonio generati dalla superficie nazionale, in conseguenza di attività di Uso del Suolo, Variazione di Uso del Suolo e Selvicoltura.
Il proprietario di un serbatoio o di un'area inclusa nel Registro può, in qualsiasi momento, denunciare al Registro il suo diritto di proprietà sui crediti di carbonio esigibili per il flusso netto di gas serra 1 da esso generato, se non diversamente stabilito nel presente Piano. Una volta che un diritto di proprietà è stato acceso può essere ceduto ma non estinto se non in accordo con il Registro.
In assenza di tale denuncia i crediti di carbonio esigibili per il flusso netto di gas serra generato dal serbatoio sono di proprietà del Registro.
Per ogni unità di area e per tutti i serbatoi di carbonio che su di essa insistono, la certificazione ed il rilascio dei crediti relativi ad ogni attività deve essere effettuata una sola volta, alla fine di ogni periodo d'impegno. Tale cadenza temporale della certificazione, è comunicata entro il 31 dicembre 2006 al Segretariato dell'UNFCCC per ognuna delle attività previste dagli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto.
[1] Il flusso netto di gas serra viene calcolato secondo le metodologie definite dal Registro ed è la sommatoria dei flussi negativi (rimozione di gas serra dall'atmosfera) e dei flussi positivi (emissione di gas serra in atmosfera) generati dal serbatoio o dall'area in oggetto, evitando il doppio conteggio con altro serbatoio e/o area
La certificazione, ed il conseguente rilascio, dei crediti di carbonio è diretta conseguenza della contabilizzazione delle variazioni, nei cinque anni del periodo d'impegno, del contenuto di carbonio nei serbatoi e delle emissioni nette dei gas serra diversi dalla CO2 dei sistemi agroforestali per le attività d'Uso del Suolo, di Variazione d'Uso del Suolo e Selvicolturali presenti nel Registro. Tali attività (forestali; agropastorali; rivegetazione) si differenziano in base alle metodologie di contabilizzazione dei crediti di carbonio generati.
Il Calcolo della quantità dei crediti di carbonio
La bozza di piano triennale assorbimento di carbonio prevede dei modelli di stima con punti di campionamento riferiti alle diverse azioni ( Gestione delle terre agricole e dei pascoli, Gestione Forestale, Afforestazione, Riforestazione, ecc) .
Se per le ultime tre azioni qui sopra indicate è molto probabile che il calcolo dimostri l'aumento del carbonio immagazzinato e quindi un credito di carbonio nel periodo di riferimento, nella gestione delle terre agricole il credito di carbonio potrà risultare positivo solo nei casi di adozione di pratiche agricole a basso input e condotte secondo le tecniche di gestione sostenibile dei suoli agricoli ( ad. Esempio l'agricoltura biologica, l'inerbimento delle colture arboree, la minima lavorazione dei terreni, il sovescio, l'avvicendamento colturale con specie miglioratrici della fertilità del terreno, ecc). In sostanza si tratta di pratiche agricole che consentono di aumentare la capacità del terreno di immagazzinare sostanza organica.
Ne deriva che le tecniche di coltivazione intensiva non avranno la possibilità di accedere al sistema dei crediti di carbonio perché spesso riducono la quantità di carbonio immagazzinato nel suolo piuttosto che aumentarlo.
La gestione delle terre agricole o gestione agraria è una delle attività addizionali opzionali previste dall'articolo 3.4 del Protocollo di Kyoto che possono essere utilizzate, quali pozzi di carbonio, per l'adempimento degli impegni di riduzione della quantità netta nazionale di emissioni. Ciò significa che entro il 31 dicembre 2006 il Governo Italiano dovrà comunicare al Segretariato dell'UNFCCC, se intende avvalersi della opzione e di voler utilizzare la gestione delle terre agricole come pozzo di carbonio, specificandone la tipologia.
Per l'Italia la gestione delle terre agricole rappresenta una grossa opportunità per sostenere con extra-redditi (la generazione di crediti di carbonio) la conversione dell'agricoltura verso pratiche colturali meno intensive e più sostenibili, proprie, ad esempio, delle colture biologiche tipiche.
Il valore dei crediti di carbonio
Attualmente non esiste un vero e proprio "mercato" dei crediti di carbonio ma possiamo ragionevolmente ipotizzare che verrà attivato prima del 2008 data di inizio del primo periodo di riferimento ( 2008-2012). Si possono prevedere due diverse situazioni:
- un riconoscimento economico dei crediti generati dai proprietari di un serbatoio o di un'area inclusa nel Registro da parte delle risorse nazionali attivate per conseguire gli impegni di riduzione di emissioni ;
- la possibilità di vendere i crediti generati a imprese o sistemi produttivi che per non superare le proprie quote di emissioni sono interessate a reperirle sul mercato internazionale.
Per stimare il valore di detti crediti possiamo considerare che la sanzione economica prevista per i soggetti che superano la quota di emissioni assentita, è di 40 euro per tonnellata di CO2 .
E' ipotizzabile assegnare prudenzialmente ai crediti di carbonio generati dal sistema agricolo forestale e certificati con l'iscrizione al registro, un valore tra i 10 e 20 euro tonn. di CO2. Valore che potrebbe ulteriormente aumentare se le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici diventeranno più stringenti a seguito di manifestazioni e fenomeni ancora più preoccupanti.
PROPOSTE DELLA CIA
Le richieste della CIA al Governo
Innanzi tutto è necessario sollecitare una rapida approvazione del "Piano Dettagliato per il Triennio 2004-2006 per la Realizzazione del Potenziale Massimo Nazionale di Assorbimento di Carbonio" da parte del CIPE , concertato tra il MATT e il MIPAF, e d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, completando il confronto tra i vai soggetti interessati alla sua attivazione e gestione. Le organizzazioni agricole sono state consultate in una sola occasione dal Corpo Forestale dello Stato (CFS) al quale hanno presentato informalmente alcune osservazioni.
Solo a seguito della approvazione del piano è possibile attivare il registro nazionale al quale i soggetti interessati possono iscriversi.
Vanno sollecitati il MATT e il MIPAF a modificare la tabella 6 della delibera CIPE n°123 del 19/12/2002, che per le attività di gestione delle terre agricole, dei pascoli e rivegetazione prevede un assorbimento di carbonio pari a 0,1 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, dato assolutamente sottostimato, tanto che nella stessa bozza di piano attualmente in discussione si ipotizza di portare il dato a 1,2 milioni di tonn di CO2. Va predisposta una analisi tecnica supportata scientificamente per stimare le effettive potenzialità delle attività di gestione dei suoli agricoli per il sequestro e l'accumulo di carbonio.
E' necessario che nella programmazione di spesa ( leggi finanziarie) dei prossimi anni siano previste le risorse per la attivazione dei piano, la gestione del registro e soprattutto il riconoscimento economico dei crediti di carbonio generati dai serbatoi Agricolo-Forestali a partire dal 2008.
Deve inoltre essere richiesto dalle organizzazioni agricole un tavolo negoziale con il Governo per la definizione del concetto CROP LAND MANAGEMENT, cioè delle attività di gestione sostenibile dei suoli agricoli che potranno rientrare tra quelle a cui vengono riconosciuti i crediti di carbonio (agricoltura biologica, tecniche a basso input, avvicendamenti, minima lavorazione dei terreni, sovescio, ecc). Il Governo deve essere sollecitato a chiedere al segretariato dell' UNFCCC entro il 31 dicenbre 2006 l'opzione di inserire la GESTIONE DELLE TERRE AGRICOLE tra le azioni previste per la riduzione delle emissioni .
Le iniziative da attivare all'interno del sistema CIA
In vista della prossima attivazione dei crediti di carbonio generati dal sistema agricolo- forestale è utile attivare alcune specifiche iniziative tra le quali:
a) organizzare occasioni interne di informazione ed approfondimento per le nostre organizzazioni territoriali per far conoscere le opportunità per le imprese agricole e forestali che il sistema dei crediti di carbonio potrà mettere in moto;
b) elaborare all'interno della CIA un sistema organizzato per:
q offrire un supporto tecnico e di consulenza alle nostre imprese che sono interessate alla iscrizione al registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali;
q costituire la banca dati dei crediti di carbonio generati dalle imprese agricole associate alla CIA, contenente tutti i dati relativi alle superfici catastali e le quote certificate dal registro nazionale, in modo da poter svolgere per loro conto la collocazione, in modo associato, dei futuri crediti di carbonio sul mercato internazionale.
<a title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftnref1" name=_ftn1>[1]</a> Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha rivisto la stima del potenziale di assorbimento dell'anidride carbonica nella biomassa e nel suolo attraverso la gestione dell'attività agricola (art. 3.4. del Protocollo di Kyoto) portandola da 0,1 Mt di CO2 equivalente per anno, come indicato nella delibera CIPE 123/2002, a 0,7 Mt di CO2 equivalente per anno. Ulteriori 0,4 Mt di CO2 possono essere generate se si attuano addizionali misure, esclusive del settore agricolo, per un costo aggiuntivo di 187 M€, suddivise nelle seguenti categorie:
o Gestione coltivazioni (riduzione delle perdite di carbonio / apporti di carbonio);
o Gestione dei prati e dei pascoli;
o Variazioni d'uso del suolo.
È stata valutata sotto il profilo economico l'effettiva applicabilità delle misure selezionate, evidenziando il costo associato alla capacità di assorbimento di CO2 di ogni misura agroambientale. Nel procedimento di stima si è tenuto conto che le misure producono anche benefici indiretti - ragionevolmente ipotizzabili nel caso di politiche agroambientali - ma difficilmente valutabili in termini monetari.
A partire dalle superfici agricole di riferimento e utilizzando opportuni coefficienti di conversione sono stati calcolati i potenziali di assorbimento di carbonio per ogni singola pratica agricola.
È importante sottolineare che in alcuni casi si propongono misure già sperimentate, eventualmente da rifinanziare trattandosi delle misure "agroambientali" di accompagnamento della PAC incluse successivamente nelle azioni di sviluppo rurale dei PSR; altre misure sono invece da proporre ex novo e non dispongono di risorse finanziarie.
<a title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://www.cia.it/cia/age/#_ftnref2" name=_ftn2>[2]</a> Legge n. 183 del 18 maggio 1989